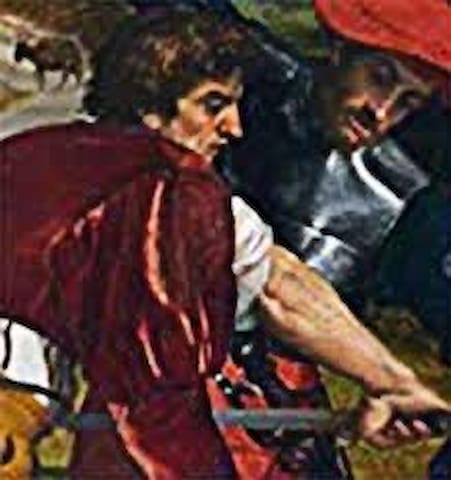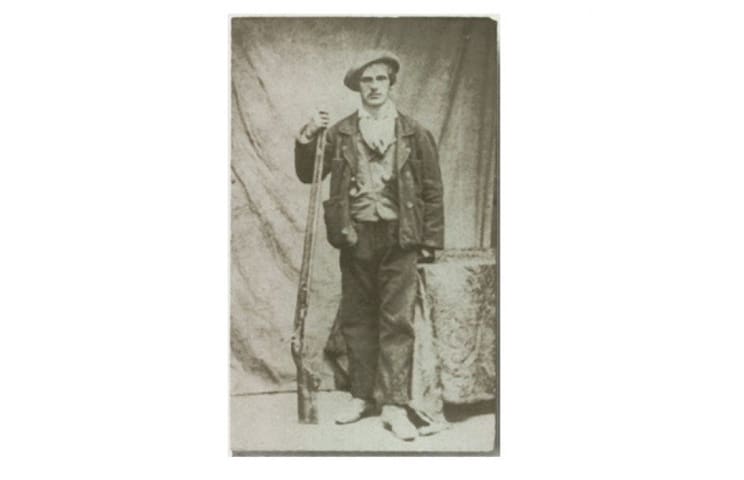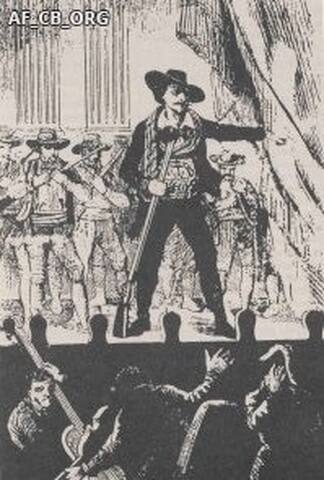Il brigantaggio in Romagna
La presenza di briganti e banditi nel territorio romagnolo è attestata da documenti storici almeno fin dal XVI sec..
La "messa al bando" (da cui il termine "banditi") era attribuita a "fuoriusciti" politici, nobili o cittadini estradati a seguito delle lotte fra fazioni municipali. Questi continuavano a contrastare l'accentramento del potere locale con azioni militari vere e proprie assoldando tutta una congrega di dubbie figure fra cui ladroni, grassatori, masnadieri ovvero soldati disoccupati, delinquenti comuni colpiti dal bando in contumacia per crimini commessi contro il patrimonio o contro la persona.
Il fenomeno è testimoniato da documenti conservati nell'archivio storico di Terra del Sole che conserva circa 1.000 "filze" di atti civili e criminali che dalla fine del 400 fino all'Unità d'Italia registrano il fenomeno del banditismo in questi territori.
Storia del fenomeno
Il caso più emblematico è quello di Alfonso Piccolomini, duca di Montemarciano che, alla fine del Cinquecento, mise in atto azioni di brigantaggio nei territori al confine fra la Romagna toscana e quella pontificia. La banda armata del Piccolomini era composta da malfattori toscani, romagnoli e marchigiani. Sia il Granducato di Toscano che lo Stato Pontificio gli diedero la caccia per un lungo periodo impiegando ingenti risorse di uomini e mezzi. Il 16/3/1591 venne impiccato.
Sottoposta allo Stato Pontificio, con parti del territorio controllate da altre entità confinanti (Granducato di Toscana, legazioni di Bologna e Ferrara, oltre a territori in carico alle odierne Marche) la Romagna vede scorrere un flusso incessante di merci di contrabbando che alimentano la piccola criminalità locale.
Il salto di qualità, da contrabbandiere a brigante, non è scontato, ma la rete di potenziali manutengoli legata al traffico illegale, favorita dalla povertà endemica del territorio, è un fattore che può contribuire al proliferare di bande di briganti, particolarmente attive nei periodi di crisi delle istituzioni in Romagna. Bande che possono sfruttare le zone ancora difficili da controllare, come paludi della Bassa Romagna e territori montani e di confine tra entità territoriali con diverse legislazioni, dove i briganti possono fuggire in caso di inseguimenti e rastrellamenti.
Ottocento
Nell'Ottocento i dati sui briganti sono molteplici e contribuiscono a ricostruire un quadro abbastanza preciso, a partire dall'età Napoleonica, fino alla definitiva estirpazione del fenomeno con l'Unità d'Italia. Alcuni dei briganti più famosi in Romagna a partire dalla fine del Settecento sono Sebastiano Bora detto “Puiena”. Attivo tra la Presidenza d'Urbino e la Legazione di Romagna e Tommaso Rinaldini da Montemaggiore (Urbino) detto Mason d'la Blona (Tommaso dell'Isabellona), che succede a “Puiena”, insistendo grosso modo sul suo territorio.
Numerosissimi anche i briganti attivi durante i primi momenti dell'invasione napoleonica.
La situazione si stabilizza nel 1802, ma dal 1805 il fenomeno ricompare. Spicca in questo periodo il brigante trentenne Michele Botti, detto "Falcone". attivo nelle zone intorno a Bagnacavallo. La sua carriera termina durante lo scontro a fuoco con le forze dell'ordine alle 9 del 14/5/1810 in Fondo Roncorosso a Bagnara.
Dopo la restaurazione il fenomeno, endemico, del brigantaggio prosegue in sordina. Spostandoci ai confini tra Marche e Romagna troviamo Antonio Cola, soprannominato “Fabrizj”. È il delinquente dalla carriera più lunga tra i briganti che hanno agito anche in territorio romagnolo. La sua zona di azione, tuttavia, va da Saludecio a S. Giovanni in Marignano, Gallo di Pesaro, Carpegna, Fano; per alcuni anni in Umbria, fino a Gubbio e addirittura a Todi.
Celeberrimo, qualche anno più tardi, Stefano Pelloni, detto “il “Passatore", che viene ucciso il 23/3/1851 [1].
Gli succede Angiolo Lama detto "Lisagna" e "Zappolone" la cui banda opera per due anni fra le Legazioni Pontificie e il Granducato di Toscana.
Il suo nome è legato alla strage del 5/5/1851 quando coi suoi compagni ammazza barbaramente cinque persone.
Prima Giuseppe Lombardi, colpevole di averli denunciati alla polizia granducale, con la moglie Maria e i due figli, Domenica e il piccolo Luigi, abitanti al Casetto, podere posto fra Tredozio e Modigliana. Poi il gruppo si sposta al vicino podere Masera uccidendo anche Domenico Bernabei, marito della figlia, perché non parli. Un massacro fatto per impaurire altri eventuali delatori.
Il 9/7/1853 Lisagna è freddato a tradimento insieme al suo compagno Antonio Ravaioli detto "Calabrese" da don Pietro Valgimigli detto "don Stiffelone", parroco di San Valentino presso Tredozio.
Al suo posto subentra Giuseppe Afflitti detto "Lazzarino" che prosegue l'attività brigantesca fino al 1857 quando, il 16 gennaio, è catturato all'Alpicella nell'Appennino tosco-romagnolo sopra Santa Sofia. Dopo averlo processato le autorità granducali lo consegnano a quelle pontificie; è fucilato all'alba dell'8/5/1857 a Bologna.
In quel periodo agiscono anche bande minori che sfruttano il clima di paura suscitato dai briganti più noti; fra queste merita ricordare la "banda delle canoniche" che opera per un breve periodo terrorizzando i parroci di campagna nella Romagna toscana.
Mentre l'ultimo brigante di un certo rilievo in Romagna sarà l'Ometto, dopo l'Unità: sarà ucciso a tradimento nel giugno 1873.
Per buona parte della prima metà dell'Ottocento il successo militare dei briganti era spesso dovuto anche alla parità offensiva tra le loro armi e quelle utilizzate dalla forza pubblica. In entrambi i casi, sostanzialmente, si trattava di armi con limitata gittata e scarso volume di fuoco; al limite anche un fucile da caccia poteva essere sufficiente ad opporre efficace contrasto. Il quadro muterà radicalmente negli anni sessanta dell'Ottocento quando i militari cominceranno ad essere dotati di armi a retrocarica perfezionate per l'uso bellico e risolutive in caso di conflitto a fuoco con bande di briganti.
Nota
[1] Si veda il breve riepilogo della sua "carriera" di brigante in Lombardi 2009:73-104. Cit. Vi troviamo anche l’inquadramento non idealizzato della sua figura, "un pazzo sanguinario, che spesso semina gratuita violenza, uccidendo con sadismo: l'unico brigante dell'intero Ottocento che giunge a sezionare le sue vittime".
8 yerel halk öneriyor
Russi
La presenza di briganti e banditi nel territorio romagnolo è attestata da documenti storici almeno fin dal XVI sec..
La "messa al bando" (da cui il termine "banditi") era attribuita a "fuoriusciti" politici, nobili o cittadini estradati a seguito delle lotte fra fazioni municipali. Questi continuavano a contrastare l'accentramento del potere locale con azioni militari vere e proprie assoldando tutta una congrega di dubbie figure fra cui ladroni, grassatori, masnadieri ovvero soldati disoccupati, delinquenti comuni colpiti dal bando in contumacia per crimini commessi contro il patrimonio o contro la persona.
Il fenomeno è testimoniato da documenti conservati nell'archivio storico di Terra del Sole che conserva circa 1.000 "filze" di atti civili e criminali che dalla fine del 400 fino all'Unità d'Italia registrano il fenomeno del banditismo in questi territori.
Storia del fenomeno
Il caso più emblematico è quello di Alfonso Piccolomini, duca di Montemarciano che, alla fine del Cinquecento, mise in atto azioni di brigantaggio nei territori al confine fra la Romagna toscana e quella pontificia. La banda armata del Piccolomini era composta da malfattori toscani, romagnoli e marchigiani. Sia il Granducato di Toscano che lo Stato Pontificio gli diedero la caccia per un lungo periodo impiegando ingenti risorse di uomini e mezzi. Il 16/3/1591 venne impiccato.
Sottoposta allo Stato Pontificio, con parti del territorio controllate da altre entità confinanti (Granducato di Toscana, legazioni di Bologna e Ferrara, oltre a territori in carico alle odierne Marche) la Romagna vede scorrere un flusso incessante di merci di contrabbando che alimentano la piccola criminalità locale.
Il salto di qualità, da contrabbandiere a brigante, non è scontato, ma la rete di potenziali manutengoli legata al traffico illegale, favorita dalla povertà endemica del territorio, è un fattore che può contribuire al proliferare di bande di briganti, particolarmente attive nei periodi di crisi delle istituzioni in Romagna. Bande che possono sfruttare le zone ancora difficili da controllare, come paludi della Bassa Romagna e territori montani e di confine tra entità territoriali con diverse legislazioni, dove i briganti possono fuggire in caso di inseguimenti e rastrellamenti.
Ottocento
Nell'Ottocento i dati sui briganti sono molteplici e contribuiscono a ricostruire un quadro abbastanza preciso, a partire dall'età Napoleonica, fino alla definitiva estirpazione del fenomeno con l'Unità d'Italia. Alcuni dei briganti più famosi in Romagna a partire dalla fine del Settecento sono Sebastiano Bora detto “Puiena”. Attivo tra la Presidenza d'Urbino e la Legazione di Romagna e Tommaso Rinaldini da Montemaggiore (Urbino) detto Mason d'la Blona (Tommaso dell'Isabellona), che succede a “Puiena”, insistendo grosso modo sul suo territorio.
Numerosissimi anche i briganti attivi durante i primi momenti dell'invasione napoleonica.
La situazione si stabilizza nel 1802, ma dal 1805 il fenomeno ricompare. Spicca in questo periodo il brigante trentenne Michele Botti, detto "Falcone". attivo nelle zone intorno a Bagnacavallo. La sua carriera termina durante lo scontro a fuoco con le forze dell'ordine alle 9 del 14/5/1810 in Fondo Roncorosso a Bagnara.
Dopo la restaurazione il fenomeno, endemico, del brigantaggio prosegue in sordina. Spostandoci ai confini tra Marche e Romagna troviamo Antonio Cola, soprannominato “Fabrizj”. È il delinquente dalla carriera più lunga tra i briganti che hanno agito anche in territorio romagnolo. La sua zona di azione, tuttavia, va da Saludecio a S. Giovanni in Marignano, Gallo di Pesaro, Carpegna, Fano; per alcuni anni in Umbria, fino a Gubbio e addirittura a Todi.
Celeberrimo, qualche anno più tardi, Stefano Pelloni, detto “il “Passatore", che viene ucciso il 23/3/1851 [1].
Gli succede Angiolo Lama detto "Lisagna" e "Zappolone" la cui banda opera per due anni fra le Legazioni Pontificie e il Granducato di Toscana.
Il suo nome è legato alla strage del 5/5/1851 quando coi suoi compagni ammazza barbaramente cinque persone.
Prima Giuseppe Lombardi, colpevole di averli denunciati alla polizia granducale, con la moglie Maria e i due figli, Domenica e il piccolo Luigi, abitanti al Casetto, podere posto fra Tredozio e Modigliana. Poi il gruppo si sposta al vicino podere Masera uccidendo anche Domenico Bernabei, marito della figlia, perché non parli. Un massacro fatto per impaurire altri eventuali delatori.
Il 9/7/1853 Lisagna è freddato a tradimento insieme al suo compagno Antonio Ravaioli detto "Calabrese" da don Pietro Valgimigli detto "don Stiffelone", parroco di San Valentino presso Tredozio.
Al suo posto subentra Giuseppe Afflitti detto "Lazzarino" che prosegue l'attività brigantesca fino al 1857 quando, il 16 gennaio, è catturato all'Alpicella nell'Appennino tosco-romagnolo sopra Santa Sofia. Dopo averlo processato le autorità granducali lo consegnano a quelle pontificie; è fucilato all'alba dell'8/5/1857 a Bologna.
In quel periodo agiscono anche bande minori che sfruttano il clima di paura suscitato dai briganti più noti; fra queste merita ricordare la "banda delle canoniche" che opera per un breve periodo terrorizzando i parroci di campagna nella Romagna toscana.
Mentre l'ultimo brigante di un certo rilievo in Romagna sarà l'Ometto, dopo l'Unità: sarà ucciso a tradimento nel giugno 1873.
Per buona parte della prima metà dell'Ottocento il successo militare dei briganti era spesso dovuto anche alla parità offensiva tra le loro armi e quelle utilizzate dalla forza pubblica. In entrambi i casi, sostanzialmente, si trattava di armi con limitata gittata e scarso volume di fuoco; al limite anche un fucile da caccia poteva essere sufficiente ad opporre efficace contrasto. Il quadro muterà radicalmente negli anni sessanta dell'Ottocento quando i militari cominceranno ad essere dotati di armi a retrocarica perfezionate per l'uso bellico e risolutive in caso di conflitto a fuoco con bande di briganti.
Nota
[1] Si veda il breve riepilogo della sua "carriera" di brigante in Lombardi 2009:73-104. Cit. Vi troviamo anche l’inquadramento non idealizzato della sua figura, "un pazzo sanguinario, che spesso semina gratuita violenza, uccidendo con sadismo: l'unico brigante dell'intero Ottocento che giunge a sezionare le sue vittime".
Alfonso Piccolomini (1558-1591)
Alfonso Piccolomini di Aragona e Castiglia, patrizio senese e conte palatino, imparentato con gli Orsini di Pitigliano, divenne signore di Montemarciano («vicario in temporalibus» per la Chiesa) a soli sedici anni, succedendo al defunto padre Giacomo. Si fece subito notare per il suo carattere bizzarro e sconsiderato e per i suoi modi violenti, trasformando la rocca di Montemarciano in un ricettacolo di banditi e le campagne intorno, specialmente nelle aree attraversata dal torrente Triponzio, in luoghi pericolosi e invivibili.
I suoi tutori e parenti, per mitigare gli eccessi del giovanissimo reggente, pensarono bene di farlo sposare ma in realtà neanche il matrimonio con la prescelta Ippolita Pico della Mirandola, celebrato a Pesaro nel 1578, riuscì a distogliere il Piccolomini dalle malefatte e dai soprusi che andava continuamente commettendo in vari territori d’Italia – dalle Marche all’Umbria alla Toscana ed in seguito anche a Venezia -, rendendosi sempre più inviso a papa Gregorio XIII.
Si racconta che Alfonso, per sfuggire alle milizie pontificie e ai suoi nemici, mettesse a punto una serie di stratagemmi atti a renderlo irriconoscibile, attraverso i quali riusciva ogni volta a salvarsi dalla cattura: tra questi, va sicuramente ricordato quella sorta di travestimento che lo vedeva portare una barba posticcia, di colore e lunghezza sempre variabili, oltre al cerone con cui soleva ricoprire il proprio volto, che gli conferiva un pallore a dir poco inquietante. È noto che in alcuni casi si serviva addirittura di un sosia, tale Giovanni Paolo di Brescia, per depistare qualsiasi nemico che fosse sulle sue tracce.
Ma la stagione di violenza e di feroce banditismo inaugurata a Montemarciano da Alfonso ben presto terminò: il 27 novembre del 1578 infatti il papa ordinò la distruzione di quel «castello bello, forte e molto ben ornato» – dotato di due «fortissimi torrioni», uno verso mare e l’altro, di epoca posteriore, verso la montagna – e il disboscamento delle selve di Montemarciano e Monte S. Vito, per neutralizzare una volta per tutte il Piccolomini e la banda di briganti al suo seguito (vennero catturati in totale ben 140 banditi). In quell’occasione, Montemarciano perse non solo uno dei suoi edifici simbolo, anzi, forse il principale monumento storico che aveva, ma anche l’antico archivio conservato dentro la fortezza, che fu dato alle fiamme e di cui non resta praticamente nessuna traccia.
Dopo tale atto di distruzione – la rocca venne demolita da duemila muratori e con l’ausilio di cariche esplosive – lo Stato ecclesiastico concedeva comunque ad Alfonso di rimanere, almeno formalmente, vicario di Montemarciano, come si legge in un documento del 1579, mentre lui ripiegò per qualche tempo a Mirandola, dove si sentiva più al sicuro. È significativo il fatto che, anche dopo la severa punizione e la sconfitta inflittagli dal pontefice, Alfonso non avesse la minima intenzione di redimersi e di migliorare la propria condotta: nel maggio del 1581 si consumò l’eccidio di Montalboddo (l’odierna Ostra) contro le truppe del colonnello Pierconte Gabuzi, suo nemico storico, e a danno di alcuni abitanti, che vennero barbaramente trucidati dalla banda guidata dal sanguinario Alfonso.
Seguirono anni di continue razzie e attacchi in vari territori d’Italia, sempre coadiuvato dal suo esercito di 150-200 uomini, in costante movimento per non farsi catturare. Le violenze perpetrate da Alfonso, il cui nemico principale rimaneva il papa, specie dopo la distruzione della rocca di Montemarciano, avvenivano peraltro con la complicità e spesso con l’appoggio delle popolazioni locali, che giustificavano le azioni del Piccolomini, ritenendole una legittima vendetta contro un ingiusto pontefice.
Dopo anni di turbolenti scorribande e spostamenti, anche fuori dall’Italia, Alfonso venne alfine catturato a Bracciano nel 1591 e impiccato poco dopo alla torre del Bargello, a Firenze. Fu sepolto nella chiesa fiorentina della Confraternita dei Neri a Borgo la Croce (fuori porta S. Francesco) ma la sua tomba andò perduta nel XVIII secolo, quando l’edificio sacro venne distrutto.
Montemarciano
Alfonso Piccolomini (1558-1591)
Alfonso Piccolomini di Aragona e Castiglia, patrizio senese e conte palatino, imparentato con gli Orsini di Pitigliano, divenne signore di Montemarciano («vicario in temporalibus» per la Chiesa) a soli sedici anni, succedendo al defunto padre Giacomo. Si fece subito notare per il suo carattere bizzarro e sconsiderato e per i suoi modi violenti, trasformando la rocca di Montemarciano in un ricettacolo di banditi e le campagne intorno, specialmente nelle aree attraversata dal torrente Triponzio, in luoghi pericolosi e invivibili.
I suoi tutori e parenti, per mitigare gli eccessi del giovanissimo reggente, pensarono bene di farlo sposare ma in realtà neanche il matrimonio con la prescelta Ippolita Pico della Mirandola, celebrato a Pesaro nel 1578, riuscì a distogliere il Piccolomini dalle malefatte e dai soprusi che andava continuamente commettendo in vari territori d’Italia – dalle Marche all’Umbria alla Toscana ed in seguito anche a Venezia -, rendendosi sempre più inviso a papa Gregorio XIII.
Si racconta che Alfonso, per sfuggire alle milizie pontificie e ai suoi nemici, mettesse a punto una serie di stratagemmi atti a renderlo irriconoscibile, attraverso i quali riusciva ogni volta a salvarsi dalla cattura: tra questi, va sicuramente ricordato quella sorta di travestimento che lo vedeva portare una barba posticcia, di colore e lunghezza sempre variabili, oltre al cerone con cui soleva ricoprire il proprio volto, che gli conferiva un pallore a dir poco inquietante. È noto che in alcuni casi si serviva addirittura di un sosia, tale Giovanni Paolo di Brescia, per depistare qualsiasi nemico che fosse sulle sue tracce.
Ma la stagione di violenza e di feroce banditismo inaugurata a Montemarciano da Alfonso ben presto terminò: il 27 novembre del 1578 infatti il papa ordinò la distruzione di quel «castello bello, forte e molto ben ornato» – dotato di due «fortissimi torrioni», uno verso mare e l’altro, di epoca posteriore, verso la montagna – e il disboscamento delle selve di Montemarciano e Monte S. Vito, per neutralizzare una volta per tutte il Piccolomini e la banda di briganti al suo seguito (vennero catturati in totale ben 140 banditi). In quell’occasione, Montemarciano perse non solo uno dei suoi edifici simbolo, anzi, forse il principale monumento storico che aveva, ma anche l’antico archivio conservato dentro la fortezza, che fu dato alle fiamme e di cui non resta praticamente nessuna traccia.
Dopo tale atto di distruzione – la rocca venne demolita da duemila muratori e con l’ausilio di cariche esplosive – lo Stato ecclesiastico concedeva comunque ad Alfonso di rimanere, almeno formalmente, vicario di Montemarciano, come si legge in un documento del 1579, mentre lui ripiegò per qualche tempo a Mirandola, dove si sentiva più al sicuro. È significativo il fatto che, anche dopo la severa punizione e la sconfitta inflittagli dal pontefice, Alfonso non avesse la minima intenzione di redimersi e di migliorare la propria condotta: nel maggio del 1581 si consumò l’eccidio di Montalboddo (l’odierna Ostra) contro le truppe del colonnello Pierconte Gabuzi, suo nemico storico, e a danno di alcuni abitanti, che vennero barbaramente trucidati dalla banda guidata dal sanguinario Alfonso.
Seguirono anni di continue razzie e attacchi in vari territori d’Italia, sempre coadiuvato dal suo esercito di 150-200 uomini, in costante movimento per non farsi catturare. Le violenze perpetrate da Alfonso, il cui nemico principale rimaneva il papa, specie dopo la distruzione della rocca di Montemarciano, avvenivano peraltro con la complicità e spesso con l’appoggio delle popolazioni locali, che giustificavano le azioni del Piccolomini, ritenendole una legittima vendetta contro un ingiusto pontefice.
Dopo anni di turbolenti scorribande e spostamenti, anche fuori dall’Italia, Alfonso venne alfine catturato a Bracciano nel 1591 e impiccato poco dopo alla torre del Bargello, a Firenze. Fu sepolto nella chiesa fiorentina della Confraternita dei Neri a Borgo la Croce (fuori porta S. Francesco) ma la sua tomba andò perduta nel XVIII secolo, quando l’edificio sacro venne distrutto.
SEBASTIANO BORA detto “PUIENA”
Durante il XVIII secolo, nell’area di San Marino, si ritrova Sebastiano Bora, detto “Puiena”, capo di una spietata banda di briganti, dedita spesso al contrabbando in un’area alquanto estesa, che andava dall’urbinate al cesenate.
La scelta di tali zone non è casuale, in quanto creava una sorta di cortocircuito fra le autorità della Presidenza d’Urbino e quelle della Legazione di Romagna, scarsamente coordinate nella repressione criminale. Inoltre la Repubblica di San Marino fungeva da riparo e luogo di magazzinaggio per le attività di contrabbando di Puiena. Tuttavia questo generò pressioni da parte delle autorità pontificie sulla Repubblica, che cercò di allontanare il brigante, preparandosi anche allo scontro. Puiena venne nel frattempo catturato dai pontifici, che lo giustiziarono a Ravenna.
Ciò non comportò, tuttavia, una pacificazione della zona. Infatti gli altri briganti riuscirono poi a ricompattare la banda sotto la guida di Sebastiano Zolini di Montetiffi.
227 yerel halk öneriyor
San Marino
SEBASTIANO BORA detto “PUIENA”
Durante il XVIII secolo, nell’area di San Marino, si ritrova Sebastiano Bora, detto “Puiena”, capo di una spietata banda di briganti, dedita spesso al contrabbando in un’area alquanto estesa, che andava dall’urbinate al cesenate.
La scelta di tali zone non è casuale, in quanto creava una sorta di cortocircuito fra le autorità della Presidenza d’Urbino e quelle della Legazione di Romagna, scarsamente coordinate nella repressione criminale. Inoltre la Repubblica di San Marino fungeva da riparo e luogo di magazzinaggio per le attività di contrabbando di Puiena. Tuttavia questo generò pressioni da parte delle autorità pontificie sulla Repubblica, che cercò di allontanare il brigante, preparandosi anche allo scontro. Puiena venne nel frattempo catturato dai pontifici, che lo giustiziarono a Ravenna.
Ciò non comportò, tuttavia, una pacificazione della zona. Infatti gli altri briganti riuscirono poi a ricompattare la banda sotto la guida di Sebastiano Zolini di Montetiffi.
13/10/1786 – Condanna a morte per Masòn dla Blona e i suoi briganti
“Musa, cantiam le memorande imprese
Di Rinaldin, dell’immortal Tremone,
ai quali Marte il cor d’ardire accese
di Rinaldo e d’Orlando al paragone.
E sempre invitti, e vincitor li rese
in ogni audace bellica tenzone,
onde la vil sbirraglia infame e sciocca
morde per rabbia ancor la lingua in bocca”
Sono i versi scritti da un frate, Mariano Minghetti, che Nevio Matteini ha riscoperto della Biblioteca Gambalunghiana di Rimini.
Narrano le imprese di Masòn dla Blona, che Leandro Castellani nel suo libro “La ballata di un brigante” ha voluto ribattezzare “il Robin Hood di Montemaggiore“.
Il 13/10/1786, a Ravenna, il Cardinal Legato Valenti-Gonzaga, condanna a morte Rinaldini Tommaso detto Masòn d’la Blona, Baldrati Giovanni da Castel Bolognese detto Tremone e Foschi Francesco da Cesenatico. Promulgatasi la sentenza e fatto venire da Mantova il carnefice, sono giustiziati per impiccagione il 21 di ottobre.
In ottemperanza alle disposizioni della sentenza, le teste di Masòn, di Tremone e del Franceschino, vengono trasportate a Cattolica, ai confini della legazione di Romagna. Sono esposte per ammonimento, «con ferrate e lapide», sul frontone della porta del paese, che da allora (sembra) assumerà il nome di “porta degli impiccati”.
E’ questa la fine di una delle bande di briganti fra le più famose dell’epoca, capace di imprese che saranno narrate per decenni.
Tommaso Rinaldini era originario di Montemaggiore al Metauro, fra Fano e Fossombrone.
Masòn doveva il suo soprannome alla madre, Isabella, detta Isabellona, quindi in dialetto Blona. Era figlio illegittimo di un falegname, Michel Angelo Rinaldini.
La prima traccia scritta delle sue gesta si hanno nel 1781 quando il Podestà di San Costanzo, quale giudice deputato di Pesaro, cita Masòn d’la Blona a rispondere «entro il termine di cinque giorni» per l’assassinio del tenente Trevisani, comandante una pattuglia di “birri” di campagna. Ma come si era giunti a quel delitto?
A quanto pare, Masòn, era come tanti, dedito al contrabbando di grano. Un’attività che il popolo non considerava affatto delittuosa. Al contrario, il contrabbandiere aiutava il contadino a spuntare guadagni più alti sfuggendo alle infinite dogane e gabelle, quelle sì odiatissime, che martoriavano il territorio e circondavano le città.
Ma un giorno del 1781, a Pesaro presso Porta Fano, un birro uccide un compagno di Masòn, che da quel momento matura un’avversione feroce contro ogni uomo dell’ordine.
Perfino negli atti della sua condanna a morte si legge che il movente delle azioni del bandito non è tanto la cupidigia, ma «la causa di delinquere rimane sempre più avvalorata dall’odio intestino nutrito da simili persone contro li birri». Dunque un ribelle prima ancora che un ladro e un assassino.
E un ribelle «bello, aitante nella persona, dalla parola facile e convincente – scrive sempre Matteini – le sue gesta sempre generose anche se talora violente … ma dappertutto trovò il sostegno della gente che ne pianse la morte».
Dopo l’omicidio del tenente Trevisani, i birri vanno a cercare Masòn a Montemaggiore; ma lui e suoi compari li fanno addirittura prigionieri e poi se ne vanno consegnando le chiavi della cella ai paesani. E siccome è tempo di Carnevale il tutto assume anche il sapore di una beffa. Già il popolo applaude.
Nella banda di Masòn sono in 15. Si specializzano nelle estorsioni: compaiono nella piazza di un mercato, come per esempio a Morciano, e consegnano ai più benestanti una lettera: basta questo a convincerli a versare l’ammontare del “pizzo” scritto su quel foglio. Ma i birri restano ne loro mirino, come quando mettono praticamente sotto assedio il bargellato di Urbino (oggi diremmo il commissariato) a furia di archibugiate.
Non sempre va bene. Un compagno di Masòn, tal Fabbri di Coriano, viene catturato a Verucchio e decapitato. La banda scappa a San Marino; ormai il Legato ha mobilitato anche l’esercito e la Repubblica viene circondata. Però Masòn arriva lo stesso a Montebello e la fa sua. Sono gli ultimi giorni del 1785.
La banda resta a lungo nel castello, dove si è impadronita perfino dell’artiglieria; Masòn fa venire lì pure la moglie e suoi figli. E quando arrivano 300 soldati a prenderlo, dopo l’ennesima battaglia, lui scappa ancora, come se volasse. Prima di nuovo a San Marino, quindi riappare a Carpegna.
Qui irrompe con altri tre nel palazzo del cardinale, vi si installa e ne sequestra i proprietari. Quando arrivano i militari pontifici, i banditi si rifugiano nel sottotetto sparando all’impazzata. Per stanarli si dà fuoco a paglia e fascine. Altre sparatorie, vani tentativi di fuga dalle canne fumarie, poi calandosi dal tetto con una corda. Inutile, è finita.
Masòn tratta la resa: chiede di riabbracciare la moglie; di restare almeno altri tre giorni in Carpegna per riacquistare le forze; di non essere dileggiato né deriso dai soldati papalini; di non subire l’onta delle manette e delle catene. Se non va bene, allora preferisce ammazzarsi subito.
“Se vuoi ch’io ceda, gli rispose allora
l’invitto eroe, questi saranno i patti
se tu li accetti, e se mi giuri ancora,
che non sian violati, e non disfatti,
io l’armi deporrò senza dimora
e porrò fine a sanguinosi fatti,
ma se ricusi quanto ti propongo
a fuggire, o a morire, io mi dispongo”
Il Tenente Piccoli promette sul suo onore. I tre banditi cedono le armi nelle mani del loro capo, che a sua volta le consegna al militare. Sono le sette di sera del 21/5/1786.
Dopo quattro giorni Masòn è trasferito a Rimini, ma in catene, il volto coperto da un fazzoletto. Tutti accorrono a vederlo. Su di un muro compare una scritta che inneggia a colui “a nessuno secondo per umanità, intelligenza, eccellenza su altri”. La mattina del 9 giugno lo portano a Ravenna. Alla partenza tutta Rimini fa ala al suo passaggio. Masòn sorride alla folla, che piange.
58 yerel halk öneriyor
Cattolica
13/10/1786 – Condanna a morte per Masòn dla Blona e i suoi briganti
“Musa, cantiam le memorande imprese
Di Rinaldin, dell’immortal Tremone,
ai quali Marte il cor d’ardire accese
di Rinaldo e d’Orlando al paragone.
E sempre invitti, e vincitor li rese
in ogni audace bellica tenzone,
onde la vil sbirraglia infame e sciocca
morde per rabbia ancor la lingua in bocca”
Sono i versi scritti da un frate, Mariano Minghetti, che Nevio Matteini ha riscoperto della Biblioteca Gambalunghiana di Rimini.
Narrano le imprese di Masòn dla Blona, che Leandro Castellani nel suo libro “La ballata di un brigante” ha voluto ribattezzare “il Robin Hood di Montemaggiore“.
Il 13/10/1786, a Ravenna, il Cardinal Legato Valenti-Gonzaga, condanna a morte Rinaldini Tommaso detto Masòn d’la Blona, Baldrati Giovanni da Castel Bolognese detto Tremone e Foschi Francesco da Cesenatico. Promulgatasi la sentenza e fatto venire da Mantova il carnefice, sono giustiziati per impiccagione il 21 di ottobre.
In ottemperanza alle disposizioni della sentenza, le teste di Masòn, di Tremone e del Franceschino, vengono trasportate a Cattolica, ai confini della legazione di Romagna. Sono esposte per ammonimento, «con ferrate e lapide», sul frontone della porta del paese, che da allora (sembra) assumerà il nome di “porta degli impiccati”.
E’ questa la fine di una delle bande di briganti fra le più famose dell’epoca, capace di imprese che saranno narrate per decenni.
Tommaso Rinaldini era originario di Montemaggiore al Metauro, fra Fano e Fossombrone.
Masòn doveva il suo soprannome alla madre, Isabella, detta Isabellona, quindi in dialetto Blona. Era figlio illegittimo di un falegname, Michel Angelo Rinaldini.
La prima traccia scritta delle sue gesta si hanno nel 1781 quando il Podestà di San Costanzo, quale giudice deputato di Pesaro, cita Masòn d’la Blona a rispondere «entro il termine di cinque giorni» per l’assassinio del tenente Trevisani, comandante una pattuglia di “birri” di campagna. Ma come si era giunti a quel delitto?
A quanto pare, Masòn, era come tanti, dedito al contrabbando di grano. Un’attività che il popolo non considerava affatto delittuosa. Al contrario, il contrabbandiere aiutava il contadino a spuntare guadagni più alti sfuggendo alle infinite dogane e gabelle, quelle sì odiatissime, che martoriavano il territorio e circondavano le città.
Ma un giorno del 1781, a Pesaro presso Porta Fano, un birro uccide un compagno di Masòn, che da quel momento matura un’avversione feroce contro ogni uomo dell’ordine.
Perfino negli atti della sua condanna a morte si legge che il movente delle azioni del bandito non è tanto la cupidigia, ma «la causa di delinquere rimane sempre più avvalorata dall’odio intestino nutrito da simili persone contro li birri». Dunque un ribelle prima ancora che un ladro e un assassino.
E un ribelle «bello, aitante nella persona, dalla parola facile e convincente – scrive sempre Matteini – le sue gesta sempre generose anche se talora violente … ma dappertutto trovò il sostegno della gente che ne pianse la morte».
Dopo l’omicidio del tenente Trevisani, i birri vanno a cercare Masòn a Montemaggiore; ma lui e suoi compari li fanno addirittura prigionieri e poi se ne vanno consegnando le chiavi della cella ai paesani. E siccome è tempo di Carnevale il tutto assume anche il sapore di una beffa. Già il popolo applaude.
Nella banda di Masòn sono in 15. Si specializzano nelle estorsioni: compaiono nella piazza di un mercato, come per esempio a Morciano, e consegnano ai più benestanti una lettera: basta questo a convincerli a versare l’ammontare del “pizzo” scritto su quel foglio. Ma i birri restano ne loro mirino, come quando mettono praticamente sotto assedio il bargellato di Urbino (oggi diremmo il commissariato) a furia di archibugiate.
Non sempre va bene. Un compagno di Masòn, tal Fabbri di Coriano, viene catturato a Verucchio e decapitato. La banda scappa a San Marino; ormai il Legato ha mobilitato anche l’esercito e la Repubblica viene circondata. Però Masòn arriva lo stesso a Montebello e la fa sua. Sono gli ultimi giorni del 1785.
La banda resta a lungo nel castello, dove si è impadronita perfino dell’artiglieria; Masòn fa venire lì pure la moglie e suoi figli. E quando arrivano 300 soldati a prenderlo, dopo l’ennesima battaglia, lui scappa ancora, come se volasse. Prima di nuovo a San Marino, quindi riappare a Carpegna.
Qui irrompe con altri tre nel palazzo del cardinale, vi si installa e ne sequestra i proprietari. Quando arrivano i militari pontifici, i banditi si rifugiano nel sottotetto sparando all’impazzata. Per stanarli si dà fuoco a paglia e fascine. Altre sparatorie, vani tentativi di fuga dalle canne fumarie, poi calandosi dal tetto con una corda. Inutile, è finita.
Masòn tratta la resa: chiede di riabbracciare la moglie; di restare almeno altri tre giorni in Carpegna per riacquistare le forze; di non essere dileggiato né deriso dai soldati papalini; di non subire l’onta delle manette e delle catene. Se non va bene, allora preferisce ammazzarsi subito.
“Se vuoi ch’io ceda, gli rispose allora
l’invitto eroe, questi saranno i patti
se tu li accetti, e se mi giuri ancora,
che non sian violati, e non disfatti,
io l’armi deporrò senza dimora
e porrò fine a sanguinosi fatti,
ma se ricusi quanto ti propongo
a fuggire, o a morire, io mi dispongo”
Il Tenente Piccoli promette sul suo onore. I tre banditi cedono le armi nelle mani del loro capo, che a sua volta le consegna al militare. Sono le sette di sera del 21/5/1786.
Dopo quattro giorni Masòn è trasferito a Rimini, ma in catene, il volto coperto da un fazzoletto. Tutti accorrono a vederlo. Su di un muro compare una scritta che inneggia a colui “a nessuno secondo per umanità, intelligenza, eccellenza su altri”. La mattina del 9 giugno lo portano a Ravenna. Alla partenza tutta Rimini fa ala al suo passaggio. Masòn sorride alla folla, che piange.
15 Luglio 1861: Il brigante Gaetano Prosperi "lo Spirito"
Nel marzo 1860, in seguito ai plebisciti popolari, il re Vittorio Emanuele II decretò l’entrata nel Regno d’Italia delle province dell’Emilia, delle Romagne e della Toscana. Fu così cancellato l’antico confine presso Monghidoro e poté cominciare il libero scambio di merci tra i due versanti dell’Appennino. Di questa nuova situazione erano scontenti, ovviamente, sia i contrabbandieri sia i commercianti locali.
15/7/1861: Il brigante Prosperi "lo Spirito"
Un’altra fonte di malumore fu, a partire dal 30/6/1860, l’imposizione della leva obbligatoria di 5 anni per i giovani che avessero compiuto 21 anni. Molti rifiutarono di arruolarsi e si diedero al brigantaggio.
La rivolta contro il Regno d’Italia non si fece attendere. La notte dell’8 agosto, una banda guidata da un mugnaio di Lognola, Gaetano Prosperi, detto “lo Spirito” e da un giovane studente di legge, Assuero Ruggeri, passò casa per casa, nelle borgate intorno a Monghidoro, per incitare i giovani a seguirli. Verso le 5 di mattina, una cinquantina di uomini assalirono il palazzo della Guardia Nazionale di Monghidoro, tolsero lo stemma dei Savoia dalla facciata del palazzo e lo sostituirono con quello dello Stato Pontificio. Alla reazione armata dei militi, i ribelli fuggirono si dispersero nelle campagne.
Nei giorni seguenti la Guardia Nazionale avviò la caccia ai rivoltosi. Molti furono catturati ma Ruggeri, lo Spirito e alcuni compagni erano fuggiti a Urbino e si erano arruolati nel cosiddetto “Esercito della Fede” aggregato alle truppe francesi in difesa dei territori pontifici. In settembre, in seguito alle sconfitte dei “papisti”, lo Spirito tornò a Monghidoro. La notizia fece il giro della montagna e la Guardia Nazionale riprese a braccarlo, ma il bandito era protetto da una fitta rete di amicizie tra i parroci e i contadini.
Il 15/7/1861, un brigadiere dei carabinieri Giacomo Sondaz incrociò casualmente lo Spirito su una strada di campagna. Ci fu uno scontro a fuoco e il brigadiere, gravemente ferito, morì dissanguato. Fu quindi spiccato un nuovo mandato di cattura per omicidio volontario.
Dopo una breve fuga a Roma, lo Spirito tornò a Monghidoro nell’aprile del 1862. I mesi passarono senza che le forze dell’ordine riuscissero a catturare il fuggiasco finché il 14 ottobre accadde un incidente. Mentre lo Spirito caricava il proprio fucile, la canna scoppiò sfracellandogli la mano sinistra. Alcuni giorni dopo fu arrestato in una casa nei pressi di San Benedetto Val di Sambro e portato in carcere a Bologna.
Il 26/5/1863 cominciò il processo e tre giorni dopo fu emessa la sentenza di condanna a morte. Alle 6,30 del 15/12/1863, Gaetano Prosperi, all’età di 32 anni, fu ghigliottinato. Finiva così l’epopea del più famoso brigante della montagna bolognese, ma per molto tempo ancora i contadini si tramandarono le gesta del mugnaio di Logno.
7 yerel halk öneriyor
Monghidoro
15 Luglio 1861: Il brigante Gaetano Prosperi "lo Spirito"
Nel marzo 1860, in seguito ai plebisciti popolari, il re Vittorio Emanuele II decretò l’entrata nel Regno d’Italia delle province dell’Emilia, delle Romagne e della Toscana. Fu così cancellato l’antico confine presso Monghidoro e poté cominciare il libero scambio di merci tra i due versanti dell’Appennino. Di questa nuova situazione erano scontenti, ovviamente, sia i contrabbandieri sia i commercianti locali.
15/7/1861: Il brigante Prosperi "lo Spirito"
Un’altra fonte di malumore fu, a partire dal 30/6/1860, l’imposizione della leva obbligatoria di 5 anni per i giovani che avessero compiuto 21 anni. Molti rifiutarono di arruolarsi e si diedero al brigantaggio.
La rivolta contro il Regno d’Italia non si fece attendere. La notte dell’8 agosto, una banda guidata da un mugnaio di Lognola, Gaetano Prosperi, detto “lo Spirito” e da un giovane studente di legge, Assuero Ruggeri, passò casa per casa, nelle borgate intorno a Monghidoro, per incitare i giovani a seguirli. Verso le 5 di mattina, una cinquantina di uomini assalirono il palazzo della Guardia Nazionale di Monghidoro, tolsero lo stemma dei Savoia dalla facciata del palazzo e lo sostituirono con quello dello Stato Pontificio. Alla reazione armata dei militi, i ribelli fuggirono si dispersero nelle campagne.
Nei giorni seguenti la Guardia Nazionale avviò la caccia ai rivoltosi. Molti furono catturati ma Ruggeri, lo Spirito e alcuni compagni erano fuggiti a Urbino e si erano arruolati nel cosiddetto “Esercito della Fede” aggregato alle truppe francesi in difesa dei territori pontifici. In settembre, in seguito alle sconfitte dei “papisti”, lo Spirito tornò a Monghidoro. La notizia fece il giro della montagna e la Guardia Nazionale riprese a braccarlo, ma il bandito era protetto da una fitta rete di amicizie tra i parroci e i contadini.
Il 15/7/1861, un brigadiere dei carabinieri Giacomo Sondaz incrociò casualmente lo Spirito su una strada di campagna. Ci fu uno scontro a fuoco e il brigadiere, gravemente ferito, morì dissanguato. Fu quindi spiccato un nuovo mandato di cattura per omicidio volontario.
Dopo una breve fuga a Roma, lo Spirito tornò a Monghidoro nell’aprile del 1862. I mesi passarono senza che le forze dell’ordine riuscissero a catturare il fuggiasco finché il 14 ottobre accadde un incidente. Mentre lo Spirito caricava il proprio fucile, la canna scoppiò sfracellandogli la mano sinistra. Alcuni giorni dopo fu arrestato in una casa nei pressi di San Benedetto Val di Sambro e portato in carcere a Bologna.
Il 26/5/1863 cominciò il processo e tre giorni dopo fu emessa la sentenza di condanna a morte. Alle 6,30 del 15/12/1863, Gaetano Prosperi, all’età di 32 anni, fu ghigliottinato. Finiva così l’epopea del più famoso brigante della montagna bolognese, ma per molto tempo ancora i contadini si tramandarono le gesta del mugnaio di Logno.
Prospero Baschieri (Pruspòn), il brigante gigante
Prospero Baschieri, detto Pruspòn, un personaggio che ha letteralmente infuocato le campagne di gran parte del bolognese tra il 1809 ed il 1810, diventando una vera e propria leggenda.
Prospero nacque nel 1781 a Maddalena di Cazzano, località di Budrio, da una famiglia di contadini. Era il quinto di otto fratelli ed in una famiglia così numerosa non mancavano di certo i sacrifici dovuti a miseria e stenti.
Le cronache raccontano che era un gigante alto più di due metri, con spalle grosse, capelli lunghi e bruni, volto incavato e "bislungo" e occhi grigi.
Visse in un periodo in cui le province settentrionali dello Stato Pontificio erano state invase dalle truppe di Napoleone Bonaparte entrando a far parte della Repubblica Cisalpina. Un po' ovunque cominciarono moti di resistenza popolare che durarono dal 1796 al 1814 e che in Italia vennero chiamati "insorgenza" (in dialetto bolognese, gli aderenti erano chiamati "insurzènt"), un fenomeno volutamente dimenticato e così scarsamente menzionato nei libri di storia che gli insorgenti vengono oggi ricordati solo come briganti e le loro gesta descritte alla stregua di delinquenza comune.
Prospero Baschieri
Nel 1804, Prospero aveva rifiutato di aderire alla leva napoleonica e divenne il capo di un gruppo di insorgenti. Viveva con la famiglia a Longara, vicino al Passo del Trebbo, ed utilizzava la zona golenale del fiume con i suoi acquitrini, ricche di canneti e di arbusti, per nascondersi, spostarsi da un lato all'altro e sfuggire alla caccia dei gendarmi e delle truppe francesi che non conoscevano bene quelle zone.
Era abile strategicamente, ma soprattutto era amato e benvoluto dalla popolazione che lo reputava un rivoluzionario benefattore e quindi lo aiutava a trovare nuovi nascondigli.
Tra il 1809 ed il 1810 mise in opera una serie di azioni sovversive per liberare il popolo dall'oppressione francese, anche se non tutte andarono a buon fine. Col tempo, la banda divenne composta da oltre duecento uomini che misero a soqquadro tutto il territorio compreso fra Medicina e Sant'Agata Bolognese.
Invase Budrio e Minerbio, non con l'intento di prenderne il controllo, ma con la speranza di alimentare focolai di ribellione e di trovare un sempre maggior numero di aderenti alla sua causa.
Assaltò la sede del Comune di Trebbo di Reno incendiando i registri ed altri documenti di contabilità e sottraendo 100 zecchini dalla cassa del Sindaco Martinelli.
Tentò anche di liberare Bologna cercando di aprire una breccia a Porta Galliera, ma poco armato e senza il consenso popolare fallì nel suo intento e fu costretto alla ritirata dall'artiglieria napoleonica e dalla Guardia Nazionale.
Occupò San Giovanni in Persiceto, lasciando andare libero un folto drappello di francesi che si erano arresi. Condusse un assalto alla caserma di Altedo, dandola alla fiamme ed ancora una volta costringendo il presidio francese a darsi alla fuga.
Sembra che lo schema dei suoi assalti fosse sempre lo stesso: in molti paesi della bassa costringeva i funzionari alla resa inducendoli a rifugiarsi entro le mura di Bologna, per poi dividere i proventi delle sue imprese nei paesi che liberava con la popolazione affamata.
Evidentemente, però, non tutti gli erano così fedeli. Nel marzo 1810, un drappello di francesi e di guardie nazionali apprese dalle imprudenti parole di una donna che Baschieri e i suoi si trovavano ospiti in una delle cascine di proprietà della famiglia Rubbini in località "Podere Malcampo", vicino a Budrio e circondò la casa.
Dopo un conflitto a fuoco che non risparmiò morti da ambo le parti, Prospero venne ferito mortalmente. La storia racconta che raccolse un pugno di terra e poi, per non finire nelle mani dei francesi, si lasciò cadere in un canale dove morì dissanguato.
I suoi nemici ne raccolsero il cadavere e come gesto simbolico verso la popolazione che lo aveva appoggiato, lo decapitarono ed esposero la sua testa conficcata in cima ad un palo sia a Budrio che a Bologna.
Col tempo, anche nei luoghi in cui le sue gesta erano diventate leggendarie, si diffuse una canzone di chiara marca propagandistica, commissionata dal regime, che venne applaudita in piazza proprio da coloro che gli erano stati più vicini:
"Traversando per il campo per voler cogli altri andare, mi mancarono le forze, non potei più camminare. E così steso per terra, senza aiuto e alcun conforto, dei nemici fui la preda e restai per sempre morto. Indi a Budrio con gran pompa fui portato con gran festa e dal popol nella piazza beffeggiata fu mia testa..."
I documenti riguardanti la Guardia Nazionale di Budrio conservati nella Biblioteca dell'Archiginnasio di Bologna lo descrivono come "un uomo irrispettoso delle leggi la cui ferocia non gli faceva risparmiare i feriti, che egli barbaramente finiva di trucidare con le stesse armi loro catturate". E poi ancora aggiungono che "grande fu in tutto il territorio bolognese il tripudio per la fine dei tre capi più funesti del brigantaggio".
La fine di Propero Baschieri è molto triste, ma lo è ancora di più il modo col quale la memoria degli eventi di cui è stato protagonista e dei motivi storici e civili che li scatenarono, è stata manipolata e trasformata.
Gli insorgenti, a partire dal 1809 si autodefinirono "patrioti" costretti a lottare con ogni mezzo contro l'invasore. Le memorie ufficiali li descrissero come dei barbari. Il popolo, volente o nolente, una volta uccisi i leader rivoluzionari, dovette accettare la versione storica e l'ideologia dei vincitori.
Forse un giorno il vento dell'insorgenza tornerà a soffiare e Prospero e tutti gli insorgenti avranno il posto che gli spetta sui libri di storia, nella memoria e nella coscienza popolare. Forse quello sarà il giorno in cui si potrà riconoscere nei moti insurrezionali del 1809 l'inizio del rapido crollo del regime napoleonico in Italia e soprattutto il primo movimento veramente popolare del Risorgimento italiano.
232 yerel halk öneriyor
Bologna
Prospero Baschieri (Pruspòn), il brigante gigante
Prospero Baschieri, detto Pruspòn, un personaggio che ha letteralmente infuocato le campagne di gran parte del bolognese tra il 1809 ed il 1810, diventando una vera e propria leggenda.
Prospero nacque nel 1781 a Maddalena di Cazzano, località di Budrio, da una famiglia di contadini. Era il quinto di otto fratelli ed in una famiglia così numerosa non mancavano di certo i sacrifici dovuti a miseria e stenti.
Le cronache raccontano che era un gigante alto più di due metri, con spalle grosse, capelli lunghi e bruni, volto incavato e "bislungo" e occhi grigi.
Visse in un periodo in cui le province settentrionali dello Stato Pontificio erano state invase dalle truppe di Napoleone Bonaparte entrando a far parte della Repubblica Cisalpina. Un po' ovunque cominciarono moti di resistenza popolare che durarono dal 1796 al 1814 e che in Italia vennero chiamati "insorgenza" (in dialetto bolognese, gli aderenti erano chiamati "insurzènt"), un fenomeno volutamente dimenticato e così scarsamente menzionato nei libri di storia che gli insorgenti vengono oggi ricordati solo come briganti e le loro gesta descritte alla stregua di delinquenza comune.
Prospero Baschieri
Nel 1804, Prospero aveva rifiutato di aderire alla leva napoleonica e divenne il capo di un gruppo di insorgenti. Viveva con la famiglia a Longara, vicino al Passo del Trebbo, ed utilizzava la zona golenale del fiume con i suoi acquitrini, ricche di canneti e di arbusti, per nascondersi, spostarsi da un lato all'altro e sfuggire alla caccia dei gendarmi e delle truppe francesi che non conoscevano bene quelle zone.
Era abile strategicamente, ma soprattutto era amato e benvoluto dalla popolazione che lo reputava un rivoluzionario benefattore e quindi lo aiutava a trovare nuovi nascondigli.
Tra il 1809 ed il 1810 mise in opera una serie di azioni sovversive per liberare il popolo dall'oppressione francese, anche se non tutte andarono a buon fine. Col tempo, la banda divenne composta da oltre duecento uomini che misero a soqquadro tutto il territorio compreso fra Medicina e Sant'Agata Bolognese.
Invase Budrio e Minerbio, non con l'intento di prenderne il controllo, ma con la speranza di alimentare focolai di ribellione e di trovare un sempre maggior numero di aderenti alla sua causa.
Assaltò la sede del Comune di Trebbo di Reno incendiando i registri ed altri documenti di contabilità e sottraendo 100 zecchini dalla cassa del Sindaco Martinelli.
Tentò anche di liberare Bologna cercando di aprire una breccia a Porta Galliera, ma poco armato e senza il consenso popolare fallì nel suo intento e fu costretto alla ritirata dall'artiglieria napoleonica e dalla Guardia Nazionale.
Occupò San Giovanni in Persiceto, lasciando andare libero un folto drappello di francesi che si erano arresi. Condusse un assalto alla caserma di Altedo, dandola alla fiamme ed ancora una volta costringendo il presidio francese a darsi alla fuga.
Sembra che lo schema dei suoi assalti fosse sempre lo stesso: in molti paesi della bassa costringeva i funzionari alla resa inducendoli a rifugiarsi entro le mura di Bologna, per poi dividere i proventi delle sue imprese nei paesi che liberava con la popolazione affamata.
Evidentemente, però, non tutti gli erano così fedeli. Nel marzo 1810, un drappello di francesi e di guardie nazionali apprese dalle imprudenti parole di una donna che Baschieri e i suoi si trovavano ospiti in una delle cascine di proprietà della famiglia Rubbini in località "Podere Malcampo", vicino a Budrio e circondò la casa.
Dopo un conflitto a fuoco che non risparmiò morti da ambo le parti, Prospero venne ferito mortalmente. La storia racconta che raccolse un pugno di terra e poi, per non finire nelle mani dei francesi, si lasciò cadere in un canale dove morì dissanguato.
I suoi nemici ne raccolsero il cadavere e come gesto simbolico verso la popolazione che lo aveva appoggiato, lo decapitarono ed esposero la sua testa conficcata in cima ad un palo sia a Budrio che a Bologna.
Col tempo, anche nei luoghi in cui le sue gesta erano diventate leggendarie, si diffuse una canzone di chiara marca propagandistica, commissionata dal regime, che venne applaudita in piazza proprio da coloro che gli erano stati più vicini:
"Traversando per il campo per voler cogli altri andare, mi mancarono le forze, non potei più camminare. E così steso per terra, senza aiuto e alcun conforto, dei nemici fui la preda e restai per sempre morto. Indi a Budrio con gran pompa fui portato con gran festa e dal popol nella piazza beffeggiata fu mia testa..."
I documenti riguardanti la Guardia Nazionale di Budrio conservati nella Biblioteca dell'Archiginnasio di Bologna lo descrivono come "un uomo irrispettoso delle leggi la cui ferocia non gli faceva risparmiare i feriti, che egli barbaramente finiva di trucidare con le stesse armi loro catturate". E poi ancora aggiungono che "grande fu in tutto il territorio bolognese il tripudio per la fine dei tre capi più funesti del brigantaggio".
La fine di Propero Baschieri è molto triste, ma lo è ancora di più il modo col quale la memoria degli eventi di cui è stato protagonista e dei motivi storici e civili che li scatenarono, è stata manipolata e trasformata.
Gli insorgenti, a partire dal 1809 si autodefinirono "patrioti" costretti a lottare con ogni mezzo contro l'invasore. Le memorie ufficiali li descrissero come dei barbari. Il popolo, volente o nolente, una volta uccisi i leader rivoluzionari, dovette accettare la versione storica e l'ideologia dei vincitori.
Forse un giorno il vento dell'insorgenza tornerà a soffiare e Prospero e tutti gli insorgenti avranno il posto che gli spetta sui libri di storia, nella memoria e nella coscienza popolare. Forse quello sarà il giorno in cui si potrà riconoscere nei moti insurrezionali del 1809 l'inizio del rapido crollo del regime napoleonico in Italia e soprattutto il primo movimento veramente popolare del Risorgimento italiano.
LA BANDA GROSSI
Con decreto ufficiale del 30/11/1860, le Marche entrarono a far parte del Regno d’Italia, con conseguente estensione a tutto il territorio della legge piemontese.
Tra le nuove leggi, quelle legate al nuovo sistema fiscale e alla leva militare obbligatoria, furono quelle che colpirono di più i cittadini; infatti la leva obbligatoria (cinque anni e sette per la cavalleria) sottraendo forze giovanili all’agricoltura, aumentava le condizioni di povertà delle famiglie contadine.
La renitenza alla leva interessò gran parte dei giovani, ed ebbe anche il sostegno del clero locale antiliberale, che in mancanza di ancora di un anagrafe ufficiale era l’unico depositario dei libri di battesimo che nascondeva o falsificava i dati. Il processo di piemontizzazione fu una della cause che alimentarono il banditismo locale, anche se esso esisteva già prima del fenomeno unitario.
Il periodo risorgimentale, però aveva suscitato aspettative civili e di riscatto per un’intera elite di cittadini, riacutizzando così fenomeni di ribellione, delinquenza e vendetta.
Il nostro territorio, di Pesaro e Urbino, fu interessato prima dalla Banda Grossi e poi dal bandito Cola (detto Fabrizi).
Questi fu ucciso a tradimento dal suo fedele compagno Pio Nazzareno Guerrini (detto Nicola di Osimo) e venne sepolto nel 1856 a Piano della Valle nei pressi di Gallo.
Il Fabrizi, che non costituì mai una vera e propria banda, operò per oltre un ventennio nelle zone del Montefeltro con azioni banditesche legate sia al contrabbando di polvere sulfurea tra il Montefeltro e San Marino, sia all’assalto di mercanti e viandanti lungo la strada Flaminia e la strada Urbinate. Luoghi centrali della banda erano: Torre (oggi Torre San Marco), Isola di Fano e Gallo.
La Banda Grossi assunse grande rilievo a cavallo dell’Unità di Italia mobilitando numerosi soldati nella zona di Gallo. Il capobanda (Terenzio Grossi), nato il 25/9/1832 a Case Nuove di Urbania, nel 1850 risultava residente a Gallo praticante il mestiere di bracciante. Il verbale di un processo del 1854 lo descrive in questo modo: “un giovine di alta statura, corporatura snella della età apparente di 22 anni circa, con capelli neri, ciglia, occhi e poca barba unita simili, naso regolare, bocca media, carnagione olivastra, e vajolato in viso, con capello di lana negro, vestito nel rimanente con panni della fornitura carceraria”.
Iniziò le sue attività di bandito con una serie di furti campestri, abigeati, rapine, evasioni dai carceri di Sant’angelo in Vado e San Leo, lasciando numerose tracce nei fascicoli processuali.
A differenza del banditismo del Cola, che agì spesso da solo, quello del Grossi può essere inserito sotto la categoria del banditismo sociale: il Grossi agiva appoggiandosi alla collaborazione dei contadini contro l’autorità costituita, combattendo le truppe del papato, sparando contro gli stemmi sabaudi, occupando paesi e contrastando carabinieri.
“La sera dell’8/1/1861 un gruppetto di finanzieri e di guardie di pubblica sicurezza stazionava nel paese di Gallo, luogo di residenza di Terenzio Grossi. I finanzieri s’erano separati dalle guardie e bevevano in un’osteria, senza le armi a portata di mano. Quando all’improvviso quel Grossi che forse non cercavano, ma al quale avrebbero voluto con la loro presenza impedire di razziare nella zona, irruppe armato in compagnia del fratello Marco nel locale.
Uno che tentò di reagire lo ferirono, gli altri vennero minacciati e consigliati di andarsene dal paese dove i Grossi vivevano, a dir loro, da galantuomini. La cosa finì in una bevuta generale, senza spari né sangue. In quei tempi l’uso di bere assieme garantiva, fra estranei, la bontà delle reciproche intenzioni; fra nemici costituiva un temporaneo e limitato trattato di pace, come accadeva infatti quella sera, per l’ultima volta tra Grossi e gli uomini dello Stato”.
Come abbiamo detto, dopo l’unificazione, l’introduzione della leva obbligatorio e l’esazione delle tasse, suscitarono tra la popolazione un notevole malcontento, provocando ribellioni diffuse, di cui il Grossi si fece in qualche modo interprete.
La banda aveva scelto come luogo di incontro una osteria a Buca Ferrara, e a seguito del malcontento popolare, attorno al Grossi si unirono altri personaggi come ad esempio Luigi e Sante Fiorentini, Antonio e Olinto Venturi (Zinzini) di Isola di Fano, Marco Grossi (fratello più giovane di Terenzio) e Biagio Olmeda di Gallo, Enrico Amantini di San Lorenzo, Giovanni Battelli (Pietraccio) e Luigi Trebbi (Cacabasso) di Montefabbri, Pietro Pandolfi di San Costanzo, Gaetano Gerboni di Colbordolo, Gaetano Rotatori di Modolfo, Baldassare Maccagli di Mercatino Conca, Giuseppe Alunni di Scapezzano, Pajno e il Bastardo di Senigallia.
Il fratello di minore di Terenzio, Marco Grossi, dopo uno scontro con i carabinieri nei pressi di Isola di Fano, il 4/3/1861 si costituisce al Sindaco di Petriano.
Un altro duro colpo alla banda Grossi fu inferto dalla resa di Baldassare Maccagli, perché costui riferì i nomi dei componenti, i luoghi di incontro e di rifugio e le persone che li nascondevano.
Le autorità cercarono di accerchiare la banda Grossi fermando ed interrogando tutte le persone che avevano avuto contatto con il Grossi.
Le testimonianze raccolte portarono all’arresto del cavatore di pietre di Gallo, Luigi Stafoggia, accusato di associazione a delinquere e connivenza con la banda Grossi. Costui, durante il processo in tribunale denunciò i propri compagni: “i suddetti quattro o cinque (Terenzio Grossi, Gaetano Gerboni, Luigi Trebbi, Giovanni Battelli, e Sante Frontini) li conosco bene per averli più volte veduti: al Gallo si presentavano sempre armati di doppietta e pistole, s’intrattenevano a mangiare e bere all’osteria della sorella del Grossi, moglie di Biagi Andrea…”.
La rete intorno al Grossi si stringeva progressivamente e ad un certo punto gli si fece capire che gli sarebbe stato concesso un aiuto se si fosse allontanato dalla zona e avesse denunciato i compagni. L’offerta fu rifiutata dal Grossi ed iniziarono cosi una serie di vendette: all’Osteria di Buca Ferrara fu ucciso Biagio Olmeda, in circostanza non del tutto chiare; durante tale omicidio il Grossi fu ferito gravemente ad una mano ed iniziò a vagare da un casolare all’altro, insieme al compagno Frontini, in cerca di protezione. I carabinieri erano sulle sue tracce e oramai gli erano vicini.
Il Grossi ad un certo punto volle ritornare al Gallo, ma lungo il sentiero verso Caspessa nei pressi di Isola di Fano, il fedele compagno (fino a quel momento) Frontini lo colpì alla testa con due colpi di pistola. Questi sperava di rimanere impunito grazie a questo tradimento; in realtà fu l’unico condannato a morte durante il processo che si svolse contro di lui e contro gli altri componenti della banda.
La scheda personale, risultante dagli atti del processo recita: “Frontini Sante di Domenico soprannominato Pipetta (nella Valle del Foglia), d’anni 25, scapolo, calzolaio, nato e domiciliato a Isola di Fano, mandamento di Fossombrone, nulla tenente analfabeta arrestato il 1/10/1862”.
Frontini venne ghigliottinato fuori Porta Sale a Pesaro il 25/10/1864.
Terminarono così le vicende di una Banda che durante gli anni della sua vita (dal 10/6/1860 al 15/9/1862), caratterizzò per anni la frazione di Gallo.
Secondo i documenti dell’epoca, la Banda Grossi commise: 78 grassazioni (furti a mano armata) 5 assassini, 12 omicidi, 23 ferimenti, 2 stupri violenti, 8 estorsioni, 6 mancate grassazioni.
Del resto, in un territorio come quello di Gallo e della vicina Montefabbri, con una ingente popolazione di braccianti, era piuttosto diffusa la delinquenza ed erano da considerarsi frequenti casi di furti o rapine, come la rapina avvenuta nella notte tra il 27 e 28/8/1863 in località di Calabalia dove diversi briganti (si sospettò del Gallo) rapinarono ben 25 viandanti con un bottino complessivo di ben 958,52 lire.
Non è un caso che i carabinieri fino al 1898 avessero una caserma a Cappone e solo dopo la sostassero a Colbordolo, quando le scorribande brigantesche erano orami terminate.
319 yerel halk öneriyor
Urbino
LA BANDA GROSSI
Con decreto ufficiale del 30/11/1860, le Marche entrarono a far parte del Regno d’Italia, con conseguente estensione a tutto il territorio della legge piemontese.
Tra le nuove leggi, quelle legate al nuovo sistema fiscale e alla leva militare obbligatoria, furono quelle che colpirono di più i cittadini; infatti la leva obbligatoria (cinque anni e sette per la cavalleria) sottraendo forze giovanili all’agricoltura, aumentava le condizioni di povertà delle famiglie contadine.
La renitenza alla leva interessò gran parte dei giovani, ed ebbe anche il sostegno del clero locale antiliberale, che in mancanza di ancora di un anagrafe ufficiale era l’unico depositario dei libri di battesimo che nascondeva o falsificava i dati. Il processo di piemontizzazione fu una della cause che alimentarono il banditismo locale, anche se esso esisteva già prima del fenomeno unitario.
Il periodo risorgimentale, però aveva suscitato aspettative civili e di riscatto per un’intera elite di cittadini, riacutizzando così fenomeni di ribellione, delinquenza e vendetta.
Il nostro territorio, di Pesaro e Urbino, fu interessato prima dalla Banda Grossi e poi dal bandito Cola (detto Fabrizi).
Questi fu ucciso a tradimento dal suo fedele compagno Pio Nazzareno Guerrini (detto Nicola di Osimo) e venne sepolto nel 1856 a Piano della Valle nei pressi di Gallo.
Il Fabrizi, che non costituì mai una vera e propria banda, operò per oltre un ventennio nelle zone del Montefeltro con azioni banditesche legate sia al contrabbando di polvere sulfurea tra il Montefeltro e San Marino, sia all’assalto di mercanti e viandanti lungo la strada Flaminia e la strada Urbinate. Luoghi centrali della banda erano: Torre (oggi Torre San Marco), Isola di Fano e Gallo.
La Banda Grossi assunse grande rilievo a cavallo dell’Unità di Italia mobilitando numerosi soldati nella zona di Gallo. Il capobanda (Terenzio Grossi), nato il 25/9/1832 a Case Nuove di Urbania, nel 1850 risultava residente a Gallo praticante il mestiere di bracciante. Il verbale di un processo del 1854 lo descrive in questo modo: “un giovine di alta statura, corporatura snella della età apparente di 22 anni circa, con capelli neri, ciglia, occhi e poca barba unita simili, naso regolare, bocca media, carnagione olivastra, e vajolato in viso, con capello di lana negro, vestito nel rimanente con panni della fornitura carceraria”.
Iniziò le sue attività di bandito con una serie di furti campestri, abigeati, rapine, evasioni dai carceri di Sant’angelo in Vado e San Leo, lasciando numerose tracce nei fascicoli processuali.
A differenza del banditismo del Cola, che agì spesso da solo, quello del Grossi può essere inserito sotto la categoria del banditismo sociale: il Grossi agiva appoggiandosi alla collaborazione dei contadini contro l’autorità costituita, combattendo le truppe del papato, sparando contro gli stemmi sabaudi, occupando paesi e contrastando carabinieri.
“La sera dell’8/1/1861 un gruppetto di finanzieri e di guardie di pubblica sicurezza stazionava nel paese di Gallo, luogo di residenza di Terenzio Grossi. I finanzieri s’erano separati dalle guardie e bevevano in un’osteria, senza le armi a portata di mano. Quando all’improvviso quel Grossi che forse non cercavano, ma al quale avrebbero voluto con la loro presenza impedire di razziare nella zona, irruppe armato in compagnia del fratello Marco nel locale.
Uno che tentò di reagire lo ferirono, gli altri vennero minacciati e consigliati di andarsene dal paese dove i Grossi vivevano, a dir loro, da galantuomini. La cosa finì in una bevuta generale, senza spari né sangue. In quei tempi l’uso di bere assieme garantiva, fra estranei, la bontà delle reciproche intenzioni; fra nemici costituiva un temporaneo e limitato trattato di pace, come accadeva infatti quella sera, per l’ultima volta tra Grossi e gli uomini dello Stato”.
Come abbiamo detto, dopo l’unificazione, l’introduzione della leva obbligatorio e l’esazione delle tasse, suscitarono tra la popolazione un notevole malcontento, provocando ribellioni diffuse, di cui il Grossi si fece in qualche modo interprete.
La banda aveva scelto come luogo di incontro una osteria a Buca Ferrara, e a seguito del malcontento popolare, attorno al Grossi si unirono altri personaggi come ad esempio Luigi e Sante Fiorentini, Antonio e Olinto Venturi (Zinzini) di Isola di Fano, Marco Grossi (fratello più giovane di Terenzio) e Biagio Olmeda di Gallo, Enrico Amantini di San Lorenzo, Giovanni Battelli (Pietraccio) e Luigi Trebbi (Cacabasso) di Montefabbri, Pietro Pandolfi di San Costanzo, Gaetano Gerboni di Colbordolo, Gaetano Rotatori di Modolfo, Baldassare Maccagli di Mercatino Conca, Giuseppe Alunni di Scapezzano, Pajno e il Bastardo di Senigallia.
Il fratello di minore di Terenzio, Marco Grossi, dopo uno scontro con i carabinieri nei pressi di Isola di Fano, il 4/3/1861 si costituisce al Sindaco di Petriano.
Un altro duro colpo alla banda Grossi fu inferto dalla resa di Baldassare Maccagli, perché costui riferì i nomi dei componenti, i luoghi di incontro e di rifugio e le persone che li nascondevano.
Le autorità cercarono di accerchiare la banda Grossi fermando ed interrogando tutte le persone che avevano avuto contatto con il Grossi.
Le testimonianze raccolte portarono all’arresto del cavatore di pietre di Gallo, Luigi Stafoggia, accusato di associazione a delinquere e connivenza con la banda Grossi. Costui, durante il processo in tribunale denunciò i propri compagni: “i suddetti quattro o cinque (Terenzio Grossi, Gaetano Gerboni, Luigi Trebbi, Giovanni Battelli, e Sante Frontini) li conosco bene per averli più volte veduti: al Gallo si presentavano sempre armati di doppietta e pistole, s’intrattenevano a mangiare e bere all’osteria della sorella del Grossi, moglie di Biagi Andrea…”.
La rete intorno al Grossi si stringeva progressivamente e ad un certo punto gli si fece capire che gli sarebbe stato concesso un aiuto se si fosse allontanato dalla zona e avesse denunciato i compagni. L’offerta fu rifiutata dal Grossi ed iniziarono cosi una serie di vendette: all’Osteria di Buca Ferrara fu ucciso Biagio Olmeda, in circostanza non del tutto chiare; durante tale omicidio il Grossi fu ferito gravemente ad una mano ed iniziò a vagare da un casolare all’altro, insieme al compagno Frontini, in cerca di protezione. I carabinieri erano sulle sue tracce e oramai gli erano vicini.
Il Grossi ad un certo punto volle ritornare al Gallo, ma lungo il sentiero verso Caspessa nei pressi di Isola di Fano, il fedele compagno (fino a quel momento) Frontini lo colpì alla testa con due colpi di pistola. Questi sperava di rimanere impunito grazie a questo tradimento; in realtà fu l’unico condannato a morte durante il processo che si svolse contro di lui e contro gli altri componenti della banda.
La scheda personale, risultante dagli atti del processo recita: “Frontini Sante di Domenico soprannominato Pipetta (nella Valle del Foglia), d’anni 25, scapolo, calzolaio, nato e domiciliato a Isola di Fano, mandamento di Fossombrone, nulla tenente analfabeta arrestato il 1/10/1862”.
Frontini venne ghigliottinato fuori Porta Sale a Pesaro il 25/10/1864.
Terminarono così le vicende di una Banda che durante gli anni della sua vita (dal 10/6/1860 al 15/9/1862), caratterizzò per anni la frazione di Gallo.
Secondo i documenti dell’epoca, la Banda Grossi commise: 78 grassazioni (furti a mano armata) 5 assassini, 12 omicidi, 23 ferimenti, 2 stupri violenti, 8 estorsioni, 6 mancate grassazioni.
Del resto, in un territorio come quello di Gallo e della vicina Montefabbri, con una ingente popolazione di braccianti, era piuttosto diffusa la delinquenza ed erano da considerarsi frequenti casi di furti o rapine, come la rapina avvenuta nella notte tra il 27 e 28/8/1863 in località di Calabalia dove diversi briganti (si sospettò del Gallo) rapinarono ben 25 viandanti con un bottino complessivo di ben 958,52 lire.
Non è un caso che i carabinieri fino al 1898 avessero una caserma a Cappone e solo dopo la sostassero a Colbordolo, quando le scorribande brigantesche erano orami terminate.
Il bandito Cola (detto Fabrizi).
Questi fu ucciso a tradimento dal suo fedele compagno Pio Nazzareno Guerrini (detto Nicola di Osimo) e venne sepolto nel 1856 a Piano della Valle nei pressi di Gallo.
Il Fabrizi, che non costituì mai una vera e propria banda, operò per oltre un ventennio nelle zone del Montefeltro con azioni banditesche legate sia al contrabbando di polvere sulfurea tra il Montefeltro e San Marino, sia all’assalto di mercanti e viandanti lungo la strada Flaminia e la strada Urbinate. Luoghi centrali della banda erano: Torre (oggi Torre San Marco), Isola di Fano e Gallo.
Montefeltro station
Il bandito Cola (detto Fabrizi).
Questi fu ucciso a tradimento dal suo fedele compagno Pio Nazzareno Guerrini (detto Nicola di Osimo) e venne sepolto nel 1856 a Piano della Valle nei pressi di Gallo.
Il Fabrizi, che non costituì mai una vera e propria banda, operò per oltre un ventennio nelle zone del Montefeltro con azioni banditesche legate sia al contrabbando di polvere sulfurea tra il Montefeltro e San Marino, sia all’assalto di mercanti e viandanti lungo la strada Flaminia e la strada Urbinate. Luoghi centrali della banda erano: Torre (oggi Torre San Marco), Isola di Fano e Gallo.
Giuseppe Afflitti, l’ultimo luogotenente del Passatore
Quando si sente parlare di briganti romagnoli il pensiero corre immediatamente alle numerose imprese di Stefano Pelloni, che a partire dal 1847 con una nutrita e variegata schiera di malviventi seminò il terrore nelle legazioni romagnole e nei territori limitrofi tanto da far lievitare fino a 3000 scudi la taglia posta dal governo pontificio sul Passatore che verrà catturato e ucciso nei pressi di Russi il 23/3/1851.
Dell’orda di scellerati che incetta e spinge al delitto il contumace Stefano Pelloni, detto il Passatore, fecero parte:
- il birocciaio di Toscanella Francesco Babini, detto il sanguinario Mattiazza per la ferocia senza limiti rivelata in alcune azioni,
- Giuseppe Tasselli, detto Giazzolo, il fedele compagno fino alla morte del capo,
- i tre delatori che ebbero la pena capitale commutata in vari anni di galera per aver contribuito con le loro confessioni a smantellare la banda:
• Giacomo Emaldi detto Lamelda di Fusignano,
• Antonio Farina soprannominato Dumandone,
• il forlivese Gaetano Morgagni detto Fagotto,
- lo stesso Teggione ovvero Tomaso Montini, arrestato cominciò a confessare, ma riuscì solo a ritardare la fucilazione.
Altri gregari della banda furono: Giuseppe Golfieri di Masiera, detto lo Scalzo, e Antonio Basili di Boncellino, chiamato Basèi, ambedue partecipanti all’invasione di Cotignola, catturati e fucilati nel foro boario di Faenza nel 1850, il cotignolese Giacomo Bedeschi detto Maraffini, il fusignanese Giuseppe Poli chiamato Faffino o Pastorello, Francesco Saporetti di Villanova di Bagnacavallo soprannominato il Rizzone, anch’essi partecipanti all’occupazione di Cotignola, ma fucilati a Bologna.
Altri membri della banda puniti con la fucilazione furono: Giacomo Drei, detto il Gobbo e Giacomo Cantoni detto Corneli di Cesena, Federico Cantagalli di Bizzuno detto Galletto, il faentino Giuseppe Prati detto Moro di Scaletta, Paolo Versari di S. Savino detto Sboraccino, Leonardo Garda di Castel S. Pietro chiamato Schivafumo, Giovanni Drudi di Montiano detto Bastianello, il forlivese Angelo Lama detto Lisagna, Felice Scheda chiamato Anguillone o anche Magnabisce e qualche altro.
Una masnada di una ventina di delinquenti in servizio permanente cui si aggiungevano gli avventizi o grattoni che si prestavano per qualche impresa, tutti sostenuti da una folta schiera di manutengoli, di spie e dritte che assicuravano informazioni, asilo, e vettovaglie dietro congrua ricompensa.
Alcuni luoghi di ritrovo o di asilo sono diventati celebri, come la casa dei piatti (Cà Nòva) in Urbiano di Brisighella perché vi fu architettata l’invasione di Forlimpopoli.
Dopo la morte del famigerato brigante di Boncellino, tra i pochi superstiti della banda rimase Giuseppe Afflitti, detto Lazzarino, un pluripregiudicato, scampato agli arresti e alle condanne dei gregari, che si ritirò in montagna per qualche anno a fare il garzone presso un contadino per sottrarsi alle insistenti ricerche delle guardie.
Forse annoiato da quell’esistenza grama e monotona, si affacciò di nuovo sulla scena attratto dal fascino dell’avventura e del pericolo formando nel 1854 una nuova banda, denominata quella di Lazzarino, alla quale si associarono ben presto due delinquenti già noti come Valentino Bignami di Budrio, detto Cunino e il lughese Federone, ovvero Federico Caravita.
Questa banda infestava la Romagna ed il territorio limitrofo del Granducato di Toscana e pei suoi misfatti immerse ben presto quei luoghi nel terrore e nello spavento, tanto che il governo pontificio ricorse ad una taglia di 3000 scudi anche per l’Afflitti e di 500 per il Bignami per porre fine ai numerosi delitti della feroce masnada che verrà decapitata e dispersa con la cattura definitiva dei capi in terra toscana e la loro fucilazione a Bologna l’8/5/1857.
La notificazione firmata dal conte Degenfeld-Schonburg emessa il giorno stesso dell’esecuzione traccia un profilo sommario del brigante romagnolo più longevo e più esperto per azioni delittuose, anche se meno famoso rispetto al Passatore, nello stesso tempo descrive le fasi principali del curriculum criminale del brigante fucilato.
Soprannominato Lazzarino, ma secondo alcuni anche Cavrèna, per l’aspetto caprino del volto, oppure Camminazzo, per il passo lungo e svelto.
Giuseppe Afflitti era nato a Cantalupo nel territorio Imolese nel 1820, dove aveva svolto il mestiere di contadino fino ai vent’anni, si era sposato ma non aveva avuto figli.
La carriera criminale di Lazzarino comincia con una rapina ai danni di alcuni contadini di Croce Coperta nel 1840.
Varie volte inquisito per furto, rapina e ferimento, solo nel 1849 si aggrega alla masnada del Passatore con la quale parteciperà alle invasioni di Brisighella, di Longiano e di Forlimpopoli, imprese che fruttarono un bottino di 6510 scudi la prima, 6632 scudi la seconda e 5611 scudi la terza e una fama sinistra ai briganti che in qualche caso inflissero inutili sevizie alle vittime o trucidarono i malcapitati.
Assente il Passatore, l’Afflitti guidò la banda nell’invasione di Consandolo che fruttò oltre 1200 scudi, all’assalto della diligenza postale della linea Bologna-Ferrara nei pressi di Altedo, che procurò un bottino di 1100 scudi ricavati dalla cassaforte e dai preziosi sottratti ai dieci viaggiatori sbigottiti.
Il mese successivo 23/9/1850 la rapina è ripetuta nell’assalto alla diligenza pontificia di Roma nei pressi di Santarcangelo: dodici briganti minacciano di morte i viaggiatori e il postiglione, li derubano e forzano la cassaforte asportando 2000 scudi.
Seguono alcune grassazioni di minore rilievo. In seguito alla cattura del Passatore l’attività criminale di Lazzarino si dirada poi si interrompe per riprendere con una serie di azioni delittuose che “anche se non ebbero la fortuna di essere celebrate da poeti e romanzieri, sono da ritenersi fra le più notevoli di quel periodo”: rapina di scudi 3800 ai possidenti Vincenzo e Luigi Frontini di Monterenzio presso Loiano, rapina di scudi 2527,83 ai danni di dodici mercanti nei pressi di Bocconi in Comune di Portico, rapina di oltre 1000 scudi a Stefano Guercioli di Dovadola, di scudi 2023, 25 rapinati a nove individui alloggiati in alcune locande di Specchio, Ponticino e Carbonile (nel territorio granducale), di scudi 1320 rapinati ad alcuni possidenti di Monte Poggiolo, invasione della tenuta La Bruciata del conte F. Massari e irruzione nella chiesa di Campanile durante la messa con il sequestro di persone e ripetute rapine ai danni dei fedeli e di alcuni viaggiatori lungo la strada per Bologna, compreso un nobile francese derubato e assassinato.
Il rapimento di monsignor Dionisio dei conti Ginnasi sulla strada del Rio Sanguinario con richiesta di riscatto di 6000 scudi e del possidente Antonio Rampi per scudi 3000 nei pressi di Felisio.
A 37 anni finiva davanti a un plotone di esecuzione la vita di Giuseppe Afflitti, detto Lazzarino, che per ben 17 anni aveva dato scacco alla polizia austriaca, pontificia e granducale, aveva organizzato una trentina di grosse rapine ed assassinato mezza dozzina di persone.
8 yerel halk öneriyor
Russi
Giuseppe Afflitti, l’ultimo luogotenente del Passatore
Quando si sente parlare di briganti romagnoli il pensiero corre immediatamente alle numerose imprese di Stefano Pelloni, che a partire dal 1847 con una nutrita e variegata schiera di malviventi seminò il terrore nelle legazioni romagnole e nei territori limitrofi tanto da far lievitare fino a 3000 scudi la taglia posta dal governo pontificio sul Passatore che verrà catturato e ucciso nei pressi di Russi il 23/3/1851.
Dell’orda di scellerati che incetta e spinge al delitto il contumace Stefano Pelloni, detto il Passatore, fecero parte:
- il birocciaio di Toscanella Francesco Babini, detto il sanguinario Mattiazza per la ferocia senza limiti rivelata in alcune azioni,
- Giuseppe Tasselli, detto Giazzolo, il fedele compagno fino alla morte del capo,
- i tre delatori che ebbero la pena capitale commutata in vari anni di galera per aver contribuito con le loro confessioni a smantellare la banda:
• Giacomo Emaldi detto Lamelda di Fusignano,
• Antonio Farina soprannominato Dumandone,
• il forlivese Gaetano Morgagni detto Fagotto,
- lo stesso Teggione ovvero Tomaso Montini, arrestato cominciò a confessare, ma riuscì solo a ritardare la fucilazione.
Altri gregari della banda furono: Giuseppe Golfieri di Masiera, detto lo Scalzo, e Antonio Basili di Boncellino, chiamato Basèi, ambedue partecipanti all’invasione di Cotignola, catturati e fucilati nel foro boario di Faenza nel 1850, il cotignolese Giacomo Bedeschi detto Maraffini, il fusignanese Giuseppe Poli chiamato Faffino o Pastorello, Francesco Saporetti di Villanova di Bagnacavallo soprannominato il Rizzone, anch’essi partecipanti all’occupazione di Cotignola, ma fucilati a Bologna.
Altri membri della banda puniti con la fucilazione furono: Giacomo Drei, detto il Gobbo e Giacomo Cantoni detto Corneli di Cesena, Federico Cantagalli di Bizzuno detto Galletto, il faentino Giuseppe Prati detto Moro di Scaletta, Paolo Versari di S. Savino detto Sboraccino, Leonardo Garda di Castel S. Pietro chiamato Schivafumo, Giovanni Drudi di Montiano detto Bastianello, il forlivese Angelo Lama detto Lisagna, Felice Scheda chiamato Anguillone o anche Magnabisce e qualche altro.
Una masnada di una ventina di delinquenti in servizio permanente cui si aggiungevano gli avventizi o grattoni che si prestavano per qualche impresa, tutti sostenuti da una folta schiera di manutengoli, di spie e dritte che assicuravano informazioni, asilo, e vettovaglie dietro congrua ricompensa.
Alcuni luoghi di ritrovo o di asilo sono diventati celebri, come la casa dei piatti (Cà Nòva) in Urbiano di Brisighella perché vi fu architettata l’invasione di Forlimpopoli.
Dopo la morte del famigerato brigante di Boncellino, tra i pochi superstiti della banda rimase Giuseppe Afflitti, detto Lazzarino, un pluripregiudicato, scampato agli arresti e alle condanne dei gregari, che si ritirò in montagna per qualche anno a fare il garzone presso un contadino per sottrarsi alle insistenti ricerche delle guardie.
Forse annoiato da quell’esistenza grama e monotona, si affacciò di nuovo sulla scena attratto dal fascino dell’avventura e del pericolo formando nel 1854 una nuova banda, denominata quella di Lazzarino, alla quale si associarono ben presto due delinquenti già noti come Valentino Bignami di Budrio, detto Cunino e il lughese Federone, ovvero Federico Caravita.
Questa banda infestava la Romagna ed il territorio limitrofo del Granducato di Toscana e pei suoi misfatti immerse ben presto quei luoghi nel terrore e nello spavento, tanto che il governo pontificio ricorse ad una taglia di 3000 scudi anche per l’Afflitti e di 500 per il Bignami per porre fine ai numerosi delitti della feroce masnada che verrà decapitata e dispersa con la cattura definitiva dei capi in terra toscana e la loro fucilazione a Bologna l’8/5/1857.
La notificazione firmata dal conte Degenfeld-Schonburg emessa il giorno stesso dell’esecuzione traccia un profilo sommario del brigante romagnolo più longevo e più esperto per azioni delittuose, anche se meno famoso rispetto al Passatore, nello stesso tempo descrive le fasi principali del curriculum criminale del brigante fucilato.
Soprannominato Lazzarino, ma secondo alcuni anche Cavrèna, per l’aspetto caprino del volto, oppure Camminazzo, per il passo lungo e svelto.
Giuseppe Afflitti era nato a Cantalupo nel territorio Imolese nel 1820, dove aveva svolto il mestiere di contadino fino ai vent’anni, si era sposato ma non aveva avuto figli.
La carriera criminale di Lazzarino comincia con una rapina ai danni di alcuni contadini di Croce Coperta nel 1840.
Varie volte inquisito per furto, rapina e ferimento, solo nel 1849 si aggrega alla masnada del Passatore con la quale parteciperà alle invasioni di Brisighella, di Longiano e di Forlimpopoli, imprese che fruttarono un bottino di 6510 scudi la prima, 6632 scudi la seconda e 5611 scudi la terza e una fama sinistra ai briganti che in qualche caso inflissero inutili sevizie alle vittime o trucidarono i malcapitati.
Assente il Passatore, l’Afflitti guidò la banda nell’invasione di Consandolo che fruttò oltre 1200 scudi, all’assalto della diligenza postale della linea Bologna-Ferrara nei pressi di Altedo, che procurò un bottino di 1100 scudi ricavati dalla cassaforte e dai preziosi sottratti ai dieci viaggiatori sbigottiti.
Il mese successivo 23/9/1850 la rapina è ripetuta nell’assalto alla diligenza pontificia di Roma nei pressi di Santarcangelo: dodici briganti minacciano di morte i viaggiatori e il postiglione, li derubano e forzano la cassaforte asportando 2000 scudi.
Seguono alcune grassazioni di minore rilievo. In seguito alla cattura del Passatore l’attività criminale di Lazzarino si dirada poi si interrompe per riprendere con una serie di azioni delittuose che “anche se non ebbero la fortuna di essere celebrate da poeti e romanzieri, sono da ritenersi fra le più notevoli di quel periodo”: rapina di scudi 3800 ai possidenti Vincenzo e Luigi Frontini di Monterenzio presso Loiano, rapina di scudi 2527,83 ai danni di dodici mercanti nei pressi di Bocconi in Comune di Portico, rapina di oltre 1000 scudi a Stefano Guercioli di Dovadola, di scudi 2023, 25 rapinati a nove individui alloggiati in alcune locande di Specchio, Ponticino e Carbonile (nel territorio granducale), di scudi 1320 rapinati ad alcuni possidenti di Monte Poggiolo, invasione della tenuta La Bruciata del conte F. Massari e irruzione nella chiesa di Campanile durante la messa con il sequestro di persone e ripetute rapine ai danni dei fedeli e di alcuni viaggiatori lungo la strada per Bologna, compreso un nobile francese derubato e assassinato.
Il rapimento di monsignor Dionisio dei conti Ginnasi sulla strada del Rio Sanguinario con richiesta di riscatto di 6000 scudi e del possidente Antonio Rampi per scudi 3000 nei pressi di Felisio.
A 37 anni finiva davanti a un plotone di esecuzione la vita di Giuseppe Afflitti, detto Lazzarino, che per ben 17 anni aveva dato scacco alla polizia austriaca, pontificia e granducale, aveva organizzato una trentina di grosse rapine ed assassinato mezza dozzina di persone.
Castellani nella banda del Passatore
Storia
Sulla vita e sulle imprese di Stefano Pelloni, “il Passatore”, molto è stato scritto e molto si è favoleggiato. Ancor oggi la sua popolarità è molto alta in Romagna. Del Passatore si è narrato tutto ed il contrario di tutto. C’è stato chi l’ha definito perverso e bestiale ed altri che ne hanno cantato le gesta elevandolo al rango di un mito.
La sua cortesia fu cantata anche da Giovanni Pascoli. Di certo non è errato dire che per più di due anni, dal 1849 al 1851, dominò i paesi delle Legazioni, cioè le province di Bologna, Forlì, Ravenna e Ferrara, sconfinando all’occasione anche nel Granducato di Toscana, tenendo in scacco sia il governo austriaco che quello pontificio. Ciò potrebbe sembrare inverosimile, ma nei fatti invase e saccheggiò sette cittadine, derubò un numero elevatissimo di persone, ne uccise almeno otto, diede l’assalto diverse volte alla diligenza dello Stato Pontificio con tanto di scorta ed organizzò e diresse una banda di svariate decine di banditi.
Fra i componenti della banda del Passatore vi erano alcuni cittadini di Castel Bolognese:
1) Giuseppe Zanelli, detto Cesarino, “giovinotto di 23-24 anni, piccolo di statura, imberbe, di occhi castagni chiari, di bel colorito e buona carnagione”;
2) Domenico Sabbatani, detto Ghigno o Ghignone;
3) Giuseppe Serantini, detto Falcone;
4) Giacomo Drei, detto della Rosa.
Essi presero parte alla invasione dei paesi di Consandolo (25/1/1850), Longiano (28/5/1850), Brisighella (7/2/1850) e Cotignola (18/1/1850).
Il Drei aveva partecipato all’impresa contro la canonica di S. Andrea Dio la Guardia di Cesena, la sera del 5/1/1850, usando gravi sevizie contro il parroco don Antonio Fusaroli.
Giuseppe Serantini, figlio di Luigi Giacomo, di anni 24 e Giacomo Drei, figlio di Sante, di anni 31, furono condannati a morte “a iudicio statario militari austriaco”, assieme Carlo Mercatelli fu Francesco di Fognano (o Limisano?) e furono fucilati a Castel Bolognese il 1/5/1852 alle 2 del pomeriggio. Il giudizio statario era celebrato direttamente “sul posto” e quindi la procedura era sommaria.
Ecco la cronaca della fucilazione che Don Gamberini riporta nel suo diario (conservato nell’Archivio parrocchiale di San Petronio):
“Furono in quest’anno condannati alla fucilazione dal giudizio Statuario Militare Austriaco Carlo Mercatelli della Parrocchia di Limisano, Giacomo Drei del Giardino e Giuseppe Serantini d’anni 24 di questa Parrocchia e fu eseguita la sentenza di morte di tutti e tre in una volta il giorno 1.5 alle 2 ¼ pomeridiane nella fossa di questo Castello dirimpetto al vecchio Cimitero di Santa Croce dai Tedeschi. Essi vennero qui tradotti dalle Carceri d’Imola accompagnati da tre PP. Cappuccini, dopo averli colà sacramentati, e confortati e li assistettero fin all’ultimo. Qui si fecero prima le Agonie nel Suffragio, nelle Monache, in San Francesco e qui in Parrocchia ed appena eseguita la fucilazione andò il clero e fatte le esequie accompagnò i tre cadaveri al Cimitero, ove furono sepolti”.
Non andò meglio a Giuseppe Zanelli, il Cesarino, che fu ucciso da una scarica dei gendarmi nel luglio 1853. Rimasto ferito in un primo scontro, fu caricato dai compagni su un cavallo e trasportato verso Marradi. Durante l’inseguimento fu nuovamente colpito, questa volta a morte.
La banda del Passatore a Castel Bolognese trovava alloggio presso la famiglia di Giuseppe Silvestrini del fondo Nardina, il quale ricettava gli ori e la refurtiva della banda; nella casa di Francesco e Mariano Montevecchi, detti Innocentone, mercanti di bestiame; presso la famiglia dei fratelli Fichi; in casa di Giuseppe Bacchilega, detto Delogazzo di Borello.
Un’altra curiosità che lega il Passatore a Castel Bolognese è stata recentemente raccontata a Sette Sere da Giovanna Carroli, custode del Mulino di Scodellino dal 1938 al 1998. Racconta Giovanna che a metà ‘800 a fare il mugnaio era il capo della Guardia Civica di Castello. Di notte perlustrava la strade per difendere la popolazione dai briganti. La guardia andava dicendo che se avesse incontrato il Passatore lo avrebbe ucciso. La voce arrivò alle orecchie del famoso brigante. Un giorno l’uomo si sposò nella chiesa di San Petronio e lasciò un suo amico fidato a guardia del Mulino. Questi vide più volte il Passatore aggirarsi nelle campagne circostanti e lo riferì al mugnaio. Saputo il fatto, questi si trasferì a Firenze e non fece più ritorno a Castel Bolognese.
Il Passatore, nato a Boncellino il 24/8/1824, fu ucciso in uno scontro a fuoco con i papalini il 23/3/1851. Il suo cadavere fu messo su un birroccio e portato in giro in tutta la Romagna, perchè tutti lo vedessero.
A Castel Bolognese il carro sostò sulla via Emilia di fronte all’attuale sede della Banca di Romagna. Alla scena assistette Oliva Diversi, la nonna dello scrittore castellano Francesco Serantini, che del Passatore fu il più famoso storico (si veda a tal proposito il volume “Fatti memorabili della banda del Passatore in terra di Romagna”, pubblicato a Faenza nel 1929).
Serantini evocò con documentata verità,
ma anche con paterna indulgenza, vita, imprese e morte di Stefano Pelloni, a lui legato per sempre e che quasi sicuramente aveva imparato a conoscere fin da bambino, grazie ai racconti di nonna Oliva.
Morto il Passatore, il resto della banda agiva diretta da Giuseppe Afflitti, detto Lazzarino.
Il 10/10/1854 la banda del Lazzarino tentò un colpo a Castel Bolognese entrando nell’abitazione del possidente Francesco Gottarelli e appropriandosi di 423 scudi. Il garzone del Gottarelli, Giovanni Mingazzini, riuscì, inosservato, ad avvertire i gendarmi castellani i quali costrinsero la banda a fuggire. Nello scontro rimasero però feriti i gendarmi Giuseppe Stornini e Francesco Casadio, mentre il Gottarelli, rimasto pure gravemente ferito, morì pochi giorni dopo.
6 yerel halk öneriyor
Castel Bolognese
Castellani nella banda del Passatore
Storia
Sulla vita e sulle imprese di Stefano Pelloni, “il Passatore”, molto è stato scritto e molto si è favoleggiato. Ancor oggi la sua popolarità è molto alta in Romagna. Del Passatore si è narrato tutto ed il contrario di tutto. C’è stato chi l’ha definito perverso e bestiale ed altri che ne hanno cantato le gesta elevandolo al rango di un mito.
La sua cortesia fu cantata anche da Giovanni Pascoli. Di certo non è errato dire che per più di due anni, dal 1849 al 1851, dominò i paesi delle Legazioni, cioè le province di Bologna, Forlì, Ravenna e Ferrara, sconfinando all’occasione anche nel Granducato di Toscana, tenendo in scacco sia il governo austriaco che quello pontificio. Ciò potrebbe sembrare inverosimile, ma nei fatti invase e saccheggiò sette cittadine, derubò un numero elevatissimo di persone, ne uccise almeno otto, diede l’assalto diverse volte alla diligenza dello Stato Pontificio con tanto di scorta ed organizzò e diresse una banda di svariate decine di banditi.
Fra i componenti della banda del Passatore vi erano alcuni cittadini di Castel Bolognese:
1) Giuseppe Zanelli, detto Cesarino, “giovinotto di 23-24 anni, piccolo di statura, imberbe, di occhi castagni chiari, di bel colorito e buona carnagione”;
2) Domenico Sabbatani, detto Ghigno o Ghignone;
3) Giuseppe Serantini, detto Falcone;
4) Giacomo Drei, detto della Rosa.
Essi presero parte alla invasione dei paesi di Consandolo (25/1/1850), Longiano (28/5/1850), Brisighella (7/2/1850) e Cotignola (18/1/1850).
Il Drei aveva partecipato all’impresa contro la canonica di S. Andrea Dio la Guardia di Cesena, la sera del 5/1/1850, usando gravi sevizie contro il parroco don Antonio Fusaroli.
Giuseppe Serantini, figlio di Luigi Giacomo, di anni 24 e Giacomo Drei, figlio di Sante, di anni 31, furono condannati a morte “a iudicio statario militari austriaco”, assieme Carlo Mercatelli fu Francesco di Fognano (o Limisano?) e furono fucilati a Castel Bolognese il 1/5/1852 alle 2 del pomeriggio. Il giudizio statario era celebrato direttamente “sul posto” e quindi la procedura era sommaria.
Ecco la cronaca della fucilazione che Don Gamberini riporta nel suo diario (conservato nell’Archivio parrocchiale di San Petronio):
“Furono in quest’anno condannati alla fucilazione dal giudizio Statuario Militare Austriaco Carlo Mercatelli della Parrocchia di Limisano, Giacomo Drei del Giardino e Giuseppe Serantini d’anni 24 di questa Parrocchia e fu eseguita la sentenza di morte di tutti e tre in una volta il giorno 1.5 alle 2 ¼ pomeridiane nella fossa di questo Castello dirimpetto al vecchio Cimitero di Santa Croce dai Tedeschi. Essi vennero qui tradotti dalle Carceri d’Imola accompagnati da tre PP. Cappuccini, dopo averli colà sacramentati, e confortati e li assistettero fin all’ultimo. Qui si fecero prima le Agonie nel Suffragio, nelle Monache, in San Francesco e qui in Parrocchia ed appena eseguita la fucilazione andò il clero e fatte le esequie accompagnò i tre cadaveri al Cimitero, ove furono sepolti”.
Non andò meglio a Giuseppe Zanelli, il Cesarino, che fu ucciso da una scarica dei gendarmi nel luglio 1853. Rimasto ferito in un primo scontro, fu caricato dai compagni su un cavallo e trasportato verso Marradi. Durante l’inseguimento fu nuovamente colpito, questa volta a morte.
La banda del Passatore a Castel Bolognese trovava alloggio presso la famiglia di Giuseppe Silvestrini del fondo Nardina, il quale ricettava gli ori e la refurtiva della banda; nella casa di Francesco e Mariano Montevecchi, detti Innocentone, mercanti di bestiame; presso la famiglia dei fratelli Fichi; in casa di Giuseppe Bacchilega, detto Delogazzo di Borello.
Un’altra curiosità che lega il Passatore a Castel Bolognese è stata recentemente raccontata a Sette Sere da Giovanna Carroli, custode del Mulino di Scodellino dal 1938 al 1998. Racconta Giovanna che a metà ‘800 a fare il mugnaio era il capo della Guardia Civica di Castello. Di notte perlustrava la strade per difendere la popolazione dai briganti. La guardia andava dicendo che se avesse incontrato il Passatore lo avrebbe ucciso. La voce arrivò alle orecchie del famoso brigante. Un giorno l’uomo si sposò nella chiesa di San Petronio e lasciò un suo amico fidato a guardia del Mulino. Questi vide più volte il Passatore aggirarsi nelle campagne circostanti e lo riferì al mugnaio. Saputo il fatto, questi si trasferì a Firenze e non fece più ritorno a Castel Bolognese.
Il Passatore, nato a Boncellino il 24/8/1824, fu ucciso in uno scontro a fuoco con i papalini il 23/3/1851. Il suo cadavere fu messo su un birroccio e portato in giro in tutta la Romagna, perchè tutti lo vedessero.
A Castel Bolognese il carro sostò sulla via Emilia di fronte all’attuale sede della Banca di Romagna. Alla scena assistette Oliva Diversi, la nonna dello scrittore castellano Francesco Serantini, che del Passatore fu il più famoso storico (si veda a tal proposito il volume “Fatti memorabili della banda del Passatore in terra di Romagna”, pubblicato a Faenza nel 1929).
Serantini evocò con documentata verità,
ma anche con paterna indulgenza, vita, imprese e morte di Stefano Pelloni, a lui legato per sempre e che quasi sicuramente aveva imparato a conoscere fin da bambino, grazie ai racconti di nonna Oliva.
Morto il Passatore, il resto della banda agiva diretta da Giuseppe Afflitti, detto Lazzarino.
Il 10/10/1854 la banda del Lazzarino tentò un colpo a Castel Bolognese entrando nell’abitazione del possidente Francesco Gottarelli e appropriandosi di 423 scudi. Il garzone del Gottarelli, Giovanni Mingazzini, riuscì, inosservato, ad avvertire i gendarmi castellani i quali costrinsero la banda a fuggire. Nello scontro rimasero però feriti i gendarmi Giuseppe Stornini e Francesco Casadio, mentre il Gottarelli, rimasto pure gravemente ferito, morì pochi giorni dopo.
L’impresa più famosa del Passatore avvenne a Forlimpopoli il 25/1/1851, quando egli assaltò il teatro con la sua banda.
All’inizio del secondo atto, all’apertura del sipario, anzichè gli attori il pubblico vide comparire il Passatore con tutta la sua banda.
Gli spettatori furono tutti rapinati e tenuti sequestrati per oltre tre ore; alcuni di essi furono accompagnati nelle proprie case e furono “usati” come lasciapassare per entrare nelle case di varie altre persone, case che furono tutte “ripulite”.
Fra le famiglie rapinate vi fu anche quella di Pellegrino Artusi; una sorella dell’Artusi, per lo spavento, si rifugiò sul tetto della casa e a seguito dell’accaduto impazzì.
Cinema Teatro Arena Verdi
L’impresa più famosa del Passatore avvenne a Forlimpopoli il 25/1/1851, quando egli assaltò il teatro con la sua banda.
All’inizio del secondo atto, all’apertura del sipario, anzichè gli attori il pubblico vide comparire il Passatore con tutta la sua banda.
Gli spettatori furono tutti rapinati e tenuti sequestrati per oltre tre ore; alcuni di essi furono accompagnati nelle proprie case e furono “usati” come lasciapassare per entrare nelle case di varie altre persone, case che furono tutte “ripulite”.
Fra le famiglie rapinate vi fu anche quella di Pellegrino Artusi; una sorella dell’Artusi, per lo spavento, si rifugiò sul tetto della casa e a seguito dell’accaduto impazzì.
Cattura di un brigante a Cesenatico
Nella nostra storia nazionale il termine “brigantaggio” rimanda alla memoria le immagini di quegli individui armati di archibugio che infestarono, tra “700 e “800, soprattutto le zone del meridione e della Romagna; nel ricordo popolare al brigantaggio è associata anche l’immagine di combattenti contro i soprusi delle classi più ricche, una sorta di rivendicazione sociale ancora indefinita che avrebbe anticipato l’unificazione nazionale.
Sebbene i motivi che originavano il brigantaggio stessero indubbiamente nella miseria, l’analisi storica ha ormai ampiamente dimostrato come il ruolo di “vendicatori” delle classi popolari fosse solo un modo di guadagnarsi la complicità della gente più povera, finalizzata a trovare aiuto, quando serviva, contro le forze di polizia; questo rapporto era ben noto anche ai politici di quel tempo (1), così come era ben noto anche a quelli che ne approfittarono per imbastire lotte politiche reazionarie ammantandole di una veste “popolare”, come nel caso delle milizie antigiacobine (i “sanfedisti”) del cardinale Fabrizio Ruffo, che tentarono la riconquista borbonica di Napoli diventata Repubblica Napoletana.
In Romagna la mitizzazione del brigante come difensore degli oppressi si deve probabilmente allo stereotipo (che gli stessi romagnoli hanno ancora di sé stessi) di una etnia di gente ribelle, passionale, sempre pronta a farsi giustizia da sé stessa, stereotipo a cui non è sfuggita neppure la letteratura (2).
Il brigantaggio ha origini antiche (esiste un editto contro "grassatori, banditi, facinorosi e malviventi" già nel 1696 pubblicato da Innocenzo XIII), ma il più famoso è quello che ci viene illustrato nei documenti storici fin dal XVI sec.: prima ancora del noto Stefano Pelloni, detto il Passatore (Stuvanèn d'e Pasadôr) in Romagna c’erano stati Gaetano Prosperi, detto “Spirito”, Prospero Baschieri, Sebastiano Bora detto Puiena, Tommaso Rinaldini detto Mason d'la Blona, Michele Botti, detto Falcone, Luigi Casadio detto E Gagin (3), Antonio Cola detto Fabrizj, Giuseppe Afflitti detto Lazzarino (4).
(1) Francesco Saverio Nitti scrisse: “Per le plebi meridionali il brigante fu assai spesso il vendicatore e il benefattore: qualche volta fu la giustizia stessa. Le rivolte dei briganti, coscienti o incoscienti, nel maggior numero dei casi ebbero il carattere di vere e selvagge rivolte proletarie”.
(2) Si pensi ai famosi versi sul Passatore di Giovanni Pascoli, o al racconto “Sangue romagnolo” di Edmondo De Amicis. Questo fenomeno è vero, anche se solo in parte, per il meridione, dove Vincenzo Padula scrisse, nel 1850, il dramma "Antonello, capobrigante calabrese".
(3) La storia di questo bandito, che si era quasi dimenticata, è tornata alla memoria collettiva grazie ad un articolo di Franco Gàbici apparso sul “Resto del Carlino” nell’agosto del 2001.
(4) Per chi volesse approfondire queste storie si rimanda a vari volumi, di cui si riporta una lista non esaustiva: Turchini A., Società, banditismo, religione e controllo sociale fra Romagna e Toscana: la Val Lamone nel XVI sec., “Studi Romagnoli” XXVIII, 1977; Antonelli L., Donati C. Corpi armati e ordine pubblico in Italia (XVI-XIX sec.). Il banditismo nella Romagna toscana. Lombardi F.: Briganti in Romagna. Secoli XVI-XIX. Il Ponte Vecchio, Cesena, 2009.
Tra le imprese del Passatore quella che più ha contribuito a far nascere il mito del difensore dei più poveri è probabilmente la rapina a danno dei cittadini di Forlimpopoli, la notte del 25/1/1851.
I briganti penetrarono nel Teatro Comunale durante una rappresentazione e, saliti sul palco da cui puntavano i fucili verso gli spettatori, li rapinarono uno per volta.
Anche in Romagna, come nelle zone meridionali d’Italia, le radici del
banditismo era sempre la solita: la miseria endemica, esasperata dalle condizioni politiche e sociali dovute allo Stato
Pontificio, che considerava questa una terra barbara ed incivile, utile per essere
sfruttata e utilizzata come via di passaggio per il Veneto (e l’Europa del Nord) senza essere costretti ad attraversare le terre toscane, dove non sempre la gerarchia ecclesiastica era ben vista e la cui frammentazione politica portava al moltiplicarsi delle tariffe doganali.
Diverso dal meridione era da noi lo stato sociale dei briganti: più legato a questioni riguardanti le proprietà terriere al sud (quelli meridionali venivano, per lo più, dallo stato bracciantile), mentre i romagnoli erano generalmente contrabbandieri (5).
(5) E’ interessante ricordare come il contrabbando sia rimasto a lungo un’attività delle nostre zone. A Cesenatico esistevano, fino agli anni 50 del secolo scorso, contrabbandieri di sigarette e l’attuale via Zara veniva identificata, in mappe comunali degli anni 20, come Via Contrabbandiera.
Ma le origini potevano anche essere diverse.
Soprattutto nei secoli precedenti non era raro che si diventasse briganti a causa di lotte politiche legate a diatribe tra famiglie nobiliari (e in questo caso erano i nobili a diventare banditi); uno di questi ebbe una vicenda che si concluse proprio a Cesenatico.
Alfonso Piccolòmini, duca di Montemarciano, nacque nel 1550 e discendeva dalle famose famiglie dei Piccolòmini di Siena e degli Orsini, quindi era uno dei discendenti di papa Pio II. Non aveva ancora diciotto anni quando uccise uno dei Baglioni, nobili di Perugia, per questioni di interessi legati ai possessi di terre. Ciò gli costò la scomunica da parte del papa Gregorio XIII; per questo fatto fu costretto a darsi alla macchia. Fu salvato dall’intervento del granduca di Toscana, che lo aiutò a fuggire in Francia dove rimase otto anni servendo il re di quel paese come militare.
Tornò poi in Italia e poiché la scomunica era ancora in vigore si diede alla latitanza mettendo insieme una banda di circa 200 uomini (toscani, romagnoli e marchigiani, alla fine della sua carriera erano diventati più di 500) che nascondeva nei suoi possedimenti. Come vassallo dei Medici in un primo tempo riuscì a barcamenarsi tra questi ed i loro nemici (convinse i Medici che avrebbe potuto liberare la Toscana da bande criminali), ma le sue imprese assunsero sempre di più il carattere di scorrerie senza regola alcuna, soprattutto durante una carestia nel 1590, durante la quale cercò di darsi la fama di “amico del popolo oppresso”. Ma questo suo tentativo non poté nascondere i fatti sanguinosi di cui si era reso colpevole: assaliva i conventi mettendo a morte tutti i religiosi che vi trovava, uccise alcuni suoi avversari politici facendoli sgozzare alla presenza dei parenti, in un paese vicino a Civitavecchia fece uccidere tutti gli abitanti maschi. Ciò costrinse il granduca di Toscana ad allearsi con il Papa per dargli la caccia. Fu allora che Piccolòmini si imbatté in un suo vecchio nemico: Pierconte Gabuzi. Nato vicino a Senigallia da famiglia di nobili locali, Pierconte Gabuzi si dedicò alla carriera militare, particolarmente a favore di Venezia (fu uno dei comandanti che più si misero in mostra durante l'assedio di Famagosta, nel 1571, cosa per la quale il Senato veneto lo nominò colonnello (6).
(6) Venezia, Bibl. del Civico Museo Correr, Mss. Cicogna, 2993/IV, cc. 11v-12.
Tra i due c’era una vecchia ruggine, poiché Piccolòmini accusava Gabuzi di averlo screditato agli occhi di papa Gregorio XIII (e per vendicarsi di questo fatto il bandito aveva saccheggiato e distrutto Montalboddo, paese natale di Gabuzi e cercato di farlo uccidere con un’imboscata capeggiata da un bandito di nome Selvatico). Quando il papa ed il granduca di Toscana decisero di porre termine alle imprese di Piccolòmini, Gabuzi ottenne dalla Serenissima un gruppo di armati albanesi per dare aiuto alle truppe toscane.
Alfonso Piccolòmini iniziò allora una fuga attraverso la Maremma e la Romagna fino a quando, ai primi di gennaio del 1591, venne catturato dalle truppe toscane e pontificie a Cesenatico: Gabuzi era tra coloro che lo fermarono (7).
(7) A. Morosini, Venetiarum principis vita, Venetiis 1628.
La zona attorno alla Cesenatico di quel tempo era il terreno più adatto da utilizzare come nascondiglio: sufficientemente lontano da grandi centri, ma non troppo per impedire l’invio di richieste di soccorso, vicino ad un mare magari utilizzabile in caso di fuga, percorso da canali che dividevano appezzamenti di terreno spesso incolti e paludosi, abitato da contadini e pescatori ignari delle beghe politiche e delle loro implicazioni sociali.
Ma questo non gli fu sufficiente.
E’ lo storico Ludovico Antonio Muratori a ricordare, nei suoi Annali, proprio Cesenatico come luogo di cattura del bandito: “
“Anno di Cristo 1591, indizione IV di Innocenzo I papa, di Rodolfo II, imperatore. Più che mai e in maniera disusata sii provarono nel verno e nei mesi susseguenti di questo anno i terribili morsi della fame in Italia ed anche fuori l’Italia [...].
A questo malore si aggiunse una perniciosa epidemia, probabilmente originata o dalla mancanza, o dalla mala qualità dei cibi per cui gran copia di gente sorpresa da deliqui, o da acute febbri perì [...]. I duchi di Firenze, Ferrara, Urbino ed altri principi e spezialmente la saggia repubblica di Venezia, non perdonarono a spesa veruna per tirar grani da lontanissime contrade a fin di soccorrere al bisogno dei loro popoli. [...] Medesimamente in questo anno più che mai infierirono i banditi in campagna di Roma e in Romagna. Per conto di questa ultima provincia, mosso dal pontefice, Alfonso duca di Ferrara, seppe trovar la maniera di purgarla da quei tanti masnadieri, inviando il conte Enea Montecuccoli con assai squadre di cavalli e fanti e certe carrette conducenti artiglierie colle loro troniere, le quali nello spazio di due mesi parte uccisero, parte dissiparono quella canaglia. [...] Nel Cesenatico restò anche preso Alfonso Piccolomini, gran caporione di quelle masnade e condotto a Firenze, quivi trovò quel fine, che conveniva ai meriti suoi . ... (8)” Alfonso Piccolòmini venne condotto a Firenze (il papa lo avrebbe voluto a Roma) dove fu processato ed impiccato nel palazzo del Bargello, il 16/3/1591: aveva poco più di quarant’anni, di cui più di venti spesi ad uccidere e terrorizzare.
(8) Annali d'Italia di Lodovico Antonio Muratori, Edizione Novissima, tomo XXIV. Dalla tipografia di Antonio Curti, in Venezia, MDCCCI.
80 yerel halk öneriyor
Cesenatico
Cattura di un brigante a Cesenatico
Nella nostra storia nazionale il termine “brigantaggio” rimanda alla memoria le immagini di quegli individui armati di archibugio che infestarono, tra “700 e “800, soprattutto le zone del meridione e della Romagna; nel ricordo popolare al brigantaggio è associata anche l’immagine di combattenti contro i soprusi delle classi più ricche, una sorta di rivendicazione sociale ancora indefinita che avrebbe anticipato l’unificazione nazionale.
Sebbene i motivi che originavano il brigantaggio stessero indubbiamente nella miseria, l’analisi storica ha ormai ampiamente dimostrato come il ruolo di “vendicatori” delle classi popolari fosse solo un modo di guadagnarsi la complicità della gente più povera, finalizzata a trovare aiuto, quando serviva, contro le forze di polizia; questo rapporto era ben noto anche ai politici di quel tempo (1), così come era ben noto anche a quelli che ne approfittarono per imbastire lotte politiche reazionarie ammantandole di una veste “popolare”, come nel caso delle milizie antigiacobine (i “sanfedisti”) del cardinale Fabrizio Ruffo, che tentarono la riconquista borbonica di Napoli diventata Repubblica Napoletana.
In Romagna la mitizzazione del brigante come difensore degli oppressi si deve probabilmente allo stereotipo (che gli stessi romagnoli hanno ancora di sé stessi) di una etnia di gente ribelle, passionale, sempre pronta a farsi giustizia da sé stessa, stereotipo a cui non è sfuggita neppure la letteratura (2).
Il brigantaggio ha origini antiche (esiste un editto contro "grassatori, banditi, facinorosi e malviventi" già nel 1696 pubblicato da Innocenzo XIII), ma il più famoso è quello che ci viene illustrato nei documenti storici fin dal XVI sec.: prima ancora del noto Stefano Pelloni, detto il Passatore (Stuvanèn d'e Pasadôr) in Romagna c’erano stati Gaetano Prosperi, detto “Spirito”, Prospero Baschieri, Sebastiano Bora detto Puiena, Tommaso Rinaldini detto Mason d'la Blona, Michele Botti, detto Falcone, Luigi Casadio detto E Gagin (3), Antonio Cola detto Fabrizj, Giuseppe Afflitti detto Lazzarino (4).
(1) Francesco Saverio Nitti scrisse: “Per le plebi meridionali il brigante fu assai spesso il vendicatore e il benefattore: qualche volta fu la giustizia stessa. Le rivolte dei briganti, coscienti o incoscienti, nel maggior numero dei casi ebbero il carattere di vere e selvagge rivolte proletarie”.
(2) Si pensi ai famosi versi sul Passatore di Giovanni Pascoli, o al racconto “Sangue romagnolo” di Edmondo De Amicis. Questo fenomeno è vero, anche se solo in parte, per il meridione, dove Vincenzo Padula scrisse, nel 1850, il dramma "Antonello, capobrigante calabrese".
(3) La storia di questo bandito, che si era quasi dimenticata, è tornata alla memoria collettiva grazie ad un articolo di Franco Gàbici apparso sul “Resto del Carlino” nell’agosto del 2001.
(4) Per chi volesse approfondire queste storie si rimanda a vari volumi, di cui si riporta una lista non esaustiva: Turchini A., Società, banditismo, religione e controllo sociale fra Romagna e Toscana: la Val Lamone nel XVI sec., “Studi Romagnoli” XXVIII, 1977; Antonelli L., Donati C. Corpi armati e ordine pubblico in Italia (XVI-XIX sec.). Il banditismo nella Romagna toscana. Lombardi F.: Briganti in Romagna. Secoli XVI-XIX. Il Ponte Vecchio, Cesena, 2009.
Tra le imprese del Passatore quella che più ha contribuito a far nascere il mito del difensore dei più poveri è probabilmente la rapina a danno dei cittadini di Forlimpopoli, la notte del 25/1/1851.
I briganti penetrarono nel Teatro Comunale durante una rappresentazione e, saliti sul palco da cui puntavano i fucili verso gli spettatori, li rapinarono uno per volta.
Anche in Romagna, come nelle zone meridionali d’Italia, le radici del
banditismo era sempre la solita: la miseria endemica, esasperata dalle condizioni politiche e sociali dovute allo Stato
Pontificio, che considerava questa una terra barbara ed incivile, utile per essere
sfruttata e utilizzata come via di passaggio per il Veneto (e l’Europa del Nord) senza essere costretti ad attraversare le terre toscane, dove non sempre la gerarchia ecclesiastica era ben vista e la cui frammentazione politica portava al moltiplicarsi delle tariffe doganali.
Diverso dal meridione era da noi lo stato sociale dei briganti: più legato a questioni riguardanti le proprietà terriere al sud (quelli meridionali venivano, per lo più, dallo stato bracciantile), mentre i romagnoli erano generalmente contrabbandieri (5).
(5) E’ interessante ricordare come il contrabbando sia rimasto a lungo un’attività delle nostre zone. A Cesenatico esistevano, fino agli anni 50 del secolo scorso, contrabbandieri di sigarette e l’attuale via Zara veniva identificata, in mappe comunali degli anni 20, come Via Contrabbandiera.
Ma le origini potevano anche essere diverse.
Soprattutto nei secoli precedenti non era raro che si diventasse briganti a causa di lotte politiche legate a diatribe tra famiglie nobiliari (e in questo caso erano i nobili a diventare banditi); uno di questi ebbe una vicenda che si concluse proprio a Cesenatico.
Alfonso Piccolòmini, duca di Montemarciano, nacque nel 1550 e discendeva dalle famose famiglie dei Piccolòmini di Siena e degli Orsini, quindi era uno dei discendenti di papa Pio II. Non aveva ancora diciotto anni quando uccise uno dei Baglioni, nobili di Perugia, per questioni di interessi legati ai possessi di terre. Ciò gli costò la scomunica da parte del papa Gregorio XIII; per questo fatto fu costretto a darsi alla macchia. Fu salvato dall’intervento del granduca di Toscana, che lo aiutò a fuggire in Francia dove rimase otto anni servendo il re di quel paese come militare.
Tornò poi in Italia e poiché la scomunica era ancora in vigore si diede alla latitanza mettendo insieme una banda di circa 200 uomini (toscani, romagnoli e marchigiani, alla fine della sua carriera erano diventati più di 500) che nascondeva nei suoi possedimenti. Come vassallo dei Medici in un primo tempo riuscì a barcamenarsi tra questi ed i loro nemici (convinse i Medici che avrebbe potuto liberare la Toscana da bande criminali), ma le sue imprese assunsero sempre di più il carattere di scorrerie senza regola alcuna, soprattutto durante una carestia nel 1590, durante la quale cercò di darsi la fama di “amico del popolo oppresso”. Ma questo suo tentativo non poté nascondere i fatti sanguinosi di cui si era reso colpevole: assaliva i conventi mettendo a morte tutti i religiosi che vi trovava, uccise alcuni suoi avversari politici facendoli sgozzare alla presenza dei parenti, in un paese vicino a Civitavecchia fece uccidere tutti gli abitanti maschi. Ciò costrinse il granduca di Toscana ad allearsi con il Papa per dargli la caccia. Fu allora che Piccolòmini si imbatté in un suo vecchio nemico: Pierconte Gabuzi. Nato vicino a Senigallia da famiglia di nobili locali, Pierconte Gabuzi si dedicò alla carriera militare, particolarmente a favore di Venezia (fu uno dei comandanti che più si misero in mostra durante l'assedio di Famagosta, nel 1571, cosa per la quale il Senato veneto lo nominò colonnello (6).
(6) Venezia, Bibl. del Civico Museo Correr, Mss. Cicogna, 2993/IV, cc. 11v-12.
Tra i due c’era una vecchia ruggine, poiché Piccolòmini accusava Gabuzi di averlo screditato agli occhi di papa Gregorio XIII (e per vendicarsi di questo fatto il bandito aveva saccheggiato e distrutto Montalboddo, paese natale di Gabuzi e cercato di farlo uccidere con un’imboscata capeggiata da un bandito di nome Selvatico). Quando il papa ed il granduca di Toscana decisero di porre termine alle imprese di Piccolòmini, Gabuzi ottenne dalla Serenissima un gruppo di armati albanesi per dare aiuto alle truppe toscane.
Alfonso Piccolòmini iniziò allora una fuga attraverso la Maremma e la Romagna fino a quando, ai primi di gennaio del 1591, venne catturato dalle truppe toscane e pontificie a Cesenatico: Gabuzi era tra coloro che lo fermarono (7).
(7) A. Morosini, Venetiarum principis vita, Venetiis 1628.
La zona attorno alla Cesenatico di quel tempo era il terreno più adatto da utilizzare come nascondiglio: sufficientemente lontano da grandi centri, ma non troppo per impedire l’invio di richieste di soccorso, vicino ad un mare magari utilizzabile in caso di fuga, percorso da canali che dividevano appezzamenti di terreno spesso incolti e paludosi, abitato da contadini e pescatori ignari delle beghe politiche e delle loro implicazioni sociali.
Ma questo non gli fu sufficiente.
E’ lo storico Ludovico Antonio Muratori a ricordare, nei suoi Annali, proprio Cesenatico come luogo di cattura del bandito: “
“Anno di Cristo 1591, indizione IV di Innocenzo I papa, di Rodolfo II, imperatore. Più che mai e in maniera disusata sii provarono nel verno e nei mesi susseguenti di questo anno i terribili morsi della fame in Italia ed anche fuori l’Italia [...].
A questo malore si aggiunse una perniciosa epidemia, probabilmente originata o dalla mancanza, o dalla mala qualità dei cibi per cui gran copia di gente sorpresa da deliqui, o da acute febbri perì [...]. I duchi di Firenze, Ferrara, Urbino ed altri principi e spezialmente la saggia repubblica di Venezia, non perdonarono a spesa veruna per tirar grani da lontanissime contrade a fin di soccorrere al bisogno dei loro popoli. [...] Medesimamente in questo anno più che mai infierirono i banditi in campagna di Roma e in Romagna. Per conto di questa ultima provincia, mosso dal pontefice, Alfonso duca di Ferrara, seppe trovar la maniera di purgarla da quei tanti masnadieri, inviando il conte Enea Montecuccoli con assai squadre di cavalli e fanti e certe carrette conducenti artiglierie colle loro troniere, le quali nello spazio di due mesi parte uccisero, parte dissiparono quella canaglia. [...] Nel Cesenatico restò anche preso Alfonso Piccolomini, gran caporione di quelle masnade e condotto a Firenze, quivi trovò quel fine, che conveniva ai meriti suoi . ... (8)” Alfonso Piccolòmini venne condotto a Firenze (il papa lo avrebbe voluto a Roma) dove fu processato ed impiccato nel palazzo del Bargello, il 16/3/1591: aveva poco più di quarant’anni, di cui più di venti spesi ad uccidere e terrorizzare.
(8) Annali d'Italia di Lodovico Antonio Muratori, Edizione Novissima, tomo XXIV. Dalla tipografia di Antonio Curti, in Venezia, MDCCCI.
Don Stiflón, prete brigante e lussurioso
Storia di sangue, sesso e soldi nella Romagna granducale dei Lorena
Questo articolo nasce dall’esigenza di fare il punto sulla ricerca storica, (1) dove si narra la vita del prete romagnolo don Pietro Valgimigli detto don Stiflón, don Stiffelone nei rapporti di polizia, ricostruita in lunghe ricerche negli archivi toscani e romagnoli.
—-
(1) P. l. Farolfi, Facinorosi pontifici. Storia di briganti e manutengoli (per tacer del prete) fra Legazioni e Granducato di Toscana, s. l., Il mio libro, 2015.
—-
Nel frattempo Luigi Cesare Bonfante, giudice e appassionato storico di grande spessore e competenza, ha pubblicato il libro: Tredozio nell’Ottocento. “Un sogno alle Murate” (2018), (2) risultato di una sua personale ricerca parallela su un pamphlet scritto dal prete durante la prigionia nel carcere fiorentino.
—-
(2) l. C. Bonfante, Tredozio nell’Ottocento. “Un sogno alle Murate”, s. l., stampato in pro- prio, 2018. Un libretto che Bonfante ha ritrovato rovistando nel solaio di casa, giunto fino a lui attraverso incredibili passaggi di mano tra i suoi avi. Si pensava che questa fosse rimasta l’unica copia e tutte le altre distrutte per non lasciare traccia di panni sporchi esibiti in pubblico. In realtà, un esemplare risulta depositato presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, ma destinato all’oblio se non ci fosse stato qualcuno, profondo conoscitore della storia, della società e del territorio a cui si riferiva, capace di leggere e interpretarne i contenuti con le giuste chiavi di lettura. Forse don Stiflón, temendo proprio un insabbiamento della sua vendetta, aveva provveduto a distribuirlo ad altre persone amiche.
—-
1. Don Stiflón e il suo tempo
Don Pietro Valgimigli nasce il 14/10/1823 a Modigliana da Cammillo e Domenica Baroggi, settimo di dieci figli, ed è battezzato in cattedrale. Frequenta le scuole dei Padri Scolopi distinguendosi fra gli allievi più meritevoli: nel 1838 è premiato in Rettorica per un lavoro su Pindaro, poeta lirico greco, insieme a Silvestro Lega, il noto pittore macchiaiolo, che, invece, si distingue in Storia greca e Poesia.
Ordinato sacerdote il 6/6/1846, va ad aiutare lo zio parroco a Senzano. Il 26/3/1847 muore il vecchio arciprete di San Valentino don Andrea Signani e la parrocchia vacante è messa a concorso. Vince don Pietro che il 27/6/1847, quinta domenica dopo pentecoste, prende possesso della Chiesa Arcipretale di San Valentino secondo i modi prescritti e nelle debite forme.
Che tipo è don Pietro? Nella nostra ricerca abbiamo visto molti identikit di briganti e manutengoli; purtroppo, nei tanti faldoni consultati, non abbiamo trovato suoi ritratti né descrizioni da parte di funzionari di norma piuttosto prolissi nel raffigurare chi avevano davanti. Comunque, le poche informazioni raccolte possono essere sufficienti a darcene un’idea sommaria, ma rappresentativa.
Un giovane di bell’aspetto, dal volto raso e dai lineamenti non rozzi, dice l’Artusi, (3) soprannominato don Stiflón per la sua figura alta e slanciata e con una gamba più veloce della lepre.
—-
3 P. Artusi, Autobiografia, Bra, Arcigola Slow Food Editore, 1999, p. 43. Approfondiremo la sua figura nel paragrafo relativo all’invasione di Forlimpopoli da parte delle banda del Passatore.
In generale, più che descriverlo fisicamente, sono gli attributi caratteriali a rappresentarlo: tristo, scaltro, fiero, violento, risentito, vendicativo, imbroglione, immorale, scandaloso, bestemmiatore, eretico, magnetizzatore, pericoloso, feroce, sanguinario. Un prete di buona cultura e di forte personalità con un’attrazione fatale per il rischio, i denari e le donne concupite e sedotte dal suo focoso temperamento. Ma, come per tutti il fisico deperisce, a 58 anni non è più quello di un tempo e si lamenta di soffrire molti incommodi fra cui la debolezza degli occhi, la sordità più che mezzana, la fiacchezza dei ginocchi.
Suoi sodali sono:
- Stefano Pelloni del Boncellino, frazione di Bagnacavallo, detto il Passatore, [e Pasadór],
- Angiolo Lama detto Lisagna,
- il Gobbo [e Gòbb],
- Zappolone [Zaplón], colono di Forlì,
- Giuseppe Afflitti detto Lazzarino [Lazarèn o Lazzerino, alla toscana],
- Caprino [Cavrèna],
- Fido,
- Camminazzo [Caminàz], contadino di Cantalupo,
- Governatorato d’Imola, che si dichiara bandito per causa politica per aver partecipato alla difesa della Repubblica Romana.
Briganti classificati come facinorosi pontifici dal Governo Granducale che li contrasta nei loro sconfinamenti per sfuggire all’inseguimento delle truppe austro-pontificie, protetti dalla loro rete di fiancheggiatori e manutengoli. La sua passione per le donne va di pari passo con la connivenza coi briganti di cui, in realtà, è l’eminenza grigia che progetta, organizza e a volte partecipa alle grassazioni, ai furti e agli omicidi. Da qui, da San Valentino, partono i colpi nelle Legazioni pontificie, il più eclatante dei quali è l’invasione di Forlimpopoli nel 1851. Le critiche mosse dai governi e dall’opinione pubblica internazionale per questo grave fatto al governo pontificio e per la sua incapacità di debellare il brigantaggio portano a un potenziamento delle misure militari con l’arrivo del capitano Michele Zambelli che si è già distinto nella lotta al brigantaggio. L’aumento delle taglie e la riconferma del Giudizio Statario che prevede l’immediata fucilazione di tutti quelli colti in flagranza di reato, porta subito a un importante risultato: il 23/3/1851, a seguito di una soffiata, i papalini uccidono il Passatore che si è nascosto nel paretaio del fondo Molesa presso Russi di proprietà degli Spadini, ricchi possidenti di Faenza ed esibiscono il macabro trofeo portandolo in giro su un barroccio per la Romagna.
La forte reazione delle truppe papaline e austriache porta a numerosi arresti ed esecuzioni capitali di briganti e manutengoli nelle Legazioni. Sono giorni in cui il Giudizio Statario funziona a pieno ritmo. È un periodo di forti agitazioni politiche. La vittoria degli austriaci sui piemontesi a Novara il 23/3/1849, l’abdicazione di Carlo Alberto, l’armistizio firmato da Vittorio Emanuele II il 26 marzo, producono i loro effetti anche in Toscana dove il triumvirato Guerrazzi, Montanelli e Mazzoni si dimette ed è restaurato il vecchio regime granducale.
Anche nella Romagna toscana il popolo manifesta, ad eccezione di pochi traviati amanti del disordine e delle tenebre, la massima gioia ed allegrezza. I comuni roma- gnoli si affrettano ad aderire al nuovo ordine, solo a S. Sofia e Modigliana c’è un poco di riottosità perché in quei paesi le affezioni per il governo monarchico non sono state mai troppo profonde. La confusione è grande: gli alberi della libertà abbattuti sono rialzati e le armi granducali, ripristinate nei palazzi governativi, sono vilipese. E il sottoprefetto si chiede sconsolato: Tutti i buoni e il contado fremono di simili vergogne, ma che fare senza Forza?. E la Forza arriva. Il 12 maggio, tre distaccamenti giungono a Modigliana, Marradi e Terra del Sole e il giorno dopo un altro a Rocca destinato a S. Sofia e Galeata. Il 25 maggio il generale Kostantin d’Aspre entra in Firenze alla testa delle truppe austriache e alla fine dell’estate il ripristino del vecchio assetto politico può dirsi completato. Ma tutto questo sommovimento politico e sociale porta miseria fra la popolazione e la recrudescenza del brigantaggio.
Il maresciallo Thurn, governatore militare e civile di Bologna, il 21/10/1849 denuncia la triste condizione delle Legazioni lamentando le recenti grassazioni, le invasioni, e gli attentati a danno della vita, e della proprietà di ogni persona commessi da bande armate che trovano sussidio dagli abitanti della campagna, in parte per corruzione, in parte per timore, essendo gli stessi privi della protezione del governo, e quindi in balia di tali malviventi. Le bande agiscono tranquille nell’inazione e depravazione delle autorità. La polizia è poco motivata perché pagata meschinamente e manca un adeguato fondo per i confidenti. La forza militare non basta a garantire la pubblica sicurezza: il corpo dei vèliti è demoralizzato e le truppe di linea scoraggiate. Una fotografia che vale anche per la Romagna toscana dove l’inasprimento della situazione sociale porta a un aumento dell’impegno del governo granducale e dell’esercito di occupazione austriaco che inviano a più riprese rinforzi nella provincia mettendo in difficoltà i briganti e i loro manutengoli con scontri a fuoco, rastrellamenti, retate, perquisizioni e arresti, a volte anche con azioni congiunte dei due Stati.
Si può calcolare che in quel periodo, fra esercito austriaco e granducale con cavalleggeri e soldati di linea, gendarmi e ausiliari, la presenza militare in Romagna toscana superi le 700 unità. Se a queste aggiungiamo le forze pontificie e austriache stanziate nelle Legazioni, che grazie ad accordi fra i due Stati possono sconfinare nei loro inseguimenti, il numero di armati impegnati nella repressione del brigantaggio oltrepassa le 1.000 unità. Uno sforzo davvero impressionante!
È in questo quadro generale che, per sfuggire all’accerchiamento delle truppe austro-pontificie, la banda del Passatore è costretta a ripiegare nel Granducato nascondendosi a San Valentino, una pieve posta in posizione dominante su uno sprone dell’Appennino tosco-romagnolo a cavallo fra i comuni di Tredozio e Modigliana. Un luogo che è sempre stato coinvolto in fenomeni di brigantaggio e di ribellismo: basti citare il brigante Giovanni Montanari detto Buriga in epoca napoleonica (4) e, più vicine a noi, le gesta del partigiano Silvio Corbari nella seconda guerra mondiale. (5)
—-
(4) Per approfondimenti vedi: D. Mengozzi, Sicurezza e criminalità, Milano, F. Angeli, 1999.
(5) Per approfondimenti vedi: E. Dalmonte, Corbari e la sua banda, Faenza, Ragazzini, 1984; P. Cacucci, Ribelli!, Milano, Feltrinelli, 2001; M. Novelli, Corbari, Iris, Casadei e gli altri, Torino, Graphot, 2002; C. GreMeNtieri, Iris Versari e la Resistenza delle donne, Castro- caro, Vespignani, 2004.
I contatti con don Pietro Valgimigli sono forse conseguenti a conoscenze di quando era in seminario a Faenza. La pieve di S. Valentino esercitava la sua giurisdizione spirituale su quattordici parrocchie; (6) le sue origini, secondo il Repetti, risalgono addirittura all’anno 562.
—-
(6) Questa pieve abbracciava 21 parrocchie attualmente ridotte a 14, fra le quali quella di S. Michele a Tredozio, per quanto sia stata eretta in battesimale. Tali sono:
1. S. Valentino, pieve arcipretura, cui è annesso il popolo di S. Carlo alle Casette;
2. S. Michele in Tredozio, pieve con l’annesso di S. Valeriano;
3. S. Benedetto in Alpe;
4. S. Maria in Carpine;
5. S. Eustachio in Cannetole;
6. S. Giuliano in Querciolano;
7. S. Maria in Castello con l’annesso di S. Michele in Vediano;
8. S. Biagio in Sarturano, cui è unito S. Martino in Scannello;
9. S. Giorgio in Rosata;
10. S. Lorenzo in Scarzana;
11 S. Maria in Ottignana con S. Maria in Tramonte;
12. S. Cesario in Cesata;
13. S. Martino in Collina;
14. S. Andrea in Pereta».
E. Repetti, Dizionario Geografico Fisico Storico della Toscana, 1841, vol. IV, pp. 238-239.
Era una cura molto appetita dai parroci dell’epoca per le sue ricche entrate che comprendevano la rendita di due poderi, alcune terre spezzate, le regalie dei capponi per il S. Natale, le ova, che sogliono corrispondersi dai coloni per le Feste Pasquali e gli incerti di stola bianca [battesimi e matrimoni] e nera [funerali]. Qui i briganti si sentono tranquilli perché è la loro casa fidata e passano il tempo a mangiare, bere, giocare e cacciare. Qui preparano i piani per qualche spedizione. Don Stiflón si premura di farli sentire a loro agio e fa girare questi assassini dappertutto e si è raccontato, conferma al sottoprefetto Bersotti don Giovanni Tignani, parroco della Berleta all’epoca dell’inchiesta su don Valgimigli, perfino che li abbia condotti al Teatro della Pergola a Firenze. A tavola si trattano bene e mangiano carne scelta che il garzone del prete, Giacomino Tronconi [Jacmèn], compra a Tredozio e a Modigliana. A Tredozio si serve da Niccola Poggiolini detto Gugliata [Guièda] che, siccome ammazza dei bei castrati manda il garzone a prendere parecchie libbre per volta e a Modigliana la ritira dal babbo che giustifica l’acquisto di tutto quel ben di Dio perché, dice: Il mio prete ci ha forestieri.
2. Una vita brigantesca
Invasione di Forlimpopoli
È il 25/1/1851, una sera triste d’aspetto, non punto fredda, caliginosa e piovosa. Le porte della città sono chiuse e le strade deserte. Al teatro comunale una compagnia di commedianti girovaghi rappresenta per l’ultima volta “La morte di Sisara”, tragedia biblica babilonese in cinque atti, con musica negli intervalli. Terminato il primo atto, i briganti irrompono sul palco e in platea disarmando i gendarmi presenti e minacciando di uccidere chi non avesse obbedito. Poi si distribuiscono per le strade saccheggiando le case dei maggiorenti della città. Violano anche l’abitazione di Pellegrino Artusi entrando con l’inganno, depredando e malmenando le persone che sono in casa. Pellegrino riconosce don Stiflón: Poi [il saccheggio continuò] giù in bottega e qui mi apparve una figura sinistra che, piantata in mezzo alla stanza col fucile ad armacollo, mostrava di comandare e far le veci del Passatore che in casa nostra non venne. Mi è rimasta sempre presente quella faccia crudele, dal cuore di tigre, che da me supplicato che cercasse di moderare i compagni a non commettere turpitudini, stava silenzioso e duro come un macigno. Dai connotati, dal volto raso, dai lineamenti non rozzi e da tutto insieme, costui non poteva essere altri che l’infame prete Valgimigli e non m’inganno di certo, sapendosi che qualche volta partecipava alle imprese. (7)
—-
(7) P. Artusi, Autobiografia, cit., p. 43.
Prima di andarsene i banditi dedicano la loro attenzione alle sorelle. Due riescono a nascondersi, ma Geltrude che è bella e di lineamenti delicati e gentili, dopo una lotta disperata con alcuni di costoro, manomessa e contaminata, fugge da un abbaino che porta sui tetti, colà vagando spaurita da un tetto all’altro. La povera Geltrude non si riprende più da questo trauma e il suo stato mentale peggiora nel tempo, fin quando viene rinchiusa nel manicomio di Pesaro dove muore dopo dodici anni di reclusione.
L’Artusi non sa darsi pace dell’accaduto e si trasferisce a Firenze dove apre un banco della seta in via Calzaioli, invitando i mercanti romagnoli a servirsi da lui. Caso vuole che la prima persona che si presenta con una partita di seta sia un fratello di don Valgimigli raccomandatogli dall’onesto negoziante Luigi Massa di Faenza che, al pari degli altri, era ignaro che quella famiglia avesse relazione cogli assassini. Lui gli fa una buona accoglienza e lo invita a pranzo ove, fra gli altri argomenti, cade il discorso sul fatto di Forlimpopoli del quale egli, purtroppo è più informato di lui. E per tutta la vita si porterà dietro il triste ricordo di quella brutta serata e di quel losco individuo che partecipò alla ruberia e allo scempio dei suoi familiari.
In seguito, quando nel 1865 Firenze diventa capitale d’Italia, l’Artusi lascia casa e bottega in via Calzaioli e si trasferisce in piazza d’Azeglio 25 dove si ritira a vita privata dedicandosi ai suoi interessi culturali e gastronomici e pubblicando a proprie spese “La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene”. Un manuale continuamente migliorato e arricchito fino alla quattordicesima edizione con la collaborazione dei fedeli domestici Marietta Sabatini e Francesco Ruffilli. (8)
—-
(8) M. Alba, G. Frosini, Domestici scrittori, Sesto Fiorentino, Apice libri, 2019. Un interessantissimo libro che riporta la corrispondenza di Marietta Sabatini, Francesco Ruffilli e altri con Pellegrino Artusi.
Un libro in cui l’Artusi ha il merito di imporre la lingua patria che per lui altro non è che il volgare toscano che forma la bella e armoniosa lingua paesana che non può tollerare contaminazioni da parte di altri paesi. Quest’opera di selezione e filtrazione fu opportuna e meritoria. [...] Artusi troncò una tradizione bisecolare e iniziò (eccedendo com’è naturale, nell’esclusivismo puristico) un processo di recupero orientato verso la migliore tradizione italiana. Talvolta, per essere più persuasivo e popolare, usò persino improvvisare quartine per rendere più orecchiabile il nuovo linguaggio di italiano di cucina. [...] Tutte le strade erano buone pur di ottenere l’intento prefissato. All’inizio del manuale c’è una Spiegazione di voci che, essendo del volgare toscano, non tutti intenderebbero, uno stringatissimo glossarietto che però capovolge l’uso da tanto tempo invalso fra i trattatisti di cucina italiani di dare un elenco di termini francesi per facilitare la pratica culinaria. (9)
—-
(9) P. Artusi, La Scienza in cucina e l’Arte di mangiar bene, Introduzione e note di Piero Camporesi, Einaudi tascabili, Torino, 1970 pp. LXIV-LXVI.
Chiedo venia per questa digressione, ma dobbiamo essere grati all’Artusi per la modernizzazione della lingua italiana, al pari di Dante e del Manzoni.
Dopo questo colpo i briganti vorrebbero ripetere l’exploit nel teatro di Tredozio, ma don Stiflón si oppone perché dice che vuole bene al paese e lo ha sempre tenuto scelto e non se ne fa di nulla. In realtà non ha alcun interesse ad agitare le acque nei pressi della sua parrocchia. Discorso che ripete anche nel 1856 mentre è a pescare col suo amico Alessandro Pazzi, calzolaio di Tredozio, con cui si lamenta perché non tutti in Tredozio si erano ricreduti, ma seguitavano a stargli sostenuti, mentre tutte le volte che i briganti avevano mostrato l’intenzione di rubare nel paese lui li aveva respinti sempre indietro.
Strage al Casetto di San Carlo e alla Masera
Giuseppe Lombardi è contadino al Casetto di San Carlo con la moglie Maria e due figli, Luigi e Domenica, sposata con Domenico Bernabei detto Mengone che lavora alla giornata anche nel vicino podere della Masera. Il Lombardi, una vecchia conoscenza della polizia, denuncia al delegato di Modigliana la presenza dei briganti a casa sua. Vengono subito mandati i soldati, guidati da lui stesso, ma non riescono a rintracciare i facinorosi. La domenica seguente l’uomo si mette a raccontarlo nella piazza del paese mostrando a tutti i 5 paoli di ricompensa per la sua denuncia. Qualcuno lo avverte che non è prudente il ciarlar tanto e che per questo sgarbo lo avrebbero ammazzato. Impaurito, si fa accompagnare a casa dai gendarmi. Ma dopo la morte del Passatore, i briganti vedono nel suo tradimento una minaccia alla loro sicurezza e sono decisi a dare un esempio che sia di monito a tutti. La sentenza viene emessa la notte del 3/4/1851 al mulino dell’Avolano sul torrente Tramazzo condotto dai fratelli Senzani: Giuseppe detto il Matto [e Matt] e Andrea detto Dreino.
Circostanziate testimonianze attestano che è lo stesso don Stiflón a essere committente, giudice e partecipe all’impresa. La sera del sabato 5 aprile Lisagna e Spigone, (10) guidati dal Matto, muovono verso il Casetto di S. Carlo dove il mugnaio chiede di entrare col pretesto di ritirare la farina di formentone che aveva portato in quel giorno a macinare.
—-
(10) Bertoni Pietro detto Spiga, Spigone e Almanacco, di Granarolo.
Alla sua vista il Lombardi si fida e apre la porta. È così che i briganti riescono a entrare in casa spezzando le armi per impedire ogni tentativo di difesa.
Manca però Mengone; Lisagna appoggia la pistola sul viso di Domenica chiedendole dove sta suo marito. Dopo che la sventurata ragazza ha rivelato che si trova alla Masera, la uccide all’istante. A quel punto si scatena Spigone che, con un’accetta trovata in casa, massacra tutti gli altri. Non ci sono testimonianze dirette di quel macello; si possono solo riassumere gli esiti di questa raccapricciante pazzia omicida descritti nella perizia medico-legale. Sui cadaveri sono riscontrate ferite mortali sulla testa e in varie parti del corpo prodotte da una scure trovata sporca di sangue e sul corpo della povera Domenica una grossa ferita in faccia dovuta all’esplosione di un’arma da fuoco. Consumata la strage decidono che bisogna uccidere anche Mengone e ripartono per la Masera, accompagnati questa volta da Dreino. Giungono a mezzanotte. L’uscio è chiuso, ma il mugnaio lo apre facilmente conoscendo il trucco: basta infilare il dito in una fessura per alzare la nottola interna e Lisagna e Spigone entrano in casa gridando: Lume, lume c’è la Forza! e, trovato Mengone, gli dicono che hanno ammazzato i suoi e ora ammazzeranno anche lui perché altrimenti avrebbe parlato. Il giovane implora invano di non ucciderlo; Spigone gli spiana il fucile sul petto, tira, ma non brucia che il fulminante. Quelli della casa lo supplicano di salvargli la vita. Spigone manda Lisagna a sentire che deve fare. Ma da fuori don Stiflón risponde: Devono esser morti tutti. Versione confermata dal commesso di vigilanza di Modigliana e da altre persone. Allora Spigone fa inginocchiare Mengone in mezzo alla stanza e, mentre il poveretto grida misericordia e pietà, lo uccide con una fucilata nel petto e un’altra in un orecchio. Prima di andarsene avvertono i casanti di aspettare il giorno dopo per sporgere la denuncia al tribunale e di dire a tutti che sono stati Lisagna e Spigone a ucciderli.
Quando Guido Tassinari, il becchino di Tredozio, apprende la notizia, sale a San Valentino dove trova don Pietro a dire messa, che gli ordina di seppellirli lì perché sono della sua parrocchia e che intanto prepari una fossa per cinque, ma come fa a conoscere il numero degli infelici trucidati senza aver conferito con alcuno? si chiede il capocommesso di Rocca dandosi anche la risposta. Don Pietro annota il loro decesso nel registro dei morti della parrocchia aggiungendo che il capofamiglia è stato trucidato orribilmente da alcuni assassini appartenenti alla famosa banda del Passatore per aver denunziato alla Giustizia i medesimi contro il di loro espresso ordine. Tanti salgono da Tredozio e da Modigliana a vedere i morti ammazzati e la voce pubblica indica subito il mandante nel prete con la convinzione che assistesse personalmente ed eccitasse alla strage della intera famiglia Lombardi.
Rapina a Razzolo
La mattina del 15/8/1852 la banda si riunisce per fare una rapina. Il colpo è stato concertato da tempo, ma si è atteso il via libera dal Calabrese (11), Morischi (12) e Spigone, ospiti a San Valentino, informati da don Stiflón che quel sabato al mercato di Dicomano ci sarebbero stati i pagamenti più grossi che si facevano in Toscana.
—-
(11) Antonio Ravaioli detto il Calabrese e il Marcio, di Faenza.
(12) Giuseppe Morigi detto Morischi, di Forlì.
Le dritte si nascondono fra i derubati. Lazzarino, Ghigno, (13) Lisagna e il Calabrese arrivano per conto loro a Razzolo, un podere sulla strada regia sopra Bocconi.
—-
(13) Domenico Sabbatani, detto Ghigno, di Castel Bolognese.
È l’alba del Ferragosto quando i commercianti tornano da Dicomano sui loro barroccini. I briganti li aspettano nascosti nella macchia sotto il podere. Man mano che arrivano sono costretti a scendere, perquisiti e derubati di tutti i denari che hanno, chi in un sacchetto, chi in scartocci, chi in ventriere di pelle. L’ammontare del bottino è di 3.436 scudi, nella massima parte composti di napoleoni d’oro. Poi si allontanano con i loro barroccini, dicendo che li avrebbero ritrovati in cima al monte Busca. I soldi li portano a don Stiflón dopo tre o quattro sere il Marcio, Morigi e Lisagna restituisce alle dritte gli scudi rapinati più la loro parte di bottino. Ma il prete rimane scontento perché i briganti rifiutano di retribuirgli dugento scudi sul bottino conseguito e questo è uno dei motivi per cui poi li tradirà. I possidenti romagnoli si allarmano e il sottoprefetto chiede rinforzi perché i facinorosi fino ad allora sembrano aver rispettato il territorio granducale come quello di loro asilo, ma dopo il fatto di Razzolo quella speranza è sparita. E il governo invia una compagnia di linea a Rocca dove giunge il 25 agosto.
Lo scontro di Spignano, la croce negata e Sacramento
Lazzarino, Spigone, Morigi e Ghigno sono ospiti al podere di Spignano, popolo di Casale, poco distante dal confine. Una dritta di sperimentata sicurezza rivela il loro nascondiglio al delegato di Modigliana che concorda col governatore di Brisighella un’azione congiunta per sorprenderli. La sera del 18/20/1852 due colonne di fucilieri con i gendarmi papalini e granducali circondano la casa colonica e li attaccano di sorpresa. Nel violento scontro a fuoco rimangono uccisi un gendarme, Spigone e Morigi. Lazzarino riesce a fuggire con Ghigno, che morirà d’infezione poco dopo per le ferite riportate. I due briganti sono inumati nel cimitero di Modigliana con sepoltura religiosa, ma il parroco nega loro la croce. Questo provoca il risentimento di don Stiflón che decide di costruirla lui stesso e manda il Calabrese e Cesarino a piantarla sulla tomba. Fa accendere delle candele vicino alla croce e affiggere due fogli alle colonne del Parterre di Modigliana. Spiega che sono una satira le cui parole dicono:
Ai due figli di Cristo
La Croce negata
I compagni di merito
Da essi posero.
La mattina del 26 novembre sono trovate la croce, la satira e un torcetto spento.
Autore della soffiata è stato Antonio Laghi detto Sacramento, bracciante e manutengolo, che per il tradimento riceve una grossa somma con cui acquista una casetta nel Borgo Violano di Modigliana. Lazzarino, unico superstite dello scontro, decide che la spia deve morire e il 19 dicembre, lo cerca insieme al Calabrese per ucciderlo. È un pomeriggio di terrore per le strade di Modigliana finché i briganti raggiungono casa sua dove minacciano la moglie incinta e la figlia; fortunatamente Sacramento è fuori e quell’assenza gli salva la vita. Ma ormai è un uomo bruciato e deve trasferirsi con la famiglia a Firenze dove è sistemato come faticante al magazzino interno e al forno nella Pia Casa di Lavoro di Montedomini. Lì morirà con la moglie durante l’epidemia di colera del 1855. Questa storia è narrata con dovizia di particolari in un libello anonimo affisso a Modigliana i giorni seguenti e che tutti attribuiscono alla penna di don Stiflón per lo stile e la perfetta conoscenza dei fatti.
Viaggio a Pelago
È ancora buio la mattina del 20/5/1853, un venerdì, quando don Stiflón e il Calabrese, lasciano San Valentino per recarsi a Pelago, un paese nel Valdarno sopra Firenze, dove suo fratello Romano, esercita la professione di speziale. Il viaggio ha lo scopo di valutare la possibilità di organizzare un furto ai danni di un possidente del luogo. Prima di partire don Pietro si è impegnato con don Carlo Muini, parroco di Pereta, di celebrare una messa la domenica seguente che è Sant’Andrea, la festa del patrono, promettendogli di tornare in tempo a celebrarla.
Corre voce che già in passato don Stiflón abbia compiuto un furto a Pelago ai danni di un fattore fiorentino. Pare che i briganti siano entrati in casa chiudendo gli abitanti in una stanza e derubandoli di 4.000 scudi. Il fatto lo racconta don Giovanni Tignani, sempre ben informato. La storia l’ha saputa da Giovanni Malpezzi detto Bel Naso [Bel Nes], mercante di bestiame di Terra del Sole, solito frequentare la fiera di Pelago. Dopo quel furto ha visto don Pietro incrociare alla fiera il fattore derubato. Questi lo riconosce e cerca di radunare i suoi contadini per prenderlo, ma lui se ne accorge e scappa. Don Pietro parte accompagnato dal Calabrese; giunti alla locanda delle Balducce si fermano perché un cavallo si è sgambato e vogliono comprarne un altro dall’oste Zanetti per proseguire. In quel momento si ferma alla locanda il Poggiolini, Guièda, il loro macellaio di fiducia, diretto a Dicomano a comprare dei castrati. I due gli chiedono un passaggio e, una volta arrivati, si fanno prestare il barroccino con la promessa di riportarglielo il giorno dopo. Ma a Pelago la polizia locale è in allerta per via di alcune satire e va per le case a cercar dei forestieri.
Il loro arrivo non passa inosservato e il commesso di vigilanza di Pontassieve li segnala in compagnia di persone del luogo che li ospitano per mancanza di comodo dal farmaco Valgimigli, suo fratello. I due ci dormono sopra. La mattina dopo lasciano il paese ritenendo di aver raccolto le informazioni sufficienti a realizzare, in seguito, il colpo e si riuniscono al macellaio, riprendendo la via di casa.
Ma durante il ritorno una pioggia torrenziale rallenta il viaggio e sono costretti a sostare al Muraglione. Il tempo di mangiare un boccone, senza staccare neppure la cavalla e ripartono subito per via dell’impegno preso con don Muini.
Raggiungono le Balducce due ore innanzi giorno e finalmente don Pietro arriva a San Valentino, ma è stanco del viaggio e chiede al cappellano di sostituirlo. Don Ferdinando Fabbri giunge a Pereta sul tardi. Trova don Muini con gli altri parroci sorpresi di non vedere il titolare e si scusa dicendo che ha dovuto aspettare perché l’arciprete era fuori. Celebra l’ultima messa sotto gli occhi incuriositi degli altri sacerdoti e se ne riparte subito dopo il pranzo.
Il tradimento
Il viaggio a Pelago è un passo falso per don Pietro. La polizia sospetta che ricetti i briganti già al tempo della strage dei Lombardi, ma le perquisizioni fatte a S. Valentino non hanno portato ad alcun risultato. Quando il sottoprefetto sa da un fiduciario del suo viaggio a Pelago in compagnia del Calabrese, pensa di avere finalmente le prove che cerca. Verso la fine di giugno lo convoca dicendo di sapere che tiene i ladri in casa» e lo mette di fronte a una secca alternativa: O consegnarli o esser punito! Vistosi scoperto e ormai compromesso, lui promette di farglieli prendere e che se poteva gli avrebbe dati vivi alla forza, altrimenti avrebbe procurato di farli avere morti e, per salvare se stesso, decide di tradirli risolvendo la situazione con i fatti che si sarebbero svolti di lì a poco. Ci riflette sopra concludendo che ha il tornaconto a disfarsi di questa gente piuttosto che consegnarli vivi, giacché dandoli vivi potevano parlare denunciandolo come complice dei delitti che essi avevano commesso andando perfino con loro a rubare. Si sarebbe appropriato del forte deposito di denari che gli hanno dato in deposito e che lui tiene ben nascosto in chiesa, che potrebbe avere un salvacondotto per andare all’Estero e avrebbe riscosso anche le taglie del governo pontificio.
Uccisione di Lisagna, Calabrese e Cesarino
Don Pietro confida al garzone Giacomino gli accordi presi col Vannucchi: M’ha detto il Tribunale che o morti o vivi li dia nelle sue mani. Gli chiede di aiutarlo, ma tutti e due temono la loro reazione. Prenderli vivi è un affaraccio molto più che gli assassini sospettando di lui stanno in guardia. In quel periodo i briganti sono nella parrocchia di Pistoglio nei pressi di Marradi, ospiti di don Ferdinando Fabbri, che è anche cappellano a San Valentino dove sta parecchio tempo e mangia, beve e giuoca con loro ed è a parte di tutto.
Intanto cerca di creare l’occasione risolutiva e manda il garzone a chiamare il Calabrese e Lisagna con la scusa che vuole vederli. I due partono e giungono a San Valentino la sera del giorno dopo. Fa preparare una cena coi fiocchi mettendo tutto il giorno ai fornelli le serve Giuditta e Lucia [di cui diciamo più avanti]. Poi manda Giacomino a Modigliana dal fratello farmacista a prendere l’oppio per drogare il vino. E quando si siedono a tavola lo fa servire: Lisagna ne beve parecchio, il Calabrese l’assaggia appena. L’arciprete, che conosce la loro passione per la caccia, propone di andare la mattina dopo al capanno a tirare ai merli che gli beccano l’uva nella vigna. Il Calabrese accetta, però i due, non fidandosi, preferiscono dormire fuori e ricompaiono all’alba. È il 9/7/1853. Don Pietro prende le schioppe e s’avvia col Calabrese per il sentiero che porta alla vigna. Lisagna, sentendosi poco bene si butta vestito sul letto per riposare.
Arrivati al capanno, il prete butta in terra la borsetta dei pallini e chiede al Calabrese di raccattarla. Mentre quello si china, gli punta il fucile alla nuca e tira una fucilata carica a pallini e a palla ammazzandolo sul colpo. Poi trascina il corpo dentro il casotto, ripulisce alla meglio le tracce e torna di corsa alla canonica dove chiede a Giacomino se ha ammazzato l’altro. Quello risponde che non se l’è sentita, ma che sta sempre dormendo a letto. Allora lo butta da parte e tira a Lisagna una fucilata colpendolo in bocca e al garzone, dalla gran paura che ha, gli scatta il fucile anche a lui colpendolo in una coscia. Don Pietro trova addosso ai cadaveri molti napoleoni d’oro, monete d’argento e diversi anelli, poi fa cucire alle ragazze due sacchi di ghinea (14) per metterci dentro i cadaveri e li fa portare in cantina coperti con una stuoia.
—-
(14) La ghinea era un tessuto di cotone grezzo, grossolano e robusto, utilizzato per la produzione di biancheria, lenzuola e simili e perciò molto richiesto, così detto perché in origine veniva fabbricato per l’esportazione in Guinea.
Manda il ragazzo a chiamare il cappellano e fa caricare i cadaveri sulla sua cavalla per portarli alla tesa del monte della Chioda, vicino al podere delle Muricce. Durante il viaggio la cavalla procede lasciando dietro di sé una scia di sangue perché i sacchi sono stati cuciti radi e, strada facendo, il corpo di Lisagna cade; nel rimetterlo sulla bestia, Giacomino sente che nasconde delle monete intorno alla vita. Prende quei quattrini, circa una cinquantina di napoleoni e li dà all’arciprete chiedendo la sua parte. Ma quello se li intasca rispondendo che toccano tutti a lui perché ha fatto il ladro, l’assassino e il becchino e lo spedisce subito ad avvertire il sottoprefetto Vannucchi. La mattina del giorno dopo da Rocca parte una colonna di soldati che fanno caricare i due cadaveri su una treggia tirata da un paio di buoi fatta venire da un podere vicino. I morti sono esposti nella cappella mortuaria del cimitero di Rocca e in tanti vanno a vederli, ma per riconoscerli sono fatte venire delle persone apposta da Forli e Faenza.
Due giorni dopo manda a chiamare Lazzarino e Cesarino con la scusa di organizzare una rapina e avverte il sottoprefetto che invia una cinquantina di soldati che si appostano dentro la canonica. Lazzarino, in un primo momento è titubante, non si fida del prete, poi si lascia convincere da don Ferdinando che gli dice che se non ci vanno, il Calabrese e Lisagna avrebbero fatto il colpo senza di loro. I due arrivano a San Valentino verso mezzanotte. Appena però Cesarino mette la mano sull’uscio di casa, questo si apre all’improvviso e da dentro parte una scarica di fucileria che l’ammazza all’istante. Lazzarino capisce di essere caduto in un’imboscata e corre a nascondersi dentro un casottino. Qui getta la saccona fuori per ingannare i soldati che gli tirano contro una ventina di schioppettate e lui ne approfitta per scappare giù per il monte. Anche il cadavere di Cesarino è portato al cimitero di Rocca e anche per lui vengono delle persone da Forlì per riconoscerlo.
Per questo successo sono distribuiti premi in denaro ed encomi, ma don Pietro ne riceve solo metà, 50 zecchini, per il parziale fallimento dell’operazione. Chiede a Giacomino di dire che li ha uccisi lui e di prendersi la colpa, ma lui rifiuta. Allora lo minaccia che se fa la spia gli taglia il collo.
Rinuncia alla parrocchia di San Valentino e trasferimento a Tredozio
Dopo questi fatti don Stiflón riscuote i premi delle taglie e si appropria del bottino dei briganti. Da questo momento le sue condizioni economiche migliorano notevolmente e fa acquisti mettendo a frutto parte del capitale. Lazzarino giura di vendicarsi e cerca di recuperare la sua parte. L’arciprete si muove sempre col fucile perché teme la sua vendetta, supplica il granduca di allontanarlo dalla parrocchia e chiede un sussidio per provvedere alla propria sicurezza personale e per pagare un altro prete che lo sostituisca durante la sua assenza. Gli viene concessa provvisoriamente e riservatamente una sovvenzione di 400 lire. Ma il tempo passa, i due sono stanchi e si temono a vicenda. Per accomodare le cose mettono di mezzo un sensale, Filippo Zauli detto Filippone [Flipòn], raggiungendo alla fine un accordo. La transazione avviene sul monte Busca dove don Pietro sborsa la porzione dell’oro spettante a Lazzarino che, da parte sua promette che avrebbe fatto a monte di tutto. Filippone dice che i due si riappattumarono, perché l’uno aveva paura dell’altro e don Pietro smette di girare armato. Quando monsignor Mario Melini, arriva a Modigliana il pomeriggio del 4/5/1854, proveniente da Montalcino, per insediarsi nella nuova diocesi, il primo problema da affrontare è la gestione del caso Valgimigli che, risolta la pendenza con Lazzarino, non vuole più andarsene da San Valentino. Il 6 giugno il ministro degli Affari Ecclesiastici mons. Giovanni Bologna lo informa che ci sono gravi e urgenti ragioni per allontanarlo perché la sua presenza è uno scandalo da rimuovere e gli chiede di concertare ogni iniziativa col sottoprefetto Vannucchi per convincerlo a rinunciare alla parrocchia. Don Pietro accetta colla condizione che gli siano assegnati 100 scudi annui di pensione. Ma poi ci ripensa e cinque giorni dopo il padre Cammillo va in arcivescovado con ulteriori pretese: una persona di fiducia che valuti le migliorie apportate alla chiesa, alla canonica e ai poderi di San Valentino e una pensione non minore di lire 1.000 ogni anno per vivere dignitosamente fuori della parrocchia. Mons. Bologna dice che il parroco esagera e che dovrebbe accontentarsi della decorosa offerta, superiore alla sua attuale rendita. Ma, in una nota a parte, dà al vescovo carta bianca per ulteriori aumenti fino alle reclamate lire 1.000. Trascorsi alcuni giorni senza risposta, don Pietro interpreta il silenzio del vescovo come assenso alla sua permanenza a San Valentino e lo informa che avrebbe iniziato subito i lavori alla canonica per far fronte all’inverno. Ma, Eccellenza, il prete minaccia, il vescovo non teme! e monsignor Melini chiede che le sue richieste siano sollecitamente risolute pur di allontanarlo per sempre dalla parrocchia. E se da una parte manovra per avere la pensione, dall’altra don Pietro fa gli ultimi disperati tentativi per restare a San Valentino. E il 29 settembre Santi Chiarini e Giovanni Farolfi si presentano davanti al vicario foraneo di Tredozio, don Cesare Leoni, per sapere quali fossero i motivi per i quali il loro arciprete doveva partirsi per sempre dalla Chiesa, chiedendogli di farsi portavoce e scrivere una petizione al vescovo per informarlo che il popolo in massa, era dispiacente di tale rimozione. Loro avrebbero organizzato la raccolta delle firme fra i parrocchiani. I due sono partigiani di don Valgimigli benissimo cogniti dal Tribunale e veramente degni di colui, di cui patrocinano la causa. Don Cesare, intimorito, firma anche lui e la mattina del 2 ottobre si presenta all’arcivescovado alla testa di una delegazione di cinque persone di cui fanno parte anche il Chiarini e il Farolfi. Ma mons. Melini dice che hanno sbagliato strada perché non dipende da lui ciò che domandano essendo solo un esecutore degli ordini superiori. Lo stesso giorno spedisce la supplica a Firenze censurando il comportamento del vicario foraneo e chiedendo di porre fine, una volta per tutte, a tali vergognosi maneggi e così togliere al Real Governo ed al Vescovo ulteriori inquietezze.
Una settimana dopo è presentata direttamente al granduca una nuova istanza a firma di Santi Chiarini, anche questa volta preparata da don Valgimigli, in cui si chiede di non rimuoverlo perché: Esso adempie esattamente ai suoi doveri come parroco; assiste volonteroso agli infermi e come medico e come infermiere; aiuta e soccorre i poveri, gl’indigenti, si presta sollecito ad ogni bisogno, ad ogni urgenza, si fattamente soddisfa tutti, che tutti niuno escluso hanno posto la loro firma nella istanza a mons. vescovo diretta e sono pronti tutti a dichiarare quanto affermano ovunque e quando ne siano richiesti, ma la manovra non riesce.
Don Pietro si convince allora di proseguire sulla strada della rinuncia e chiede e ottiene una nuova valutazione dello stato economico della parrocchia a lui più vantaggiosa.
Il 14 agosto mons. Bologna trasmette al prefetto di Firenze, da cui dipende la sottoprefettura di Rocca, il decreto granducale che, preso atto delle eccezionali circostanze, assegna al Valgimigli un’annua pensione personale di lire 1.000 in tutto conforme alle non discrete esigenze del nostro reverendo, perché al nemico che fugge devonsi fare ponti d’oro, informandolo che si è dovuto camminare a vapore sull’affare Valgimigli e si è dovuto fare a modo di quel tristissimo soggetto impedendo l’osservanza del consueto procedimento ufficiale. La pensione comincerà ad avere effetto col primo dell’anno imminente 1855, pagabili in due rate semestrali, a giugno e a dicembre di ogni anno e il 12/1/1855 viene emesso il relativo decreto granducale munito di R. Exequatur.
Il 30 dicembre don Pietro rinuncia liberamente e spontaneamente alla parrocchia e si stabilisce a Tredozio, dove però nessuno gli fa buon viso e la gente lo teme e lo evita. Di ciarle se ne fanno tante nel chiuso delle mura domestiche, ma poi fuori, in piazza, tutto tacciono per paura di ritorsioni.
Ma è l’epidemia del colera esplosa nell’estate del 1855 a risollevarne le sorti e don Stiflón per avere il popolaccio dalla sua parte e per farsi benvolere si butta allo sbaraglio al Lazzaretto, così allora qualcuno comincia ad avvicinarlo. Il consiglio comunale gliene affida la direzione ringraziandolo poi con una delibera piena di encomi per essersi prestato all’assistenza gratuita degli infermi, non solo spirituale, ma anche sanitaria. Intanto, mentre il vescovo assegna a don Cesare Leoni l’arcipretura della parrocchia di San Valentino, don Pietro ottiene l’uffiziatura dell’ultima messa nelle feste nella chiesa di San Michele a Tredozio col permesso del parroco e del gonfaloniere. Così, da quel momento in poi, tutti si mostrarono meno sdegnati è il commento del barrocciaio Luigi Poggiolini detto Ciula e Bulone [Bulòn], suo vicino di casa.
Il tesoro di don Stiflón
Possiamo fare un conto della sua disponibilità finanziaria a seguito degli introiti delle rapine e ricompense avute con il tradimento e l’uccisione dei briganti. Dopo aver ammazzato Lisagna e il Calabrese, don Pietro si appropria di quanto hanno indosso: un centinaio di napoleoni d’oro, altrettanti d’argento, diversi anelli e una bella schioppa. Due giorni dopo, a seguito dell’uccisione del brigante Cesarino, viene ricompensato dal sottoprefetto di Rocca con 50 zecchini, la metà di quelli pattuiti perché Lazzarino riesce a fuggire. In questa occasione si appropria del bottino dei briganti. Si parla di 20.000 scudi con cui il prete compra diverse case e un podere, mentre una parte li dà a frutto a un signore di Forlì. In più riceve una sovvenzione di 400 lire per provvedere alla propria sicurezza personale. In seguito fa la pace con Lazzarino e gli ridà la porzione dell’oro a lui spettante. Ai primi del 1855 lascia la parrocchia di San Valentino e si trasferisce a Tredozio: gli viene assegnata una pensione di 1.000 lire ... per la di lui vita naturale. Quando il nuovo Stato italiano gli sospende la pensione granducale in quanto non ha derivazione legale ed è puramente graziosa», lui fa ricorso all’Amministrazione del Fondo per il Culto. Alla fine la spunta e la pensione gli viene ripagata, arretrati compresi.
3. Una vita lussuriosa
L’11/1/1857 Lazzarino viene catturato all’Alpicella, nell’Alpe del Corniolo sopra Santa Sofia, concludendo così la sua carriera di brigante con la fucilazione a Bologna all’alba dell’8 maggio sul terrapieno delle mura fra Porta S. Felice e quella di S. Isaia. In quello stesso momento don Stiflón fa una vita da gran signore ed è all’apice della sua carriera di puttaniere. È proprio nei giorni freddi e nevosi di quell’inverno che i gendarmi granducali lo sorprendono nottetempo sul ponte di Tredozio, mentre esce da casa sua nascondendo sotto il ferraiolo (15) la giovane Veronica Tassinari figlia del becchino del paese, cucitrice di bianco e lavandaia e moglie di Luigi Poggiolini.
—-
(15) Ampio mantello di seta o di altra stoffa leggera di colore rosso, violaceo o nero, a seconda del grado di chi lo porta (cardinale, vescovo o sacerdote) annodato al collo con strisce dello stesso colore. Per estensione, in passato, mantello da uomo in genere, di solito senza maniche, con o senza bavero.
La polizia sa che questa donna è anche la mezzana nella tresca tra il Valgimigli e la Ghetti, un’altra sposa con cui il sacerdote sfoga le proprie brutali passioni, ma le due non sono che pedine di un gioco più grande creato da don Stiflón. Un rapporto riservatissimo, lo descrive: Capace di ogni delitto, spregiatore delle cose più sacre, dedito soltanto allo sfogo delle più brutali passioni, ha posto lo scompiglio in varie famiglie coltivando illecite tresche con donne specialmente coniugate, i mariti delle quali tacciono sul proprio disonore per tema d’incorrere nella vendetta inesorabile di quell’uomo temutissimo da tutti». Il medico venturiere (16) Giuseppe Fabroni ne fa un elenco alla commissione d’inchiesta.
—-
(16) Persona che esercita la professione o il mestiere alla ventura, cioè senza avere uno stipendio fisso da qualcuno, liberamente ora qua ora là, esempio: medico venturiere.
Si contano fra queste donne del Valgimigli per prima la signora Anna Monti moglie di Giovanni Ghetti possidente di Tredozio; la signora Umiltà Monti e anche la signora Assunta Monti moglie di Giuseppe detto il Papa; queste sarebbero del ceto delle signore. Fra le persone più basse poi il Valgimigli conta pure le sue favorite e sarebbero una certa Billi Rosa, una certa Tronconi ed altre tutte maritate.
Tra queste spicca Umiltà Monti che, apprendiamo dal libro di Bonfante: era una donna molto “svelta” e peggio; era vedova e in casa sua si facevano anche i “balli angelici”, cioè i balli in cui si ballava senza vestiti addosso». E un testimone aggiunge che è arrivata persino a far sparire il bambino della sua serva perché aveva un cagnolino piccolo rimasto senza mamma, così lo fece allattare alla serva.
Anche don Stiflón frequenta le feste da ballo di Carnevale vestito mascherato da donna, con visiera di ferro a buchi che solevano usare gli assassini e con dei smanigli d’oro, ma siccome l’ignoto è alto e sottile e un personale come lo ha il Valgimigli la gente non ha difficoltà a riconoscerlo dietro la maschera femminile. Pellegrino Artusi, che anche dopo il trasferimento a Firenze è informato dai commercianti romagnoli sugli sviluppi della vicenda di don Stiflón, commenta nelle sue memorie: Ma credete che qui finisca la storia di quel prete infernale? Neppure per sogno. Andò egli a stabilirsi a Tredozio e colà mise in agitazione tutto il paese. Gli venne fatto di contrarre una relazione amorosa con la moglie di uno di quei signori e poi, essendo scoppiato il colera, si dié a corpo morto, per farsi credito, a soccorrere ed assistere i colerosi cosicché formatisi due partiti, uno dei gonzi (che sono sempre i più) i quali lo proteggevano e l’altro dei ben pensanti che gli avrebbero dato fuoco, egli coraggioso com’era, andava a celebrar messa con la pistola in tasca. Queste cose, a lui relative, mi erano narrate da persone di quei luoghi degne di fede e don Giovanni Verità di Modigliana, il buon prete che salvò al vita a Garibaldi ed è ricordato con lode nelle sue memorie, mi raccontava fra le altre cose che un giorno i compagni del Passatore essendo venuti a questione fra loro, mentre sedevano a tavola, uno di essi si scagliò sul compagno che gli stava in faccia e con un colpo di arma affilata gli tagliò netta la gola. (17)
—-
(17) P. Artusi, Autobiografia, cit., p. 48.
Don Pietro ha già avuto storie con altre donne.
La prima con Lucia Cangialeoni, al suo servizio dal 1848 al marzo 1855, che mette incinta per due volte e poi accasa, con un matrimonio di comodo, con Giacomino Tronconi, detto Jacmèn, il giovane casante-sacrestano. E il secondo figlio muore quasi subito di stenti perché anche lui la costringe ad allattare un cucciolo di cane a cui tiene molto essendo appassionato cacciatore. La seconda con Giuditta Villa che subentra alla cugina Lucia. Giuditta ha 22 anni quando nel 1853 la sostituisce nelle faccende domestiche, anche se poi lei e suo marito Giacomino, vanno ad alloggiare presso la canonica continuando a prestare servizio per lui e Giuditta ammette che le ha insegnato molte cose perché all’inizio non sapeva fare proprio niente. Don Pietro fa subito presa sulla giovane che rimane clandestinamente incinta e la voce pubblica la indica come la sua druda. La ragazza va a sgravarsi dal cugino Bastiano a Val di Varana, parrocchia di Fregiolo. Tre anni dopo Giuditta aspetta un altro figlio ed è costretta a lasciare la parrocchia e cercar servizio presso altre famiglie di Tredozio.
Don Pietro, per mantenere la tresca, la mette in casa di Giuseppe Monti detto il Papa, possidente di Tredozio, 62 anni, vedovo con una figlia già grande, sposato in seconde nozze con la giovane Assunta Cavina. Don Pietro ha una relazione anche con lei e procura il maritaggio alla figliola per rimaner libero e frequentare la casa con la scusa di fare da maestro ai suoi bambini. C’è anche chi li ha scoperti in un bosco in attitudine oscena e chi ha trovato l’arciprete e l’Assunta abbracciati in casa. Anche lei partorisce un maschio che nel paese si mormora che per l’espressa somiglianza con lui si palesa per suo figlio e lo stesso prete se ne vanta ed è poi somigliantissimo al primo bambino partorito da Giuditta.
Intanto la pancia cresce; Giuditta non è più in grado di prestare il servizio di prima in casa Monti e tutti dicono che ha fatto un altro figliuolo con l’arciprete. La giovane è liquidata con 4 o 5 francesconi e viene licenziata e don Pietro deve smettere di frequentare la famiglia.
Per sistemarla propone ad Antonio Monti detto Macacco, un faticante della casa, di sposarla e ne parla con don Cesare Poggiolini, parroco di San Pietro a Castagneto, onde sia affatturato il matrimonio. Assunta, saputa la cosa, si arrabbia perché dice che in casa sua non vuole tresche e licenzia anche il garzone. Don Pietro allora la convince ad andare a Firenze per abortire. Il 30/9/1857 parte per la capitale con Macacco che le paga le spese sostenute per i giorni trascorsi in città per trovare un impiego. Prende servizio in casa di Gaspero Doni, scritturale di Burò al ministero dell’Interno, abitante in via dei Leoni nel centro di Firenze dietro Palazzo Vecchio. Ma non può nascondere la gravidanza a lungo e due mesi dopo don Pietro la raggiunge, alloggiando in una locanda sotto falso nome, per procurarle mercé dei medicinali un violento aborto. Dei contrattempi non previsti ostacolano la pratica e il 21 dicembre Giuditta è ricoverata per sgravarsi del feto nell’Ospizio dell’Orbatello, da dove è dimessa il 25 febbraio dell’anno dopo tornando a servizio del Doni. Il neonato è portato nel vicino Spedale degli Innocenti. All’epoca, una parte di questo edificio era destinata alle gravide vergognose e qui finivano gl’infanti abbandonati, i cosiddetti gettatelli, innocentini o nocentini. Lo Spedale esercitava la sua beneficenza nella provincia di Firenze, nel Mugello e nella Romagna toscana dove erano aperti gli spedaletti succursali a S. Piero in Bagno, Modigliana, Premilcuore e Galeata. Ed è probabilmente questo il percorso di Giuditta nel suo travagliato parto clandestino del figlio della colpa.
Il suo posto è preso da Veronica, la donna con cui è sorpreso dai gendarmi nel gennaio 1857. Nel frattempo pratica anche Rosa Billi, che gli fa da moglie e va da lui tutte le notti in quanto, essendo di bassa estrazione, di giorno il prete la evita perché, come ha ben spiegato il dottor Fabroni, gli piace distinguere fra il ceto delle signore da frequentare in pubblico e le persone più basse con cui è bene non farsi vedere. Anche lei si presta a fare la mezzana, ma siccome è di lingua lunga, don Pietro le proibisce anche di andare a servire in casa Monti dall’altra sua amante Assunta; infine la licenzia.
Intanto inizia anche una liaison con Anna Monti sposata con Giovanni Ghetti, (18) che la stessa Veronica e sua sorella Maria accompagnano a casa sua e quando i due si appartano in camera, loro aspettano in cucina.
—-
(18) Don Pietro definisce Giovanni Ghetti un coticone zotico, sguaiato e ignorante; sta di fatto, però, come ci spiega Bonfante, che successivamente divenne capitano della guardia civica, assessore e poi sindaco; partecipò alle guerre d’indipendenza e fu il fondatore della Società di Mutuo Soccorso di Tredozio a cui lasciò in eredità il suo palazzo e tre poderi. Forse don Pietro non lo teneva in gran stima essendo questi il marito di una delle sue donne e di idee anticlericali.
Una relazione molto chiacchierata perché la sua famiglia è una delle più in vista del paese. Anna è figlia di Calocero Monti, un uomo astuto e intelligente che ha iniziato la sua carriera raccattando da ragazzetto lo sterco per le vie con un cesto in mano e qualche volta a campar d’accatto fino a diventare l’amministratore del patrimonio della ricca famiglia di Filippo Bonaccorsi. (19)
—-
(19) La famiglia Bonaccorsi Dolcini Dal Prato è iscritta nel Libro d’oro del patriziato fiorentino ed è considerata la più ricca di tutte le Romagne. Dal matrimonio di Filippo Bonaccorsi con Rosa di Pier Matteo Ragazzini nascono quattro figlie: Eleonora, Ortensia, Rosa e Anna. Quest’ultima va in sposa a Bettino Ricasoli, un testimone è lo stesso Calocero, con un matrimonio d’interesse che risolleva le deplorevoli condizioni in cui versano le finanze del nobile toscano. E quando il barone, alla prematura morte della moglie liquida tutto il patrimonio immobiliare romagnolo, gli riserva un trattamento di favore cedendogli numerosi poderi a una somma decisamente contenuta a ricompensa alle straordinarie occupazioni avute come amministratore dei suoi averi. In: D. Bronzuoli, Matrimoni e patrimoni, Firenze, Ed. Polistampa, 2013, pp. 29, 68 e segg. E quando Bettino, governatore delle Provincie Toscane, dovrà valutare le istanze di grazie e riduzione della pena di don Pietro, i suoi legami affettivi ed economici con Tredozio di certo avranno influito nelle sue decisioni.
Calocero sa che all’arciprete piacciono le donne, ma finge di non vedere niente anche se la loro storia è sulla bocca di tutti. (20)
—-
(20) Don Pietro ha il dente avvelenato nei confronti di Calocero, che nel suo Sogno alle Murate, il racconto fantastico che scrive quando è detenuto nel carcere fiorentino, identifica nella figura del ladro che deruba il ricco signore (Filippo Bonaccorsi) e i suoi fratelli due preti don Giovanni Battista, suo compare e don Andrea, parroco di San Benedetto in Alpe e un secolare Giuseppe detto il Papa, noto per essere un uomo pio, che fa rinchiudere in manicomio. E lui stesso che dal matrimonio con Teresa Fantini, di diciassette anni più giovane, ha due figli, maschio e femmina, fa con lei la separazione di toro, così scrive don Pietro, per non disperdere l’ingente patrimonio accumulato.
Il marito Giovanni è una persona specchiata, ma debole e tutt’altro che acquiescente a questa tresca, ma non ha il coraggio di reagire. Il suocero Paolo Ghetti è uomo più risentito, ma pure lui non si azzarda a dir nulla e chiede all’avvocato Pietro Fantini e a suo fratello Lorenzo, gli zii, di convincerla a cessare quell’indecenza, ma la donna nega tutto. E probabilmente per causa del patema d’animo che gli procura la condotta della nuora, alla fine ha un accidente che lo blocca, sebbene sia ancora in grado di parlare. Ma le chiacchiere sono insistenti perché i due sono stati visti insieme lungo il fiume Tramazzo in una brillera, verso la mezzanotte in attitudine turpe e il prete trovandosi una volta in casa della donna malata, con la scusa di tastarle il polso, mise le mani sotto le lenzuola e invece gliele teneva fisse nelle parti pudende, senza alcun riguardo alle persone che vi erano presenti fra le quali il padre del Ghetti di lei marito, il quale non si azzardò a non dire nulla per il gran timore che ha di questo prete. I due si vedono anche conversare senza alcun riguardo sulla pubblica via e la gente mormora che quel becco del marito, si strugge dalla passione, ma tace ed é in grave apprensione pel conosciuto feroce carattere del prete ed anche per quello assai capriccioso della propria moglie. E a volte s’incontrano pure in qualche locanda compiacente a Firenze dove lui si presenta travestito e sotto falso nome.
4. L’indagine segreta prefettizia
La situazione si è spinta a tal punto che nel giugno 1857 la Dominante sollecita un’indagine su don Stiflón essendo la sua condotta a Tredozio motivo di grande scandalo. Ma il sottoprefetto ha difficoltà a trovare chi sia disposto a deporre. Alla fine riesce a convocare in segreto alcuni notabili di Tredozio: l’avvocato Pietro Fantini, possidente; Andrea Leoni, speziale di Tredozio, fratello di don Cesare Leoni vicario foraneo di Tredozio succeduto a don Valgimigli nella cura di San Valentino; Calocero Monti direttamente interessato perché è il padre di Anna; Luigi Brenti, possidente; Angiolo Vivoli, di Firenzuola, medico condotto a Tredozio; Giuseppe Fabbroni, medico chirurgo di cui abbiamo già detto.
Tutti chiedono garanzie per la loro incolumità, accettano a condizione che la deposizione sia segreta e confermano che egli tiene ora pratiche scandalose e immorali con diverse donne coniugate e no, ben spargendo il disordine e la discordia in alcune famiglie, che impudentemente ha esercitato atti gravissimi e ributtantissimi alla vista altrui, che esercita illegalmente la medicina, che professa massime antireligiose e perverse, che è dedito ai brogli, al giuoco, alla crapula, che si mostra dissoluto fino alla nausea, di niuna fede politica, regolato solo dai propri appetiti e dalle proprie passioni, conculcatore di ogni Legge Divina ed umana, prepotente, tenace nelle persecuzioni, temibile nell’ira, dispregiatore di ogni rimorso, pronto e capace di ogni delitto. In particolare, il farmacista è tra i più intimoriti, viste le grandissime relazioni di don Pietro non solo in Tredozio, ma anche con impiegati molto alti, ed anche in Firenze e si sente colpito sotto l’aspetto professionale e familiare. È notorio, dice, che il prete Valgimigli esercita la medicina e nessuno, neppure fra quelli della polizia, ha il coraggio a denunziarlo e con la sua ciarla trova anche dei creduloni che gli danno retta e si fanno medicare da lui ed anzi a Modigliana vi è il suo fratello speziale, che spedisce quante ricette detto prete gli manda. Da parte sua si è astenuto più che ha potuto, ma siccome una volta il prete lo ha minacciato, ora si limita a dare dei medicinali semplici, come olio di ricino, rabarbaro, santonina (21) e simili, che si vendono anche dai droghieri, tanto per non urtarlo di più.
—-
(21) Santonina: principio attivo contenuto in diverse specie del genere Artemisia, usato in medicina come vermifugo.
In materia di religione è un ateo, e uno che non crede a nulla, o crede a modo suo. Per lui non è peccato l’adulterio, l’incesto e lo stupro, ed egli stesso ha detto che questi fatti non sono proibiti dal Vangelo, e che sono immaginati dai preti per tenere la pace nelle famiglie, ed anzi ha rimproverato mio fratello prete perché ha denunziato le fanciulle incinte del suo popolo, dicendo che son cose che non vanno avvertite e anche il vescovo ha paura, e perciò lo tollera. Spende e spande oltre i limiti di quello, che si conosce che abbia, prosegue il farmacista e la sua casa è aperta a tutti i più viziosi del paese; costì vi si tiene gioco e vi sono crapule e gozzoviglie continuamente e con questo mezzo ha saputo procacciarsi molti aderenti, che gli fanno una polizia a parte. È anche dedito agli imbrogli e con questo mezzo si procura aderenti, non mancandogli né testa, né istruzione, né furberia. Il Fabbroni è stato scolaro con don Pietro, ma della vecchia amicizia non resta più nulla e osserva che quelli che lo evitano in pubblico, in privato lo invitano a far la partita nelle loro case. Anche lui sa che esercita illegalmente la medicina, senza però essere a conoscenza di conseguenze sinistre per i malati. Calocero Monti conferma la pessima fama dell’arciprete per avere ricettato i briganti, partecipato alle loro ruberie e condiviso i bottini e per averne lui stesso ammazzati tre. Finge di non sapere dei fatti di famiglia, ma sa delle tresche illecite con varie donne anche maritate e crede che alcune di loro vi si prestino per i quattrini che egli sparge a piene mani. Anche nella conduzione del suo ministero è irreligiosissimo ed esprime massime contrarie al Vangelo, dicendo che il trattar le donne non è peccato e sottolinea anche la sua attività di sensale di pochi scrupoli perché fa da cavalocchio, (22) e tratta gli affari dei terzi e dei quarti, fa dei compromessi, delle scritte, e dà consigli per interessi a questo e quello.
—-
(22) Cavalòcchio: Chi fa l’avvocato in cause di poca importanza o senza averne il titolo, senza porsi eccessivi scrupoli. Quegli che prezzolato riscuote i crediti altrui e fa de’ garbugli e degli abbindolamenti legali (P. Fanfani, Vocabolario dell’uso toscano, Firenze, G. Barbera, 1863).
Il Vivoli abita vicino alla casa di don Pietro e perciò vede chi la frequenta: persone del popolino, che il prete alletta per procurarsi le loro simpatie, intrattenendole nel giuoco, nella crapula senza neppur riguardo alle ore delle sue funzioni. Anche lui è a conoscenza dei suoi intrallazzi amorosi e conferma che esercita la medicina senza alcuna matricola, spedisce ricette ed ha persino vaccinato dei bambini, procurandosi da Modigliana i medicinali occorrenti per le cure che egli intraprende. Al termine delle deposizioni i testimoni si rifiutano di firmarle dicendo di essersi già troppo esposti con le sole dichiarazioni a un grave pericolo e non le ripeteranno in una pubblica udienza.
5. L’arresto e l’interrogatorio alle Murate
Ragguagliato sulle malefatte del prete romagnolo, lo stesso Canapone, il granduca Leopoldo II, ravvisa opportuno un provvedimento disciplinare atto a frenare in lui tanta licenza e il ministro degli Affari Ecclesiastici chiede di rimuoverlo con discrezione dal paese e di tradurlo sotto buona scorta alle carceri pretoriali di Firenze, per contestargli in modo bastantemente sicuro e tranquillo le sue defezioni con la circospezione necessaria per tutelare i testimoni che temono di esporsi con le loro dichiarazioni.
Il prefetto dispone un’inchiesta, questa volta non più segreta, per stabilire la gravità degli addebiti contestati e ordina la sua carcerazione chiedendo di agire con efficacia per evitare disgustose emergenze. La Ministeriale con l’ordine dell’arresto giunge con la diligenza della mattina del 14/1/1858. Per assicurare la massima segretezza dell’operazione, si decide di far agire la gendarmeria di Rocca e non quella di Modigliana dove don Pietro ha parenti e amici e può in qualche modo venire a saperlo. La trappola scatta la mattina del giorno dopo: mentre don Pietro esce di casa per recarsi in chiesa a celebrare la messa è arrestato e tradotto nel quartiere della gendarmeria locale ed ivi trattenuto fino a sera con i riguardi dovuti al suo carattere sacerdotale. Quando la situazione è più tranquilla e tutti sono rientrati in casa, viene caricato sul calesse di Luigi Poggiolini, Bulone e trasferito a Rocca per la strada ghiacciata del monte Busca che costringe gli uomini della scorta a scendere e a camminare a piedi. La notte seguente è tradotto a Firenze dove giunge il 18. Qui viene registrato al Bargello dove sono espletate le formalità di rito, poi è trasferito nel carcere delle Murate in una stanza ben sicura e totalmente separata da altro detenuto e con le cautele prescritte, si raccomanda il prefetto, in conformità del Concordato tra i Governi Toscano e Romano. Appena Anna Ghetti apprende la notizia, decide di seguirlo. Dice al marito che le sarebbe piaciuto tornare a Firenze dalla zia Marianna per trascorrere un po’ di giorni per il carnevale. L’uomo acconsente. La sera stessa va a Rocca a casa di Pompeo Valgimigli, fratello del prete, per valutare il da farsi. Poi, travestita da uomo, parte subito per la capitale. Quando sa del suo arrivo, don Pietro le scrive una lettera apparentemente formale, ma con il preciso scopo di attivare all’esterno procedure utili per farlo uscire di prigione. La censura del carcere intercetta e blocca il mes- saggio. Ma Anna entra subito in azione e la mattina del 21 gli manda una colazione: caffelatte e semel, (23) e dentro il semel ha nascosto un biglietto con un messaggio: Tentiamo ogni mezzo per metterci in comunicazione con te per giovarti, salvarti se è possibile.
—-
(23) Il Vocabolario dell’uso toscano, cit., definisce il semel una foggia di piccolo pane finissimo e di particolare lavorazione, che suole usarsi intingere nel caffè e altre bibite a colazione. C’è chi lo mangia anche a pranzo.
So tutto e siccome il disperarsi non giova, procuro renderti meno peggio la tua prigionia. Domattina verrà Ernesto a nome di tuo fratello Pompeo a sentire di dove desideri ti sia portato il pranzo e tu dirai: dalla Villa de Paris. Dopo pranzo ti verrà servito un caffè, nel manico del bricco vi sarà l’occorrente per poter rispondere, prova ogni mezzo per svitarlo, tieni il lapis e metti la risposta dove trovi la roba. Io sono stata alla Rocca da Pompeo. Qualunque cosa ti sia portata osservala attentamente, sia stufato, fritto, tabacco, insomma tutto. Addio Pietro ama chi ti adora, ti è fedele e sarà sempre tua a costo della vita. Spero che mi risponderai che sono disperata, te lo figuri. Un bacio il più tenero ti dà la tua sposa con la speranza che tu l’ami ancora». Ma il
trucco è scoperto e il corriere arrestato e don Pietro ha tanto rancore in corpo se è vero, come riferisce il fiduciario della polizia, che in una lettera scritta alla Ghetti le chiede: Se mi ami procura di uccidere tuo marito.
Durante la sua permanenza fiorentina Anna sa che è sorvegliata, ma è brava a dissimulare i suoi movimenti e riesce a sapere che il delegato di Santa Croce di lei dice che fino ad oggi non ha dato da sospettare in alcun rapporto colla propria condotta e che il suo soggiorno nella capitale, non ha altro scopo che quello di un semplice passatempo, tanto più che la Vespignani, [la zia] usufruttuaria dello stabile in cui dimora, è donna che fino ad oggi non ha dato da sospettare in alcun rapporto colla propria condotta. Ma la sua lontananza dalla famiglia si prolunga oltre i limiti del lecito, il marito e il padre fanno di tutto per ricondurla al tetto maritale e la sera dell’8 marzo, Calocero va a riprendersela e la riporta a Tredozio tenendola a casa sua per un po’ di giorni, colla veduta di riunirla in seguito al marito e di richiamarla con paterne ammonizioni a più esemplare condotta, appartenendo ad agiata ed onesta famiglia. Intanto il prete passa i giorni in isolamento finché il 7 febbraio è condotto nella stanza degli esami ordinari dove lo attende il delegato di S. Croce. Don Pietro protesta di non conoscere il motivo dell’arresto. Il funzionario gli contesta di aver tenuto una condotta non solo irregolare, ma di più eminentemente riprovevole, la fierezza del carattere e una effrenata tendenza al libertinaggio.
Don Pietro si difende dicendo di aver dato un grosso contributo al governo nel disperdere i malfattori di Romagna e questo gli ha provocato l’odio di alcuni funzionari governativi locali gelosi del suo rapporto diretto col sottoprefetto di Rocca e di alcuni tredoziesi che avevano complottato per ottenere il suo arresto. Si è sempre comportato come uomo pacifico, prudente e facile al perdono. Conserva ancora gli attestati di riconoscenza del gonfaloniere, di alcuni priori e del pievano in occasione del colera e può dire che il popolo di Tredozio è con lui. Chiede i nomi dei suoi accusatori. Per tutta risposta, il delegato replica che il processo è ultimato e non ci saranno ulteriori esami. Anzi, sostiene che le misure prese dal governo sono dirette non tanto a punirlo, quanto a tutelarlo. Lui ringrazia per l’aiuto sebbene trovi strano ottenere la sua sicurezza col rimanere detenuto in un carcere penitenziario.
Dopo quell’unico interrogatorio resta in una snervante attesa degli eventi. E ragiona: ma se il processo è finito, perché non si è ancora giunti a delle conclusioni? E perché non gli è consentito di difendersi?
Nelle sue memorie difensive dice di non conoscere il motivo del suo arresto. Di aver lasciato la parrocchia su pressione del vescovo e del governo. Nessuno si è mai lagnato sul suo conto.
È stimato da tutti i signori di Tredozio, ammesso in quasi tutte le case di persone oneste ed estimato poi direttore del lazzaretto ai tempi del colera. Di più, ha avuto anche l’assistenza di parecchi malati nelle primarie case del paese, per lo che questi signori non avrebbero di certo avvicinato una persona la quale si fosse macchiata, come viene falsamente dedotto, di così gravi misfatti. Anzi, prosegue, vorrei che mi si trovasse una sola persona colla quale in tre anni abbi avuto che dire né il minimo dissapore e che sia capace di fare di me quel carattere, che per quanto sento mi viene attribuito.
Gli viene contestato di essere un soggetto facile all’ira, come capace di qualunque vendetta; di sbrigliarsi cioè ad ogni genere di vita licenziosa e di corruttela ad ognuno disdicevole, specialmente poi a chi riveste il carattere sacerdotale; di sedurre un buon numero di donne nubili e maritate con oltraggio impudente alla morale e con detrimento anche gravissimo dell’ordine della famiglia. Non è vero, ribatte, perché con molte parole non si fa neppure un fatto ed io vorrei che mi fossero contestati fatti precisi e non rimproveri generici. Dicono che lo hanno visto in congressi con femmine in luoghi, tempi e modi da ritenerli senza velo per disonesti avvicinamenti, da cui si dice che sono nati anche dei figli che apertamente si designano come miei. Lui può solo dire che ha parlato con delle donne, ma non in modo disonesto, né in modo da dar sospetto se nonché a quelli che hanno la vista più acuta dello stesso Dio, da poter conoscere nei figli nati a quale padre appartengano. Gli sono state contestate anche altre sue inclinazioni viziose come il giuoco, la crapula, l’associazione ai più depravati, l’esercizio illegale della medicina e l’arresto è stato eseguito a seguito degli ordini del Superior Governo e per misura di alta polizia. Lui può solo rispondere di essersi qualche volta divertito con persone oneste e in modi limitatissimi, di aborrire la crapula, di non aver accostate persone per alcuno modo riprovevoli; di avere qualche volta assistito i malati, ma non come medico. Tutte queste sono solo calunnie. Ma perché nessuno mi ha mai rimproverato o si è bonariamente lagnato, se non direttamente ma anche per mezzo di terze persone con me stesso?ribatte don Pietro e riflette: Alla fine di questo processo posso dire che ora finalmente so di soffrire non per mancanze che io abbia commesso, ma unicamente per cattiveria e malignità altrui. Non mi furono contestate se non che incoerenti chiacchiere, maligne supposizioni e un ammasso di ingiuriosi, infamanti vituperi, che
alcuni signori di Tredozio forse per privati odi e vendette hanno vomitato in un modo vergognoso contro di me. Non mi si è accennato neppure un fatto particolare, neppure una persona mi si è determinata ... Ecco la ricompensa, conclude, che i tredoziesi assegnano alle immense fatiche, che io sostenni nella luttuosa circostanza del colera e ciò non mi giunge nuovo, perché io sapevo di aver fatto troppo bene a quel paese per non dovermi aspettare la mercede, che Cristo preannunzia in terra a quelli, che per amor di lui sacrificano se stessi al bene altrui.
La sua famiglia intanto si attiva per cercare di capire meglio gli sviluppi della vicenda e manda Giacomino a Firenze per avere un colloquio con lui, ufficialmente per curare i suoi interessi e riferire alla famiglia sullo stato in cui si trovava il detenuto. Il giovane, analfabeta, si fa scrivere la richiesta dell’incontro in cui il motivo è per interesse di un paro di manzi venduti al Casetto di San Carlo. Il colloquio è autorizzato alla presenza del coadiutore del delegato di S. Croce.
Poi Giacomino torna a Tredozio e don Pietro si incontra con l’avvocato Ildefolso Giusti per imbastire una linea difensiva contro quel muro di silenzio che l’autorità costituita gli frappone.
Decide quindi di inviare al prefetto una memoria con la sua versione dei fatti e si dice sicuro di essere amato e ben voluto dalla maggior parte del Paese, anzi esclusi questi pochi mestatori di male, da tutti del paese. E conclude nella speranza che gli verrà fatta ragione il più presto possibile.
6. L’istruttoria romagnola e la condanna
Intanto anche in Romagna viene avviata un’indagine amministrativa da parte della sottoprefettura di Rocca. Le audizioni iniziano il 27 marzo e si concludono l’11/5/1858 e sono sentite 126 persone. I testimoni espongono il loro pensiero, tutto basato sulla pubblica voce, che si divide in tre categorie:
i partitanti che lo assolvono da ogni peccato o comunque lo giustificano; gli equidistanti che si barcamenano nel dire e nel non dire per questioni di quieto vivere;
gli accusatori, la maggioranza, che sono soddisfatti del suo arresto, ma che non si sbilanciano più di tanto per il timore di un suo ritorno in paese. Ma l’inchiesta stenta a decollare; dalla capitale partono pressanti sollecitazioni e, per accelerare i tempi, mandano da Firenze un giovane praticante copista per svolgere il servizio alla compitazione di questa procedura. Il sottoprefetto giustifica il ritardo con la necessità di muoversi con cautela per non allarmare i soggetti interessati e la famiglia Valgimigli è a conoscenza delle indagini e non lascia intentati mezzi onde espiarne le mosse nella veduta poi di paralizzarne gli effetti. Gli addebiti contestati a don Pietro sono:
- di cooperazione alla strage della famiglia Lombardi avvenuta per opera della banda Lisagna nella notte dal 5 al 6 aprile 1851;
- di favoreggiamento e ricettazione della suddetta banda nella propria canonica di San Valentino;
- di avere ucciso nel luglio 1853 Angiolo Lama detto Lisagna, Antonio Ravaglioli detto il Calabrese e d’aver poco dopo fatto uccidere dalla Forza a San Valentino Giuseppe Zannelli detto Cesarino allo scopo d’im- possessarsi dei loro averi;
- di avere dopo la detta uccisione, continuato a tenere relazione coi malviventi superstiti, in particolar modo con Giuseppe Afflitti detto Lazzarino;
- di avere tentato di organizzare una nuova banda di malfattori;
- di avere messa incinta la giovane Giuditta Villa di Tredozio, sua serva e tentato di farla abortire a Firenze;
- di avere infine tenuto una condotta biasimevole sotto tutti i rapporti ed in specie in quelli della moralità.
Il 2/6:1858 il Consiglio di Prefettura, conclusa l’inchiesta, condanna il sacerdote don Pietro Valgimigli parroco di San Valentino in Romagna alla reclusione per anni tre nello Stabilimento Correzionale per traviata condotta. Il 9 giugno è trasferito alla cella n. 36 nel reparto ove si trovano i condannati in espiazione e si trova al piano terreno, vicino all’infermeria. Una parte del carcere demolita nella ristrutturazione dell’edificio che ha conservato solo una porzione storica a memoria dell’antica prigione.
7. Il carcere
Il segreto dell’istruttoria e la pesante condanna inflittagli convincono don Stiflón dell’assoluta inutilità di avvalersi di un qualunque appello o ricorso che gli avesse accordato la legge sia in via di giustizia, sia in via di grazia. Cerca altre vie per uscire da quella situazione e quando conosce un altro detenuto, un certo Giulio Lijbert che ha un fratello, Pietro, cantante nel Teatro Ferdinando, gli dà più volte dei denari nella speranza che possa aiutarlo tramite il collegamento con un frate cappuccino all’esterno, ma scopertolo falso e impostore cessa di finanziarlo. Anche questo tentativo fallisce e alla fine si convince che è meglio rassegnarsi alla tristissima sorte ed espiare la pena inflittagli. Il 1859 è un anno di grandi eventi per la Toscana, il 27 aprile il granduca Leopoldo II se ne va per sempre da Firenze, grandi manifestazioni popolari per le strade e alle fortezze sono esposti vessilli tricolori. L’entusiasmo è generale, alle Murate si preparano bandiere, banderuole e coccarde e i detenuti sperano in un provvedimento di clemenza. La seconda guerra d’indipendenza prosegue vittoriosa. Bettino Ricasoli è nominato presidente e ministro dell’Interno del governo provvisorio toscano e il 6 settembre concede l’amnistia. Ma il provvedimento non riguarda il Valgimigli che resta in carcere.
Nel luglio 1860 don Pietro presenta una supplica al Ricasoli che, lo ricordiamo, ha sposato Anna Bonaccorsi Dolcini di Tredozio e quindi è sensibile alle istanze di quelli che non lo vogliono più in Romagna. Chiede di commutare la pena residua in esilio dalla Toscana per il tempo e alle condizioni fissate dal governo. Ammette la colpa, ma trova il castigo eccessivo. Contesta l’irregolarità della procedura con cui è stato condannato e i cinque mesi di carcere preventivo non computati nel calcolo della pena, quasi li avesse passati in villeggiatura, ironizza. La supplica si arena sul tavolo del barone di ferro. Il 6 ottobre insiste chiedendo al governatore che, qualora non voglia condonargli tutta la pena, computi almeno il carcere preventivo, ritenendo la pretesa di farlo partire dal giorno della sua condanna, esorbitante ed assurda e chiede inoltre, come atto di grazia per la lunga prigionia sofferta, di ordinare a di lui favore la piena remissione e condonazione di ogni pena ulteriore. Il barone sollecita i funzionari governativi di valutare se la memoria suddetta sia meritevole di attenzione. Il direttore delle Murate conferma che è corretto conteggiare il periodo intercorso dall’arresto alla condanna nel computo complessivo della pena. Il delegato di Modigliana constata con sorpresa che il fascicolo relativo al suo procedimento economico è praticamente vuoto e anche nell’archivio di Rocca non esistono elementi per valutare la richiesta, in quanto gli atti della procedura economica contro Valgimigli trasmessi a Firenze non sono stati restituiti. Emerge chiaro, quindi, che tutta la documentazione relativa a quell’affare è stata avocata dal governo centrale ... la ragion di Stato ha prevalso su tutti gli altri interessi e don Pietro, che pure per un certo periodo è riuscito a volgerla a proprio favore, se la ritrova ora contro in tutta la sua potenza burocratica. L’affare non si risolve e rimane pendente nell’attesa della superiore risoluzione che non arriverà mai. Don Pietro espia tutta la condanna ed esce il 1/6/1861 dopo aver scontato quarantun mesi di prigionia, compresi i cinque di carcere preventivo.
8. “Un sogno alle Murate”
Nei lunghi giorni trascorsi in carcere don Pietro si è ormai rassegnato a scontare tutta la pena. Ma vivere nell’angustia di una cella dove non si possono fare cinque passi senza intoppare nell’uscio o nel muro lo fa sentire come un uccello a cui hanno tarpato le ali. Lui è una persona colta e di gradevole penna; scrivere gli riesce piuttosto bene, anzi, gli piace proprio. Perché non mettere a frutto questo suo talento per non morire d’inedia? Perché non scrivere un libello in cui attacca i suoi accusatori e denuncia tutte le loro nefandezze? Ricorda bene lo scalpore suscitato da quello affisso a Modigliana dopo lo scontro di Spignano e il tradimento di Sacramento. Pian piano matura dentro di lui un desiderio di vendetta. Ottenuto il permesso, inizia a fermare sulla carta le sue impressioni e predispone il canovaccio dell’opera: sono già oltre quaranta capitoli, ognuno col proprio titolo e ce ne saranno sicuramente altri da aggiungere. Quando il 1/7/1861 riassapora la libertà ed esce dal portone delle Murate ha in mano una valigia con poche cose; tra queste un grosso fascicolo di oltre duecentocinquanta pagine con tutti i suoi appunti. Non è facile reinserirsi nella vita civile dopo un lungo periodo di carcere. Conscio della sua situazione, si rivolge agli amici che lo hanno sostenuto in quegli anni difficili e che, fortunatamente, non mancano di aprirgli la porta; tra questi don C.B. che gli chiede di poter leggere il manoscritto. L’opera ha la forma del romanzo, colla sola differenza che i fatti esposti non sono invenzioni di fantasia, ma sono tutte cose vere e realmente accadute e che vuole raccontare solo la verità dei fatti. Un sacerdote arrestato in chiesa, poco men che con l’ostia consacrata in mano, incatenato e guardato come un infame assassino, scrive don Pietro e senza alcun riguardo tradotto in carcere, non già perché reo di qualche delitto, ma per semplice misura di polizia; un accusato al quale si diniega e impedisce ogni possibile difesa e si condanna col deposto apertamente falso e calunnioso di pochi scellerati suoi giurati nemici, già noti al governo per uomini che non ebbero mai né fede né religione, sono fatti che di per sé, anche nudi e semplici, commuovono a dispetto e a sdegno chiunque li conosce. Don C.B. gli propone di completare l’opera e darla alle stampe. Alla fine don Pietro accetta e il libro viene edito nel 1861 dalla Tipografia Torelli di Firenze, col chilometrico titolo: Un sogno. Descrizione tolta da un’opera inedita intitolata “Le Murate di Firenze” ossia “La casa della depravazione e della mor- te”. Memorie apologetiche.
Il volumetto contiene solo una parte del lavoro complessivo articolato in 74 capitoli, dove don Pietro parla del suo arresto, della condanna e della dura vita in carcere fino agli ultimi giorni di pri- gionia e si paragona a Silvio Pellico, il patriota che narrò la sua reclusione nel libro Le mie prigioni. Il sogno comprende i capitoli dal XXIV al XXXI che illustrano le vedute in cui esso è articolato. Il sogno narra di un incendio scoppiato nel carcere delle Murate dal quale il protagonista è salvato da un’aquila grandissima tutta bianca come neve dal cui petto spiccavasi bianco e snello un corpo umano, cui soprastava la bella faccia d’angelica donna» (Anna Monti?) che, in un viaggio fantastico, lo trasporta in Transilvania, oltre i monti Carpazi. Qui lo accoglie un venerando vecchio, il buon Genio che lo introduce nel Palazzo della Verità. Visitando il bel maniero incontra dei personaggi che portano impressi in fronte i nomi identificativi: l’empio, il ladro, il fanciullone, l’ince- stuoso, l’ipocrita, il mestatore, il cacaciano, l’avaro, il materialone, il calunniatore e lo spergiuro, in cui si possono riconoscere i «signori» di Tredozio. Ma, conclude don Pietro: se qualcuno si vedesse tratteggiato in questo sogno così bene al naturale o che avesse inteso parlare di quei tali, di quelle tali S’ingannerebbe a partito!perché tutto è frutto solo dalla sua matta immaginazione e nulla più. Giustificazione posta a paravento o ulteriore presa in giro di don Stiflón, ben consapevole di ciò che ha scritto? Nel novembre dello stesso anno, don Natale Graziani, parroco di Ottignana e maestro della scuola comunale di Tredozio, scrive al suo cugino don Giovanni Verità, in quel periodo cappellano militare a Chieti, dei recenti fatti avvenuti a Tredozio: il mese scorso, dice, qualcuno ha lanciato al di là dei muri di cinta, nei cortili di alcuni palazzi di Tredozio, un libello dal titolo Un sogno alle Murate.
Un racconto, come ben riassume Bonfante, che parla di una serie di personaggi misteriosi; misteriosi solo formalmente, giacché, con abile penna, non solo sono stati descritti, d’ognuno di essi, i difetti più abietti, ma sono anche state, di loro, indicate caratteristiche tali da consentire ai tredoziesi la possibilità d’individuare la vera identità dei personaggi descritti e cioè una serie di persone notabili di Tredozio. Questi ultimi, hanno distrutto i libretti piovuti dal cielo nei loro cortili; ma qualcuno ha ugualmente avuto modo di leggere il libello e forse lo possiede ancora; sicché, dopo qualche tempo, la notizia di quel ch’è stato scritto si è diffusa ed è sopravvenuto in paese un grave scandalo. Anche la polizia si è mossa, perché sembra non sia estraneo ai fatti qualche funzionario di Rocca e, addirittura, sia coinvolto anche uno dei signori di Tredozio, destinatari del libretto, che pare abbia tenuto mano ai due banditi uccisi a San Valentino otto anni prima. Non esiste alcun dubbio, conclude don Natale, che quel ch’è successo costituisce la vendetta dell’ex arciprete di San Valentino condannato a tre anni di carcere a seguito delle loro testimonianze. Don Giovanni Verità, canonico della Collegiata di S. Stefano in Modigliana per diritto di famiglia, va collocato in quella categoria di preti liberali e liberaleggianti considerati dai superiori non forti in teologia che seppe distinguere nella chiesa l’aspetto dogmatico da quello storico e contingente, obbedendo al primo, dissentendo attivamente dal secondo. (24)
—-
(24) Comune di Modigliana, Centenario della morte di don Giovanni Verità salvatore di Garibaldi, Faenza, Unione Tip. Artigiana Faenza, 1985, pp. 15, 16.
Ed è con questo spirito di adesione ai moti risorgimentali che nel 1849 contribuisce al salvataggio di Giuseppe Garibaldi nella trafila romagnola. Don Giovanni conosce bene don Pietro Valgimigli, suo compaesano e collega e risponde a don Natale che non è affatto sorpreso di quello che il famoso prete ha combinato: uno scellerato da par suo non può che far opere che lo assomiglino; vedendosi osservato da tutti si sforza di rendere osservanti gli altri; la consolazione dei dannati, come volgarmente si dice, però continua, non per questo devi essere persuaso che io abbia buonissima opinione di alcuni individui, da quel tristo soggetto accusati ingiustamente, o non accusati; abbastanza conosco alcuni polli: ma guardo e passo. (25)
—-
(25) V. Becattini, Don Giovanni Verità. Prete Cattolico. Patriota Garibaldino, Faenza, Tip. Faentina, 1984, pp. 52, 53.
È, questa, la parte dell’opera scritta dal Valgimigli che ci è pervenuta commenta Bonfante nella sua appassionata e puntuale ricerca storica e che ci svela gli occulti accadimenti, scandalosi e perversi, che segretamente animavano la vita, in quello che appariva un tranquillo paese dell’Appennino, di alcune famiglie, tenutarie del potere economico, politico e religioso di quella comunità.
9. La seconda vita di don Stiflón
Quando si avvicina la data della scarcerazione, il barone Ricasoli, all’epoca governatore delle Provincie Toscane, chiede al prefetto quali misure di pubblica sicurezza intenda adottare sul Valgimigli per garantirsi efficacemente da quei disturbi, che sono forse a temersi per la di lui presenza in località nelle quali è inviso e dove ben sarebbe a desiderarsi che non ritornasse. Interpellato se fosse disposto ad abbandonare lo Stato e ridursi all’Estero», don Pietro, risponde che è necessario almeno momentaneamente, per sistemare i di lui interessi fermarsi a S. Valentino. Però nel momento in cui fosse tornato in libertà, le misure per tutelare il Valgimigli e provvedere nel tempo stesso alla quiete pubblica non possono essere che quelle prescritte dal Regolamento di Polizia Amministrativa, quindi il controllo sulla sua persona sarebbe assai limitato. Per impedire il suo ritorno in Romagna si cerca di convincere un fratello a incontrarlo a Firenze per sistemare i suoi affari. Il prefetto propone questa soluzione, ma lui non intende por piede, neppure momentaneamente, nel Circondario della Rocca e specialmente a S. Valentino e a Tredozio, ma
non vuole impegnarsi in precedenza e nell’incertezza della sistemazione che si propone dare ai propri interessi, ad abbandonare il Regno e ripararsi all’Estero. In qualunque caso però gli occorrerebbe solo portarsi a Modigliana e, comunque, espiata la pena, non ci sono motivi validi per impedirgli dei movimenti. In effetti le osservazioni del prefetto sono giuste e, quando esce dal carcere, don Pietro va a trovare diversi suoi amici a cui ha promesso di fare visita. Parte alla volta di Faenza, prosegue per Ferrara e dopo qualche settimana, passando da Bologna, rientra a Firenze. Poi, con una soluzione probabilmente già concordata, si trasferisce nel piviere di Cascia, diocesi di Fiesole, a Reggello in Valdarno. Qui può mantenere tutti i suoi contatti fiorentini e romagnoli, ha il fratello farmacista nella vicina Pelago e la vicina strada regia con il servizio postale che gli consente di curare i propri interessi e vendicarsi con la pubblicazione e la distribuzione del suo libel- lo. Si inserisce bene nella vita della comunità locale e nel 1870, insieme ad altri sacerdoti, contribuisce con 5 lire per l’obolo in aiuto al Concilio Vaticano e a sostegno del dogma dell’infallibilità del Papa quando parla ex-cathedra in materia di fede e di morale. (26)
—-
(26) In Voti del clero italiano per la definizione dommatica dell’infallibilità pontificia con l’offerte de’ sacerdoti al S. Padre Pio IX in omaggio ed aiuto al Concilio Ecumenico Vaticano raccolte nel giugno del 1870, Vol. II, p. 181, Torino 1870, Pubbl. del giornale L’Unità cattolica.
Il Concilio fu poi interrotto a causa della presa di Porta Pia e dello scoppio della guerra franco-prussiana e poi ripreso, dopo quasi un secolo, nel 1962 col Concilio Vaticano II.
Nel 1872, volendo trasferirsi a Cortona, chiede al vescovo di Fiesole, da cui la parrocchia dipende, un’attestazione sulle sue qualità morali. E il vescovo certifica che il Molto Reverendo Sacerdote Pietro Valgimigli oriundo
della Diocesi di Modigliana, per il corso di circa otto anni che ha dimorato in questa nostra Diocesi Fiesolana, si è sempre diportato lodevolmente e conseguentemente non è stato mai sospeso né colpito da censure o irregolarità che si sappia, per cui avendoci esposto di volere prendere dimora nella Diocesi di Cortona, lo raccomandiamo all’Ordinario della Diocesi predetta. A Cortona costruisce un buon rapporto col vescovo Giovan Battista Laparelli-Pitti, l’unico a sapere del suo passato, che pensa a lui quando, nel 1877, deve provvedere alla cura delle anime di S. Lorenzo a Rinfrena, una parrocchia vicina alla città, dopo la rinuncia del titolare. In lui trova le qualità necessarie per bene disimpegnare l’Uffizio di vacanza e lo nomina economo spirituale della parrocchia vacante. Don Pietro svolge il suo incarico con diligenza e passione dal 27/11/1877 al 28/6/1884, quando rinuncia ufficialmente alla parrocchia. Intanto continua a corrispondere col canonico don Tommaso Pierazzoli, cancelliere della curia di Modigliana, uno dei suoi pochi riferimenti rimasti in terra natia anche nei momenti più difficili che lo tiene informato sugli avvenimenti romagnoli, e gli scrive: In tutta la mia travagliata vita non ho mai avuto un tempo di dolce soddisfazione, di placida tranquillità come quello che passo ora e se questo, come spero, sarà l’ultimo periodo della mia vita, io debbo ringraziarne, ne ringrazio di tutto cuore il Signore. Morta del tutto la passione della caccia, dei divertimenti, io posso senza lotta attendere al mio dovere e la sera quando vado al riposo m’addormento subito perché non sento alcuna inquietudine che possa agitarmi. Dio sia benedetto! Questa corrispondenza ha un brusco soprassalto quando lo Stato italiano gli sospende la pensione granducale. Il regio decreto del 5/12/1880 stabilisce che gli impegni dello Stato inerenti gli affari ecclesiastici e del culto passino all’Amministrazione del Fondo per il Culto e un’apposita commissione valuti le origini e le cause, sopprimendo tutti quegli impegni dello Stato che non avessero basi contrattuali e non riportassero derivazione legale e fossero puramente graziosi. Chi si sente leso nei suoi diritti può ricorrere in via amministrativa producendo i documenti giustificativi del suo credito. Don Pietro si rivolge a un avvocato di Arezzo, Pietro Maggi, che lo consiglia di rinunziare alle 30 lire mensili che riscuote per l’incarico di economo spirituale della parrocchia di S. Lorenzo a Rinfrena e che possono interferire negativamente nella riassegnazione della pensione. Così lascia ufficialmente l’incarico comunicandolo al vescovo che accetta le dimissioni e il 6 agosto nomina al suo posto don Giovanni Ciabattini con lo stesso stipendio mensile. In realtà è un giochetto concordato fra i due per ingannare lo Stato italiano, che così spiega a Pierazzoli: È un accordo fatto col vescovo. Io rinunziai, il vescovo accettò la rinunzia; fu nominato economo un parroco limitrofo, il quale figura in faccia al governo, riscuote dall’economo e passa a me l’assegno perché sono io che faccio come prima ogni cosa. Apre un contenzioso col nuovo Stato ed è determinato ad andare in fondo fino all’ultimo respiro, ma quando sta per dar fuoco alle munizioni, l’Amministrazione del Fondo per il Culto decide di soprassedere perché sarebbe stata una pessima pubblicità per lo Stato dovere ammettere pub- blicamente di continuare a pagare una pensione acquisita per meriti poco edificanti, con sua grande meraviglia che si siano ricreduti senza una sentenza e alle sole ragioni prodotte dall’interessato per sopra più prete». E il 17/5/1882 la ricevitoria dell’Intendenza di Finanza di Arezzo gli paga la pensione sull’unghia, arretrati compresi, assicurandolo che le future rate trimestrali saranno corrisposte puntualmente. Don Pietro è raggiante e desidera di ritornare in Romagna di cui sente una forte nostalgia. Ma dopo un commovente incontro col vescovo di Cortona che lo invita a restare, come lui spiega a don Pierazzoli: sono rimasto a S. Lorenzo ed è molto probabile che qui me ne stia fino all’ultimo momento della mia vita. Difficilmente addunque potremo rivederci in questa terra: se piacerà al Signore ci rivedremo nella vita eterna e sarà per noi una gran gioia: speriamolo e rimettiamoci alla Divina Provvidenza». Don Pietro, parroco rinunciatario della cura di San Lorenzo a Rinfrena, muore il 30/1/1885 a Cortona. Ha da poco compiuto 61 anni, pieno di acciacchi e di ripensamenti morali. È sepolto nel cimitero della Misericordia di quella città munito dei conforti religiosi, speriamo redento dalle sue malefatte.
10. Processo postumo
Il 29/4/2018 è stata realizzata una ricostruzione storica del Processo a don Pietro Valgimigli detto don Stiflón (1823-1885) prete della Romagna toscana nella bella sede di Palazzo Fantini a Tredozio grazie all’ospitalità degli attuali proprietari, con il patrocinio dell’Accademia degli Incamminati di Modigliana, del Comune di Tredozio, del Comitato della Romagna Toscana per la Promozione dei Valori Risorgimentali.
Lo scopo è stato quello di riaprire il caso di questo complesso ed enigmatico personaggio che all’epoca fu condannato sulla base di un procedimento indiziario in cui non ebbe la possibilità di difendersi perché già condannato dalla voce pubblica e poi esiliato per sempre dalla sua terra natale. Giusti o sbagliati che possano essere stati i motivi che portarono a queste conclusioni, questa revisione processuale postuma ha cercato di capire e valutare le molte accuse e le poche difese e dargli la possibilità di esporre anche il suo punto di vista per giungere alla fine di questo riesame con una sentenza emessa dal Collegio giudicante qui insediato e dal giudizio della giuria popolare presente in sala. Una ricostruzione storica, basata sui documenti raccolti nel libro Facinorosi pontifici, in cui sono stati coinvolti sindaci e volti noti di Forlì e provincia, che hanno partecipato con generosa disponibilità. (27)
—-
(27) Il collegio giudicante è formato dal presidente Luigi Cesare Bonfante giudice onorario presso il Tribunale di Ravenna e dai giudici a latere, gli avvocati Giancallisto Maz- zolini, Giancarlo Fontaine e Rosaria Tassinari, sindaca di Rocca San Casciano e da Simona Vietina, sindaca di Tredozio. Il pubblico ministero è Roberto Roccari, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena, mentre la difesa è rappresentata da Lorenzo Valgimigli, penalista; Iacopo Versari è il cancelliere. Al banco dei testimoni sfilano Pel- legrino Artusi, rappresentato da Giuseppe Mercatali, segretario dell’Accademia degli Incamminati; Giuseppe Vannucchi, sottoprefetto di Rocca, impersonato da Massimo Frassineti; Savino Savini, contadino a Senzano, è Luigi Pieraccini, già sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole e discendente di una vittima dei briganti; Andrea Leoni, speziale di Tredozio, interpretato da Claudio Samorì, già sindaco di Modigliana; monsignor Mario Melini, primo vescovo di Modigliana, recitato da Quinto Cappelli, storico e giornalista; Giuditta Villa, domestica di don Stiflón, è Maria Cristina Rossi, assessore del Comune di Modigliana; Anna Maria Monti in Ghetti, amante di don Stiflón è portata in scena da Maria Grazia Nannini; relatore è l’autore Pier Luigi Farolfi; lo spettacolo è aperto dai canti risorgimentali del Gruppo Cantastorie Modiglianese I Ciapa Cialdini.
La sentenza emessa dalla giuria togata lo ha condannato per avere messa incinta la giovane Giuditta e tentato di farla abortire a Firenze e per avere ucciso i briganti Lisagna, Calabrese e Cesarino.
Assolto per avere dopo la detta uccisione, continuato a tenere relazione coi malviventi superstiti, in particolar modo con Lazzarino; di avere tentato di organizzare una nuova banda di malfattori; di avere tenuto una con- dotta biasimevole sotto tutti i rapporti ed in specie in quelli della moralità.
Assolto, infine, per insufficienza di prove dalle accuse di cooperazione alla strage della famiglia Lombardi e di favoreggiamento e ricettazione della suddetta banda nella propria canonica di San Valentino.
Sentenza della giuria popolare:
- Colpevole: voti 64
- Innocente: voti: 46
A questo punto, anche alla luce dei nuovi contributi portati dal ritrovamento del Sogno alle Murate e dall’integrazione dei nuovi documenti prodotti da Bonfante, forse sarebbe opportuno dare a don Stiflón una ulteriore possibilità di difesa con l’indizione di un processo di appello che valuti e si esprima definitivamente su questi fatti.
Tredozio
Don Stiflón, prete brigante e lussurioso
Storia di sangue, sesso e soldi nella Romagna granducale dei Lorena
Questo articolo nasce dall’esigenza di fare il punto sulla ricerca storica, (1) dove si narra la vita del prete romagnolo don Pietro Valgimigli detto don Stiflón, don Stiffelone nei rapporti di polizia, ricostruita in lunghe ricerche negli archivi toscani e romagnoli.
—-
(1) P. l. Farolfi, Facinorosi pontifici. Storia di briganti e manutengoli (per tacer del prete) fra Legazioni e Granducato di Toscana, s. l., Il mio libro, 2015.
—-
Nel frattempo Luigi Cesare Bonfante, giudice e appassionato storico di grande spessore e competenza, ha pubblicato il libro: Tredozio nell’Ottocento. “Un sogno alle Murate” (2018), (2) risultato di una sua personale ricerca parallela su un pamphlet scritto dal prete durante la prigionia nel carcere fiorentino.
—-
(2) l. C. Bonfante, Tredozio nell’Ottocento. “Un sogno alle Murate”, s. l., stampato in pro- prio, 2018. Un libretto che Bonfante ha ritrovato rovistando nel solaio di casa, giunto fino a lui attraverso incredibili passaggi di mano tra i suoi avi. Si pensava che questa fosse rimasta l’unica copia e tutte le altre distrutte per non lasciare traccia di panni sporchi esibiti in pubblico. In realtà, un esemplare risulta depositato presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, ma destinato all’oblio se non ci fosse stato qualcuno, profondo conoscitore della storia, della società e del territorio a cui si riferiva, capace di leggere e interpretarne i contenuti con le giuste chiavi di lettura. Forse don Stiflón, temendo proprio un insabbiamento della sua vendetta, aveva provveduto a distribuirlo ad altre persone amiche.
—-
1. Don Stiflón e il suo tempo
Don Pietro Valgimigli nasce il 14/10/1823 a Modigliana da Cammillo e Domenica Baroggi, settimo di dieci figli, ed è battezzato in cattedrale. Frequenta le scuole dei Padri Scolopi distinguendosi fra gli allievi più meritevoli: nel 1838 è premiato in Rettorica per un lavoro su Pindaro, poeta lirico greco, insieme a Silvestro Lega, il noto pittore macchiaiolo, che, invece, si distingue in Storia greca e Poesia.
Ordinato sacerdote il 6/6/1846, va ad aiutare lo zio parroco a Senzano. Il 26/3/1847 muore il vecchio arciprete di San Valentino don Andrea Signani e la parrocchia vacante è messa a concorso. Vince don Pietro che il 27/6/1847, quinta domenica dopo pentecoste, prende possesso della Chiesa Arcipretale di San Valentino secondo i modi prescritti e nelle debite forme.
Che tipo è don Pietro? Nella nostra ricerca abbiamo visto molti identikit di briganti e manutengoli; purtroppo, nei tanti faldoni consultati, non abbiamo trovato suoi ritratti né descrizioni da parte di funzionari di norma piuttosto prolissi nel raffigurare chi avevano davanti. Comunque, le poche informazioni raccolte possono essere sufficienti a darcene un’idea sommaria, ma rappresentativa.
Un giovane di bell’aspetto, dal volto raso e dai lineamenti non rozzi, dice l’Artusi, (3) soprannominato don Stiflón per la sua figura alta e slanciata e con una gamba più veloce della lepre.
—-
3 P. Artusi, Autobiografia, Bra, Arcigola Slow Food Editore, 1999, p. 43. Approfondiremo la sua figura nel paragrafo relativo all’invasione di Forlimpopoli da parte delle banda del Passatore.
In generale, più che descriverlo fisicamente, sono gli attributi caratteriali a rappresentarlo: tristo, scaltro, fiero, violento, risentito, vendicativo, imbroglione, immorale, scandaloso, bestemmiatore, eretico, magnetizzatore, pericoloso, feroce, sanguinario. Un prete di buona cultura e di forte personalità con un’attrazione fatale per il rischio, i denari e le donne concupite e sedotte dal suo focoso temperamento. Ma, come per tutti il fisico deperisce, a 58 anni non è più quello di un tempo e si lamenta di soffrire molti incommodi fra cui la debolezza degli occhi, la sordità più che mezzana, la fiacchezza dei ginocchi.
Suoi sodali sono:
- Stefano Pelloni del Boncellino, frazione di Bagnacavallo, detto il Passatore, [e Pasadór],
- Angiolo Lama detto Lisagna,
- il Gobbo [e Gòbb],
- Zappolone [Zaplón], colono di Forlì,
- Giuseppe Afflitti detto Lazzarino [Lazarèn o Lazzerino, alla toscana],
- Caprino [Cavrèna],
- Fido,
- Camminazzo [Caminàz], contadino di Cantalupo,
- Governatorato d’Imola, che si dichiara bandito per causa politica per aver partecipato alla difesa della Repubblica Romana.
Briganti classificati come facinorosi pontifici dal Governo Granducale che li contrasta nei loro sconfinamenti per sfuggire all’inseguimento delle truppe austro-pontificie, protetti dalla loro rete di fiancheggiatori e manutengoli. La sua passione per le donne va di pari passo con la connivenza coi briganti di cui, in realtà, è l’eminenza grigia che progetta, organizza e a volte partecipa alle grassazioni, ai furti e agli omicidi. Da qui, da San Valentino, partono i colpi nelle Legazioni pontificie, il più eclatante dei quali è l’invasione di Forlimpopoli nel 1851. Le critiche mosse dai governi e dall’opinione pubblica internazionale per questo grave fatto al governo pontificio e per la sua incapacità di debellare il brigantaggio portano a un potenziamento delle misure militari con l’arrivo del capitano Michele Zambelli che si è già distinto nella lotta al brigantaggio. L’aumento delle taglie e la riconferma del Giudizio Statario che prevede l’immediata fucilazione di tutti quelli colti in flagranza di reato, porta subito a un importante risultato: il 23/3/1851, a seguito di una soffiata, i papalini uccidono il Passatore che si è nascosto nel paretaio del fondo Molesa presso Russi di proprietà degli Spadini, ricchi possidenti di Faenza ed esibiscono il macabro trofeo portandolo in giro su un barroccio per la Romagna.
La forte reazione delle truppe papaline e austriache porta a numerosi arresti ed esecuzioni capitali di briganti e manutengoli nelle Legazioni. Sono giorni in cui il Giudizio Statario funziona a pieno ritmo. È un periodo di forti agitazioni politiche. La vittoria degli austriaci sui piemontesi a Novara il 23/3/1849, l’abdicazione di Carlo Alberto, l’armistizio firmato da Vittorio Emanuele II il 26 marzo, producono i loro effetti anche in Toscana dove il triumvirato Guerrazzi, Montanelli e Mazzoni si dimette ed è restaurato il vecchio regime granducale.
Anche nella Romagna toscana il popolo manifesta, ad eccezione di pochi traviati amanti del disordine e delle tenebre, la massima gioia ed allegrezza. I comuni roma- gnoli si affrettano ad aderire al nuovo ordine, solo a S. Sofia e Modigliana c’è un poco di riottosità perché in quei paesi le affezioni per il governo monarchico non sono state mai troppo profonde. La confusione è grande: gli alberi della libertà abbattuti sono rialzati e le armi granducali, ripristinate nei palazzi governativi, sono vilipese. E il sottoprefetto si chiede sconsolato: Tutti i buoni e il contado fremono di simili vergogne, ma che fare senza Forza?. E la Forza arriva. Il 12 maggio, tre distaccamenti giungono a Modigliana, Marradi e Terra del Sole e il giorno dopo un altro a Rocca destinato a S. Sofia e Galeata. Il 25 maggio il generale Kostantin d’Aspre entra in Firenze alla testa delle truppe austriache e alla fine dell’estate il ripristino del vecchio assetto politico può dirsi completato. Ma tutto questo sommovimento politico e sociale porta miseria fra la popolazione e la recrudescenza del brigantaggio.
Il maresciallo Thurn, governatore militare e civile di Bologna, il 21/10/1849 denuncia la triste condizione delle Legazioni lamentando le recenti grassazioni, le invasioni, e gli attentati a danno della vita, e della proprietà di ogni persona commessi da bande armate che trovano sussidio dagli abitanti della campagna, in parte per corruzione, in parte per timore, essendo gli stessi privi della protezione del governo, e quindi in balia di tali malviventi. Le bande agiscono tranquille nell’inazione e depravazione delle autorità. La polizia è poco motivata perché pagata meschinamente e manca un adeguato fondo per i confidenti. La forza militare non basta a garantire la pubblica sicurezza: il corpo dei vèliti è demoralizzato e le truppe di linea scoraggiate. Una fotografia che vale anche per la Romagna toscana dove l’inasprimento della situazione sociale porta a un aumento dell’impegno del governo granducale e dell’esercito di occupazione austriaco che inviano a più riprese rinforzi nella provincia mettendo in difficoltà i briganti e i loro manutengoli con scontri a fuoco, rastrellamenti, retate, perquisizioni e arresti, a volte anche con azioni congiunte dei due Stati.
Si può calcolare che in quel periodo, fra esercito austriaco e granducale con cavalleggeri e soldati di linea, gendarmi e ausiliari, la presenza militare in Romagna toscana superi le 700 unità. Se a queste aggiungiamo le forze pontificie e austriache stanziate nelle Legazioni, che grazie ad accordi fra i due Stati possono sconfinare nei loro inseguimenti, il numero di armati impegnati nella repressione del brigantaggio oltrepassa le 1.000 unità. Uno sforzo davvero impressionante!
È in questo quadro generale che, per sfuggire all’accerchiamento delle truppe austro-pontificie, la banda del Passatore è costretta a ripiegare nel Granducato nascondendosi a San Valentino, una pieve posta in posizione dominante su uno sprone dell’Appennino tosco-romagnolo a cavallo fra i comuni di Tredozio e Modigliana. Un luogo che è sempre stato coinvolto in fenomeni di brigantaggio e di ribellismo: basti citare il brigante Giovanni Montanari detto Buriga in epoca napoleonica (4) e, più vicine a noi, le gesta del partigiano Silvio Corbari nella seconda guerra mondiale. (5)
—-
(4) Per approfondimenti vedi: D. Mengozzi, Sicurezza e criminalità, Milano, F. Angeli, 1999.
(5) Per approfondimenti vedi: E. Dalmonte, Corbari e la sua banda, Faenza, Ragazzini, 1984; P. Cacucci, Ribelli!, Milano, Feltrinelli, 2001; M. Novelli, Corbari, Iris, Casadei e gli altri, Torino, Graphot, 2002; C. GreMeNtieri, Iris Versari e la Resistenza delle donne, Castro- caro, Vespignani, 2004.
I contatti con don Pietro Valgimigli sono forse conseguenti a conoscenze di quando era in seminario a Faenza. La pieve di S. Valentino esercitava la sua giurisdizione spirituale su quattordici parrocchie; (6) le sue origini, secondo il Repetti, risalgono addirittura all’anno 562.
—-
(6) Questa pieve abbracciava 21 parrocchie attualmente ridotte a 14, fra le quali quella di S. Michele a Tredozio, per quanto sia stata eretta in battesimale. Tali sono:
1. S. Valentino, pieve arcipretura, cui è annesso il popolo di S. Carlo alle Casette;
2. S. Michele in Tredozio, pieve con l’annesso di S. Valeriano;
3. S. Benedetto in Alpe;
4. S. Maria in Carpine;
5. S. Eustachio in Cannetole;
6. S. Giuliano in Querciolano;
7. S. Maria in Castello con l’annesso di S. Michele in Vediano;
8. S. Biagio in Sarturano, cui è unito S. Martino in Scannello;
9. S. Giorgio in Rosata;
10. S. Lorenzo in Scarzana;
11 S. Maria in Ottignana con S. Maria in Tramonte;
12. S. Cesario in Cesata;
13. S. Martino in Collina;
14. S. Andrea in Pereta».
E. Repetti, Dizionario Geografico Fisico Storico della Toscana, 1841, vol. IV, pp. 238-239.
Era una cura molto appetita dai parroci dell’epoca per le sue ricche entrate che comprendevano la rendita di due poderi, alcune terre spezzate, le regalie dei capponi per il S. Natale, le ova, che sogliono corrispondersi dai coloni per le Feste Pasquali e gli incerti di stola bianca [battesimi e matrimoni] e nera [funerali]. Qui i briganti si sentono tranquilli perché è la loro casa fidata e passano il tempo a mangiare, bere, giocare e cacciare. Qui preparano i piani per qualche spedizione. Don Stiflón si premura di farli sentire a loro agio e fa girare questi assassini dappertutto e si è raccontato, conferma al sottoprefetto Bersotti don Giovanni Tignani, parroco della Berleta all’epoca dell’inchiesta su don Valgimigli, perfino che li abbia condotti al Teatro della Pergola a Firenze. A tavola si trattano bene e mangiano carne scelta che il garzone del prete, Giacomino Tronconi [Jacmèn], compra a Tredozio e a Modigliana. A Tredozio si serve da Niccola Poggiolini detto Gugliata [Guièda] che, siccome ammazza dei bei castrati manda il garzone a prendere parecchie libbre per volta e a Modigliana la ritira dal babbo che giustifica l’acquisto di tutto quel ben di Dio perché, dice: Il mio prete ci ha forestieri.
2. Una vita brigantesca
Invasione di Forlimpopoli
È il 25/1/1851, una sera triste d’aspetto, non punto fredda, caliginosa e piovosa. Le porte della città sono chiuse e le strade deserte. Al teatro comunale una compagnia di commedianti girovaghi rappresenta per l’ultima volta “La morte di Sisara”, tragedia biblica babilonese in cinque atti, con musica negli intervalli. Terminato il primo atto, i briganti irrompono sul palco e in platea disarmando i gendarmi presenti e minacciando di uccidere chi non avesse obbedito. Poi si distribuiscono per le strade saccheggiando le case dei maggiorenti della città. Violano anche l’abitazione di Pellegrino Artusi entrando con l’inganno, depredando e malmenando le persone che sono in casa. Pellegrino riconosce don Stiflón: Poi [il saccheggio continuò] giù in bottega e qui mi apparve una figura sinistra che, piantata in mezzo alla stanza col fucile ad armacollo, mostrava di comandare e far le veci del Passatore che in casa nostra non venne. Mi è rimasta sempre presente quella faccia crudele, dal cuore di tigre, che da me supplicato che cercasse di moderare i compagni a non commettere turpitudini, stava silenzioso e duro come un macigno. Dai connotati, dal volto raso, dai lineamenti non rozzi e da tutto insieme, costui non poteva essere altri che l’infame prete Valgimigli e non m’inganno di certo, sapendosi che qualche volta partecipava alle imprese. (7)
—-
(7) P. Artusi, Autobiografia, cit., p. 43.
Prima di andarsene i banditi dedicano la loro attenzione alle sorelle. Due riescono a nascondersi, ma Geltrude che è bella e di lineamenti delicati e gentili, dopo una lotta disperata con alcuni di costoro, manomessa e contaminata, fugge da un abbaino che porta sui tetti, colà vagando spaurita da un tetto all’altro. La povera Geltrude non si riprende più da questo trauma e il suo stato mentale peggiora nel tempo, fin quando viene rinchiusa nel manicomio di Pesaro dove muore dopo dodici anni di reclusione.
L’Artusi non sa darsi pace dell’accaduto e si trasferisce a Firenze dove apre un banco della seta in via Calzaioli, invitando i mercanti romagnoli a servirsi da lui. Caso vuole che la prima persona che si presenta con una partita di seta sia un fratello di don Valgimigli raccomandatogli dall’onesto negoziante Luigi Massa di Faenza che, al pari degli altri, era ignaro che quella famiglia avesse relazione cogli assassini. Lui gli fa una buona accoglienza e lo invita a pranzo ove, fra gli altri argomenti, cade il discorso sul fatto di Forlimpopoli del quale egli, purtroppo è più informato di lui. E per tutta la vita si porterà dietro il triste ricordo di quella brutta serata e di quel losco individuo che partecipò alla ruberia e allo scempio dei suoi familiari.
In seguito, quando nel 1865 Firenze diventa capitale d’Italia, l’Artusi lascia casa e bottega in via Calzaioli e si trasferisce in piazza d’Azeglio 25 dove si ritira a vita privata dedicandosi ai suoi interessi culturali e gastronomici e pubblicando a proprie spese “La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene”. Un manuale continuamente migliorato e arricchito fino alla quattordicesima edizione con la collaborazione dei fedeli domestici Marietta Sabatini e Francesco Ruffilli. (8)
—-
(8) M. Alba, G. Frosini, Domestici scrittori, Sesto Fiorentino, Apice libri, 2019. Un interessantissimo libro che riporta la corrispondenza di Marietta Sabatini, Francesco Ruffilli e altri con Pellegrino Artusi.
Un libro in cui l’Artusi ha il merito di imporre la lingua patria che per lui altro non è che il volgare toscano che forma la bella e armoniosa lingua paesana che non può tollerare contaminazioni da parte di altri paesi. Quest’opera di selezione e filtrazione fu opportuna e meritoria. [...] Artusi troncò una tradizione bisecolare e iniziò (eccedendo com’è naturale, nell’esclusivismo puristico) un processo di recupero orientato verso la migliore tradizione italiana. Talvolta, per essere più persuasivo e popolare, usò persino improvvisare quartine per rendere più orecchiabile il nuovo linguaggio di italiano di cucina. [...] Tutte le strade erano buone pur di ottenere l’intento prefissato. All’inizio del manuale c’è una Spiegazione di voci che, essendo del volgare toscano, non tutti intenderebbero, uno stringatissimo glossarietto che però capovolge l’uso da tanto tempo invalso fra i trattatisti di cucina italiani di dare un elenco di termini francesi per facilitare la pratica culinaria. (9)
—-
(9) P. Artusi, La Scienza in cucina e l’Arte di mangiar bene, Introduzione e note di Piero Camporesi, Einaudi tascabili, Torino, 1970 pp. LXIV-LXVI.
Chiedo venia per questa digressione, ma dobbiamo essere grati all’Artusi per la modernizzazione della lingua italiana, al pari di Dante e del Manzoni.
Dopo questo colpo i briganti vorrebbero ripetere l’exploit nel teatro di Tredozio, ma don Stiflón si oppone perché dice che vuole bene al paese e lo ha sempre tenuto scelto e non se ne fa di nulla. In realtà non ha alcun interesse ad agitare le acque nei pressi della sua parrocchia. Discorso che ripete anche nel 1856 mentre è a pescare col suo amico Alessandro Pazzi, calzolaio di Tredozio, con cui si lamenta perché non tutti in Tredozio si erano ricreduti, ma seguitavano a stargli sostenuti, mentre tutte le volte che i briganti avevano mostrato l’intenzione di rubare nel paese lui li aveva respinti sempre indietro.
Strage al Casetto di San Carlo e alla Masera
Giuseppe Lombardi è contadino al Casetto di San Carlo con la moglie Maria e due figli, Luigi e Domenica, sposata con Domenico Bernabei detto Mengone che lavora alla giornata anche nel vicino podere della Masera. Il Lombardi, una vecchia conoscenza della polizia, denuncia al delegato di Modigliana la presenza dei briganti a casa sua. Vengono subito mandati i soldati, guidati da lui stesso, ma non riescono a rintracciare i facinorosi. La domenica seguente l’uomo si mette a raccontarlo nella piazza del paese mostrando a tutti i 5 paoli di ricompensa per la sua denuncia. Qualcuno lo avverte che non è prudente il ciarlar tanto e che per questo sgarbo lo avrebbero ammazzato. Impaurito, si fa accompagnare a casa dai gendarmi. Ma dopo la morte del Passatore, i briganti vedono nel suo tradimento una minaccia alla loro sicurezza e sono decisi a dare un esempio che sia di monito a tutti. La sentenza viene emessa la notte del 3/4/1851 al mulino dell’Avolano sul torrente Tramazzo condotto dai fratelli Senzani: Giuseppe detto il Matto [e Matt] e Andrea detto Dreino.
Circostanziate testimonianze attestano che è lo stesso don Stiflón a essere committente, giudice e partecipe all’impresa. La sera del sabato 5 aprile Lisagna e Spigone, (10) guidati dal Matto, muovono verso il Casetto di S. Carlo dove il mugnaio chiede di entrare col pretesto di ritirare la farina di formentone che aveva portato in quel giorno a macinare.
—-
(10) Bertoni Pietro detto Spiga, Spigone e Almanacco, di Granarolo.
Alla sua vista il Lombardi si fida e apre la porta. È così che i briganti riescono a entrare in casa spezzando le armi per impedire ogni tentativo di difesa.
Manca però Mengone; Lisagna appoggia la pistola sul viso di Domenica chiedendole dove sta suo marito. Dopo che la sventurata ragazza ha rivelato che si trova alla Masera, la uccide all’istante. A quel punto si scatena Spigone che, con un’accetta trovata in casa, massacra tutti gli altri. Non ci sono testimonianze dirette di quel macello; si possono solo riassumere gli esiti di questa raccapricciante pazzia omicida descritti nella perizia medico-legale. Sui cadaveri sono riscontrate ferite mortali sulla testa e in varie parti del corpo prodotte da una scure trovata sporca di sangue e sul corpo della povera Domenica una grossa ferita in faccia dovuta all’esplosione di un’arma da fuoco. Consumata la strage decidono che bisogna uccidere anche Mengone e ripartono per la Masera, accompagnati questa volta da Dreino. Giungono a mezzanotte. L’uscio è chiuso, ma il mugnaio lo apre facilmente conoscendo il trucco: basta infilare il dito in una fessura per alzare la nottola interna e Lisagna e Spigone entrano in casa gridando: Lume, lume c’è la Forza! e, trovato Mengone, gli dicono che hanno ammazzato i suoi e ora ammazzeranno anche lui perché altrimenti avrebbe parlato. Il giovane implora invano di non ucciderlo; Spigone gli spiana il fucile sul petto, tira, ma non brucia che il fulminante. Quelli della casa lo supplicano di salvargli la vita. Spigone manda Lisagna a sentire che deve fare. Ma da fuori don Stiflón risponde: Devono esser morti tutti. Versione confermata dal commesso di vigilanza di Modigliana e da altre persone. Allora Spigone fa inginocchiare Mengone in mezzo alla stanza e, mentre il poveretto grida misericordia e pietà, lo uccide con una fucilata nel petto e un’altra in un orecchio. Prima di andarsene avvertono i casanti di aspettare il giorno dopo per sporgere la denuncia al tribunale e di dire a tutti che sono stati Lisagna e Spigone a ucciderli.
Quando Guido Tassinari, il becchino di Tredozio, apprende la notizia, sale a San Valentino dove trova don Pietro a dire messa, che gli ordina di seppellirli lì perché sono della sua parrocchia e che intanto prepari una fossa per cinque, ma come fa a conoscere il numero degli infelici trucidati senza aver conferito con alcuno? si chiede il capocommesso di Rocca dandosi anche la risposta. Don Pietro annota il loro decesso nel registro dei morti della parrocchia aggiungendo che il capofamiglia è stato trucidato orribilmente da alcuni assassini appartenenti alla famosa banda del Passatore per aver denunziato alla Giustizia i medesimi contro il di loro espresso ordine. Tanti salgono da Tredozio e da Modigliana a vedere i morti ammazzati e la voce pubblica indica subito il mandante nel prete con la convinzione che assistesse personalmente ed eccitasse alla strage della intera famiglia Lombardi.
Rapina a Razzolo
La mattina del 15/8/1852 la banda si riunisce per fare una rapina. Il colpo è stato concertato da tempo, ma si è atteso il via libera dal Calabrese (11), Morischi (12) e Spigone, ospiti a San Valentino, informati da don Stiflón che quel sabato al mercato di Dicomano ci sarebbero stati i pagamenti più grossi che si facevano in Toscana.
—-
(11) Antonio Ravaioli detto il Calabrese e il Marcio, di Faenza.
(12) Giuseppe Morigi detto Morischi, di Forlì.
Le dritte si nascondono fra i derubati. Lazzarino, Ghigno, (13) Lisagna e il Calabrese arrivano per conto loro a Razzolo, un podere sulla strada regia sopra Bocconi.
—-
(13) Domenico Sabbatani, detto Ghigno, di Castel Bolognese.
È l’alba del Ferragosto quando i commercianti tornano da Dicomano sui loro barroccini. I briganti li aspettano nascosti nella macchia sotto il podere. Man mano che arrivano sono costretti a scendere, perquisiti e derubati di tutti i denari che hanno, chi in un sacchetto, chi in scartocci, chi in ventriere di pelle. L’ammontare del bottino è di 3.436 scudi, nella massima parte composti di napoleoni d’oro. Poi si allontanano con i loro barroccini, dicendo che li avrebbero ritrovati in cima al monte Busca. I soldi li portano a don Stiflón dopo tre o quattro sere il Marcio, Morigi e Lisagna restituisce alle dritte gli scudi rapinati più la loro parte di bottino. Ma il prete rimane scontento perché i briganti rifiutano di retribuirgli dugento scudi sul bottino conseguito e questo è uno dei motivi per cui poi li tradirà. I possidenti romagnoli si allarmano e il sottoprefetto chiede rinforzi perché i facinorosi fino ad allora sembrano aver rispettato il territorio granducale come quello di loro asilo, ma dopo il fatto di Razzolo quella speranza è sparita. E il governo invia una compagnia di linea a Rocca dove giunge il 25 agosto.
Lo scontro di Spignano, la croce negata e Sacramento
Lazzarino, Spigone, Morigi e Ghigno sono ospiti al podere di Spignano, popolo di Casale, poco distante dal confine. Una dritta di sperimentata sicurezza rivela il loro nascondiglio al delegato di Modigliana che concorda col governatore di Brisighella un’azione congiunta per sorprenderli. La sera del 18/20/1852 due colonne di fucilieri con i gendarmi papalini e granducali circondano la casa colonica e li attaccano di sorpresa. Nel violento scontro a fuoco rimangono uccisi un gendarme, Spigone e Morigi. Lazzarino riesce a fuggire con Ghigno, che morirà d’infezione poco dopo per le ferite riportate. I due briganti sono inumati nel cimitero di Modigliana con sepoltura religiosa, ma il parroco nega loro la croce. Questo provoca il risentimento di don Stiflón che decide di costruirla lui stesso e manda il Calabrese e Cesarino a piantarla sulla tomba. Fa accendere delle candele vicino alla croce e affiggere due fogli alle colonne del Parterre di Modigliana. Spiega che sono una satira le cui parole dicono:
Ai due figli di Cristo
La Croce negata
I compagni di merito
Da essi posero.
La mattina del 26 novembre sono trovate la croce, la satira e un torcetto spento.
Autore della soffiata è stato Antonio Laghi detto Sacramento, bracciante e manutengolo, che per il tradimento riceve una grossa somma con cui acquista una casetta nel Borgo Violano di Modigliana. Lazzarino, unico superstite dello scontro, decide che la spia deve morire e il 19 dicembre, lo cerca insieme al Calabrese per ucciderlo. È un pomeriggio di terrore per le strade di Modigliana finché i briganti raggiungono casa sua dove minacciano la moglie incinta e la figlia; fortunatamente Sacramento è fuori e quell’assenza gli salva la vita. Ma ormai è un uomo bruciato e deve trasferirsi con la famiglia a Firenze dove è sistemato come faticante al magazzino interno e al forno nella Pia Casa di Lavoro di Montedomini. Lì morirà con la moglie durante l’epidemia di colera del 1855. Questa storia è narrata con dovizia di particolari in un libello anonimo affisso a Modigliana i giorni seguenti e che tutti attribuiscono alla penna di don Stiflón per lo stile e la perfetta conoscenza dei fatti.
Viaggio a Pelago
È ancora buio la mattina del 20/5/1853, un venerdì, quando don Stiflón e il Calabrese, lasciano San Valentino per recarsi a Pelago, un paese nel Valdarno sopra Firenze, dove suo fratello Romano, esercita la professione di speziale. Il viaggio ha lo scopo di valutare la possibilità di organizzare un furto ai danni di un possidente del luogo. Prima di partire don Pietro si è impegnato con don Carlo Muini, parroco di Pereta, di celebrare una messa la domenica seguente che è Sant’Andrea, la festa del patrono, promettendogli di tornare in tempo a celebrarla.
Corre voce che già in passato don Stiflón abbia compiuto un furto a Pelago ai danni di un fattore fiorentino. Pare che i briganti siano entrati in casa chiudendo gli abitanti in una stanza e derubandoli di 4.000 scudi. Il fatto lo racconta don Giovanni Tignani, sempre ben informato. La storia l’ha saputa da Giovanni Malpezzi detto Bel Naso [Bel Nes], mercante di bestiame di Terra del Sole, solito frequentare la fiera di Pelago. Dopo quel furto ha visto don Pietro incrociare alla fiera il fattore derubato. Questi lo riconosce e cerca di radunare i suoi contadini per prenderlo, ma lui se ne accorge e scappa. Don Pietro parte accompagnato dal Calabrese; giunti alla locanda delle Balducce si fermano perché un cavallo si è sgambato e vogliono comprarne un altro dall’oste Zanetti per proseguire. In quel momento si ferma alla locanda il Poggiolini, Guièda, il loro macellaio di fiducia, diretto a Dicomano a comprare dei castrati. I due gli chiedono un passaggio e, una volta arrivati, si fanno prestare il barroccino con la promessa di riportarglielo il giorno dopo. Ma a Pelago la polizia locale è in allerta per via di alcune satire e va per le case a cercar dei forestieri.
Il loro arrivo non passa inosservato e il commesso di vigilanza di Pontassieve li segnala in compagnia di persone del luogo che li ospitano per mancanza di comodo dal farmaco Valgimigli, suo fratello. I due ci dormono sopra. La mattina dopo lasciano il paese ritenendo di aver raccolto le informazioni sufficienti a realizzare, in seguito, il colpo e si riuniscono al macellaio, riprendendo la via di casa.
Ma durante il ritorno una pioggia torrenziale rallenta il viaggio e sono costretti a sostare al Muraglione. Il tempo di mangiare un boccone, senza staccare neppure la cavalla e ripartono subito per via dell’impegno preso con don Muini.
Raggiungono le Balducce due ore innanzi giorno e finalmente don Pietro arriva a San Valentino, ma è stanco del viaggio e chiede al cappellano di sostituirlo. Don Ferdinando Fabbri giunge a Pereta sul tardi. Trova don Muini con gli altri parroci sorpresi di non vedere il titolare e si scusa dicendo che ha dovuto aspettare perché l’arciprete era fuori. Celebra l’ultima messa sotto gli occhi incuriositi degli altri sacerdoti e se ne riparte subito dopo il pranzo.
Il tradimento
Il viaggio a Pelago è un passo falso per don Pietro. La polizia sospetta che ricetti i briganti già al tempo della strage dei Lombardi, ma le perquisizioni fatte a S. Valentino non hanno portato ad alcun risultato. Quando il sottoprefetto sa da un fiduciario del suo viaggio a Pelago in compagnia del Calabrese, pensa di avere finalmente le prove che cerca. Verso la fine di giugno lo convoca dicendo di sapere che tiene i ladri in casa» e lo mette di fronte a una secca alternativa: O consegnarli o esser punito! Vistosi scoperto e ormai compromesso, lui promette di farglieli prendere e che se poteva gli avrebbe dati vivi alla forza, altrimenti avrebbe procurato di farli avere morti e, per salvare se stesso, decide di tradirli risolvendo la situazione con i fatti che si sarebbero svolti di lì a poco. Ci riflette sopra concludendo che ha il tornaconto a disfarsi di questa gente piuttosto che consegnarli vivi, giacché dandoli vivi potevano parlare denunciandolo come complice dei delitti che essi avevano commesso andando perfino con loro a rubare. Si sarebbe appropriato del forte deposito di denari che gli hanno dato in deposito e che lui tiene ben nascosto in chiesa, che potrebbe avere un salvacondotto per andare all’Estero e avrebbe riscosso anche le taglie del governo pontificio.
Uccisione di Lisagna, Calabrese e Cesarino
Don Pietro confida al garzone Giacomino gli accordi presi col Vannucchi: M’ha detto il Tribunale che o morti o vivi li dia nelle sue mani. Gli chiede di aiutarlo, ma tutti e due temono la loro reazione. Prenderli vivi è un affaraccio molto più che gli assassini sospettando di lui stanno in guardia. In quel periodo i briganti sono nella parrocchia di Pistoglio nei pressi di Marradi, ospiti di don Ferdinando Fabbri, che è anche cappellano a San Valentino dove sta parecchio tempo e mangia, beve e giuoca con loro ed è a parte di tutto.
Intanto cerca di creare l’occasione risolutiva e manda il garzone a chiamare il Calabrese e Lisagna con la scusa che vuole vederli. I due partono e giungono a San Valentino la sera del giorno dopo. Fa preparare una cena coi fiocchi mettendo tutto il giorno ai fornelli le serve Giuditta e Lucia [di cui diciamo più avanti]. Poi manda Giacomino a Modigliana dal fratello farmacista a prendere l’oppio per drogare il vino. E quando si siedono a tavola lo fa servire: Lisagna ne beve parecchio, il Calabrese l’assaggia appena. L’arciprete, che conosce la loro passione per la caccia, propone di andare la mattina dopo al capanno a tirare ai merli che gli beccano l’uva nella vigna. Il Calabrese accetta, però i due, non fidandosi, preferiscono dormire fuori e ricompaiono all’alba. È il 9/7/1853. Don Pietro prende le schioppe e s’avvia col Calabrese per il sentiero che porta alla vigna. Lisagna, sentendosi poco bene si butta vestito sul letto per riposare.
Arrivati al capanno, il prete butta in terra la borsetta dei pallini e chiede al Calabrese di raccattarla. Mentre quello si china, gli punta il fucile alla nuca e tira una fucilata carica a pallini e a palla ammazzandolo sul colpo. Poi trascina il corpo dentro il casotto, ripulisce alla meglio le tracce e torna di corsa alla canonica dove chiede a Giacomino se ha ammazzato l’altro. Quello risponde che non se l’è sentita, ma che sta sempre dormendo a letto. Allora lo butta da parte e tira a Lisagna una fucilata colpendolo in bocca e al garzone, dalla gran paura che ha, gli scatta il fucile anche a lui colpendolo in una coscia. Don Pietro trova addosso ai cadaveri molti napoleoni d’oro, monete d’argento e diversi anelli, poi fa cucire alle ragazze due sacchi di ghinea (14) per metterci dentro i cadaveri e li fa portare in cantina coperti con una stuoia.
—-
(14) La ghinea era un tessuto di cotone grezzo, grossolano e robusto, utilizzato per la produzione di biancheria, lenzuola e simili e perciò molto richiesto, così detto perché in origine veniva fabbricato per l’esportazione in Guinea.
Manda il ragazzo a chiamare il cappellano e fa caricare i cadaveri sulla sua cavalla per portarli alla tesa del monte della Chioda, vicino al podere delle Muricce. Durante il viaggio la cavalla procede lasciando dietro di sé una scia di sangue perché i sacchi sono stati cuciti radi e, strada facendo, il corpo di Lisagna cade; nel rimetterlo sulla bestia, Giacomino sente che nasconde delle monete intorno alla vita. Prende quei quattrini, circa una cinquantina di napoleoni e li dà all’arciprete chiedendo la sua parte. Ma quello se li intasca rispondendo che toccano tutti a lui perché ha fatto il ladro, l’assassino e il becchino e lo spedisce subito ad avvertire il sottoprefetto Vannucchi. La mattina del giorno dopo da Rocca parte una colonna di soldati che fanno caricare i due cadaveri su una treggia tirata da un paio di buoi fatta venire da un podere vicino. I morti sono esposti nella cappella mortuaria del cimitero di Rocca e in tanti vanno a vederli, ma per riconoscerli sono fatte venire delle persone apposta da Forli e Faenza.
Due giorni dopo manda a chiamare Lazzarino e Cesarino con la scusa di organizzare una rapina e avverte il sottoprefetto che invia una cinquantina di soldati che si appostano dentro la canonica. Lazzarino, in un primo momento è titubante, non si fida del prete, poi si lascia convincere da don Ferdinando che gli dice che se non ci vanno, il Calabrese e Lisagna avrebbero fatto il colpo senza di loro. I due arrivano a San Valentino verso mezzanotte. Appena però Cesarino mette la mano sull’uscio di casa, questo si apre all’improvviso e da dentro parte una scarica di fucileria che l’ammazza all’istante. Lazzarino capisce di essere caduto in un’imboscata e corre a nascondersi dentro un casottino. Qui getta la saccona fuori per ingannare i soldati che gli tirano contro una ventina di schioppettate e lui ne approfitta per scappare giù per il monte. Anche il cadavere di Cesarino è portato al cimitero di Rocca e anche per lui vengono delle persone da Forlì per riconoscerlo.
Per questo successo sono distribuiti premi in denaro ed encomi, ma don Pietro ne riceve solo metà, 50 zecchini, per il parziale fallimento dell’operazione. Chiede a Giacomino di dire che li ha uccisi lui e di prendersi la colpa, ma lui rifiuta. Allora lo minaccia che se fa la spia gli taglia il collo.
Rinuncia alla parrocchia di San Valentino e trasferimento a Tredozio
Dopo questi fatti don Stiflón riscuote i premi delle taglie e si appropria del bottino dei briganti. Da questo momento le sue condizioni economiche migliorano notevolmente e fa acquisti mettendo a frutto parte del capitale. Lazzarino giura di vendicarsi e cerca di recuperare la sua parte. L’arciprete si muove sempre col fucile perché teme la sua vendetta, supplica il granduca di allontanarlo dalla parrocchia e chiede un sussidio per provvedere alla propria sicurezza personale e per pagare un altro prete che lo sostituisca durante la sua assenza. Gli viene concessa provvisoriamente e riservatamente una sovvenzione di 400 lire. Ma il tempo passa, i due sono stanchi e si temono a vicenda. Per accomodare le cose mettono di mezzo un sensale, Filippo Zauli detto Filippone [Flipòn], raggiungendo alla fine un accordo. La transazione avviene sul monte Busca dove don Pietro sborsa la porzione dell’oro spettante a Lazzarino che, da parte sua promette che avrebbe fatto a monte di tutto. Filippone dice che i due si riappattumarono, perché l’uno aveva paura dell’altro e don Pietro smette di girare armato. Quando monsignor Mario Melini, arriva a Modigliana il pomeriggio del 4/5/1854, proveniente da Montalcino, per insediarsi nella nuova diocesi, il primo problema da affrontare è la gestione del caso Valgimigli che, risolta la pendenza con Lazzarino, non vuole più andarsene da San Valentino. Il 6 giugno il ministro degli Affari Ecclesiastici mons. Giovanni Bologna lo informa che ci sono gravi e urgenti ragioni per allontanarlo perché la sua presenza è uno scandalo da rimuovere e gli chiede di concertare ogni iniziativa col sottoprefetto Vannucchi per convincerlo a rinunciare alla parrocchia. Don Pietro accetta colla condizione che gli siano assegnati 100 scudi annui di pensione. Ma poi ci ripensa e cinque giorni dopo il padre Cammillo va in arcivescovado con ulteriori pretese: una persona di fiducia che valuti le migliorie apportate alla chiesa, alla canonica e ai poderi di San Valentino e una pensione non minore di lire 1.000 ogni anno per vivere dignitosamente fuori della parrocchia. Mons. Bologna dice che il parroco esagera e che dovrebbe accontentarsi della decorosa offerta, superiore alla sua attuale rendita. Ma, in una nota a parte, dà al vescovo carta bianca per ulteriori aumenti fino alle reclamate lire 1.000. Trascorsi alcuni giorni senza risposta, don Pietro interpreta il silenzio del vescovo come assenso alla sua permanenza a San Valentino e lo informa che avrebbe iniziato subito i lavori alla canonica per far fronte all’inverno. Ma, Eccellenza, il prete minaccia, il vescovo non teme! e monsignor Melini chiede che le sue richieste siano sollecitamente risolute pur di allontanarlo per sempre dalla parrocchia. E se da una parte manovra per avere la pensione, dall’altra don Pietro fa gli ultimi disperati tentativi per restare a San Valentino. E il 29 settembre Santi Chiarini e Giovanni Farolfi si presentano davanti al vicario foraneo di Tredozio, don Cesare Leoni, per sapere quali fossero i motivi per i quali il loro arciprete doveva partirsi per sempre dalla Chiesa, chiedendogli di farsi portavoce e scrivere una petizione al vescovo per informarlo che il popolo in massa, era dispiacente di tale rimozione. Loro avrebbero organizzato la raccolta delle firme fra i parrocchiani. I due sono partigiani di don Valgimigli benissimo cogniti dal Tribunale e veramente degni di colui, di cui patrocinano la causa. Don Cesare, intimorito, firma anche lui e la mattina del 2 ottobre si presenta all’arcivescovado alla testa di una delegazione di cinque persone di cui fanno parte anche il Chiarini e il Farolfi. Ma mons. Melini dice che hanno sbagliato strada perché non dipende da lui ciò che domandano essendo solo un esecutore degli ordini superiori. Lo stesso giorno spedisce la supplica a Firenze censurando il comportamento del vicario foraneo e chiedendo di porre fine, una volta per tutte, a tali vergognosi maneggi e così togliere al Real Governo ed al Vescovo ulteriori inquietezze.
Una settimana dopo è presentata direttamente al granduca una nuova istanza a firma di Santi Chiarini, anche questa volta preparata da don Valgimigli, in cui si chiede di non rimuoverlo perché: Esso adempie esattamente ai suoi doveri come parroco; assiste volonteroso agli infermi e come medico e come infermiere; aiuta e soccorre i poveri, gl’indigenti, si presta sollecito ad ogni bisogno, ad ogni urgenza, si fattamente soddisfa tutti, che tutti niuno escluso hanno posto la loro firma nella istanza a mons. vescovo diretta e sono pronti tutti a dichiarare quanto affermano ovunque e quando ne siano richiesti, ma la manovra non riesce.
Don Pietro si convince allora di proseguire sulla strada della rinuncia e chiede e ottiene una nuova valutazione dello stato economico della parrocchia a lui più vantaggiosa.
Il 14 agosto mons. Bologna trasmette al prefetto di Firenze, da cui dipende la sottoprefettura di Rocca, il decreto granducale che, preso atto delle eccezionali circostanze, assegna al Valgimigli un’annua pensione personale di lire 1.000 in tutto conforme alle non discrete esigenze del nostro reverendo, perché al nemico che fugge devonsi fare ponti d’oro, informandolo che si è dovuto camminare a vapore sull’affare Valgimigli e si è dovuto fare a modo di quel tristissimo soggetto impedendo l’osservanza del consueto procedimento ufficiale. La pensione comincerà ad avere effetto col primo dell’anno imminente 1855, pagabili in due rate semestrali, a giugno e a dicembre di ogni anno e il 12/1/1855 viene emesso il relativo decreto granducale munito di R. Exequatur.
Il 30 dicembre don Pietro rinuncia liberamente e spontaneamente alla parrocchia e si stabilisce a Tredozio, dove però nessuno gli fa buon viso e la gente lo teme e lo evita. Di ciarle se ne fanno tante nel chiuso delle mura domestiche, ma poi fuori, in piazza, tutto tacciono per paura di ritorsioni.
Ma è l’epidemia del colera esplosa nell’estate del 1855 a risollevarne le sorti e don Stiflón per avere il popolaccio dalla sua parte e per farsi benvolere si butta allo sbaraglio al Lazzaretto, così allora qualcuno comincia ad avvicinarlo. Il consiglio comunale gliene affida la direzione ringraziandolo poi con una delibera piena di encomi per essersi prestato all’assistenza gratuita degli infermi, non solo spirituale, ma anche sanitaria. Intanto, mentre il vescovo assegna a don Cesare Leoni l’arcipretura della parrocchia di San Valentino, don Pietro ottiene l’uffiziatura dell’ultima messa nelle feste nella chiesa di San Michele a Tredozio col permesso del parroco e del gonfaloniere. Così, da quel momento in poi, tutti si mostrarono meno sdegnati è il commento del barrocciaio Luigi Poggiolini detto Ciula e Bulone [Bulòn], suo vicino di casa.
Il tesoro di don Stiflón
Possiamo fare un conto della sua disponibilità finanziaria a seguito degli introiti delle rapine e ricompense avute con il tradimento e l’uccisione dei briganti. Dopo aver ammazzato Lisagna e il Calabrese, don Pietro si appropria di quanto hanno indosso: un centinaio di napoleoni d’oro, altrettanti d’argento, diversi anelli e una bella schioppa. Due giorni dopo, a seguito dell’uccisione del brigante Cesarino, viene ricompensato dal sottoprefetto di Rocca con 50 zecchini, la metà di quelli pattuiti perché Lazzarino riesce a fuggire. In questa occasione si appropria del bottino dei briganti. Si parla di 20.000 scudi con cui il prete compra diverse case e un podere, mentre una parte li dà a frutto a un signore di Forlì. In più riceve una sovvenzione di 400 lire per provvedere alla propria sicurezza personale. In seguito fa la pace con Lazzarino e gli ridà la porzione dell’oro a lui spettante. Ai primi del 1855 lascia la parrocchia di San Valentino e si trasferisce a Tredozio: gli viene assegnata una pensione di 1.000 lire ... per la di lui vita naturale. Quando il nuovo Stato italiano gli sospende la pensione granducale in quanto non ha derivazione legale ed è puramente graziosa», lui fa ricorso all’Amministrazione del Fondo per il Culto. Alla fine la spunta e la pensione gli viene ripagata, arretrati compresi.
3. Una vita lussuriosa
L’11/1/1857 Lazzarino viene catturato all’Alpicella, nell’Alpe del Corniolo sopra Santa Sofia, concludendo così la sua carriera di brigante con la fucilazione a Bologna all’alba dell’8 maggio sul terrapieno delle mura fra Porta S. Felice e quella di S. Isaia. In quello stesso momento don Stiflón fa una vita da gran signore ed è all’apice della sua carriera di puttaniere. È proprio nei giorni freddi e nevosi di quell’inverno che i gendarmi granducali lo sorprendono nottetempo sul ponte di Tredozio, mentre esce da casa sua nascondendo sotto il ferraiolo (15) la giovane Veronica Tassinari figlia del becchino del paese, cucitrice di bianco e lavandaia e moglie di Luigi Poggiolini.
—-
(15) Ampio mantello di seta o di altra stoffa leggera di colore rosso, violaceo o nero, a seconda del grado di chi lo porta (cardinale, vescovo o sacerdote) annodato al collo con strisce dello stesso colore. Per estensione, in passato, mantello da uomo in genere, di solito senza maniche, con o senza bavero.
La polizia sa che questa donna è anche la mezzana nella tresca tra il Valgimigli e la Ghetti, un’altra sposa con cui il sacerdote sfoga le proprie brutali passioni, ma le due non sono che pedine di un gioco più grande creato da don Stiflón. Un rapporto riservatissimo, lo descrive: Capace di ogni delitto, spregiatore delle cose più sacre, dedito soltanto allo sfogo delle più brutali passioni, ha posto lo scompiglio in varie famiglie coltivando illecite tresche con donne specialmente coniugate, i mariti delle quali tacciono sul proprio disonore per tema d’incorrere nella vendetta inesorabile di quell’uomo temutissimo da tutti». Il medico venturiere (16) Giuseppe Fabroni ne fa un elenco alla commissione d’inchiesta.
—-
(16) Persona che esercita la professione o il mestiere alla ventura, cioè senza avere uno stipendio fisso da qualcuno, liberamente ora qua ora là, esempio: medico venturiere.
Si contano fra queste donne del Valgimigli per prima la signora Anna Monti moglie di Giovanni Ghetti possidente di Tredozio; la signora Umiltà Monti e anche la signora Assunta Monti moglie di Giuseppe detto il Papa; queste sarebbero del ceto delle signore. Fra le persone più basse poi il Valgimigli conta pure le sue favorite e sarebbero una certa Billi Rosa, una certa Tronconi ed altre tutte maritate.
Tra queste spicca Umiltà Monti che, apprendiamo dal libro di Bonfante: era una donna molto “svelta” e peggio; era vedova e in casa sua si facevano anche i “balli angelici”, cioè i balli in cui si ballava senza vestiti addosso». E un testimone aggiunge che è arrivata persino a far sparire il bambino della sua serva perché aveva un cagnolino piccolo rimasto senza mamma, così lo fece allattare alla serva.
Anche don Stiflón frequenta le feste da ballo di Carnevale vestito mascherato da donna, con visiera di ferro a buchi che solevano usare gli assassini e con dei smanigli d’oro, ma siccome l’ignoto è alto e sottile e un personale come lo ha il Valgimigli la gente non ha difficoltà a riconoscerlo dietro la maschera femminile. Pellegrino Artusi, che anche dopo il trasferimento a Firenze è informato dai commercianti romagnoli sugli sviluppi della vicenda di don Stiflón, commenta nelle sue memorie: Ma credete che qui finisca la storia di quel prete infernale? Neppure per sogno. Andò egli a stabilirsi a Tredozio e colà mise in agitazione tutto il paese. Gli venne fatto di contrarre una relazione amorosa con la moglie di uno di quei signori e poi, essendo scoppiato il colera, si dié a corpo morto, per farsi credito, a soccorrere ed assistere i colerosi cosicché formatisi due partiti, uno dei gonzi (che sono sempre i più) i quali lo proteggevano e l’altro dei ben pensanti che gli avrebbero dato fuoco, egli coraggioso com’era, andava a celebrar messa con la pistola in tasca. Queste cose, a lui relative, mi erano narrate da persone di quei luoghi degne di fede e don Giovanni Verità di Modigliana, il buon prete che salvò al vita a Garibaldi ed è ricordato con lode nelle sue memorie, mi raccontava fra le altre cose che un giorno i compagni del Passatore essendo venuti a questione fra loro, mentre sedevano a tavola, uno di essi si scagliò sul compagno che gli stava in faccia e con un colpo di arma affilata gli tagliò netta la gola. (17)
—-
(17) P. Artusi, Autobiografia, cit., p. 48.
Don Pietro ha già avuto storie con altre donne.
La prima con Lucia Cangialeoni, al suo servizio dal 1848 al marzo 1855, che mette incinta per due volte e poi accasa, con un matrimonio di comodo, con Giacomino Tronconi, detto Jacmèn, il giovane casante-sacrestano. E il secondo figlio muore quasi subito di stenti perché anche lui la costringe ad allattare un cucciolo di cane a cui tiene molto essendo appassionato cacciatore. La seconda con Giuditta Villa che subentra alla cugina Lucia. Giuditta ha 22 anni quando nel 1853 la sostituisce nelle faccende domestiche, anche se poi lei e suo marito Giacomino, vanno ad alloggiare presso la canonica continuando a prestare servizio per lui e Giuditta ammette che le ha insegnato molte cose perché all’inizio non sapeva fare proprio niente. Don Pietro fa subito presa sulla giovane che rimane clandestinamente incinta e la voce pubblica la indica come la sua druda. La ragazza va a sgravarsi dal cugino Bastiano a Val di Varana, parrocchia di Fregiolo. Tre anni dopo Giuditta aspetta un altro figlio ed è costretta a lasciare la parrocchia e cercar servizio presso altre famiglie di Tredozio.
Don Pietro, per mantenere la tresca, la mette in casa di Giuseppe Monti detto il Papa, possidente di Tredozio, 62 anni, vedovo con una figlia già grande, sposato in seconde nozze con la giovane Assunta Cavina. Don Pietro ha una relazione anche con lei e procura il maritaggio alla figliola per rimaner libero e frequentare la casa con la scusa di fare da maestro ai suoi bambini. C’è anche chi li ha scoperti in un bosco in attitudine oscena e chi ha trovato l’arciprete e l’Assunta abbracciati in casa. Anche lei partorisce un maschio che nel paese si mormora che per l’espressa somiglianza con lui si palesa per suo figlio e lo stesso prete se ne vanta ed è poi somigliantissimo al primo bambino partorito da Giuditta.
Intanto la pancia cresce; Giuditta non è più in grado di prestare il servizio di prima in casa Monti e tutti dicono che ha fatto un altro figliuolo con l’arciprete. La giovane è liquidata con 4 o 5 francesconi e viene licenziata e don Pietro deve smettere di frequentare la famiglia.
Per sistemarla propone ad Antonio Monti detto Macacco, un faticante della casa, di sposarla e ne parla con don Cesare Poggiolini, parroco di San Pietro a Castagneto, onde sia affatturato il matrimonio. Assunta, saputa la cosa, si arrabbia perché dice che in casa sua non vuole tresche e licenzia anche il garzone. Don Pietro allora la convince ad andare a Firenze per abortire. Il 30/9/1857 parte per la capitale con Macacco che le paga le spese sostenute per i giorni trascorsi in città per trovare un impiego. Prende servizio in casa di Gaspero Doni, scritturale di Burò al ministero dell’Interno, abitante in via dei Leoni nel centro di Firenze dietro Palazzo Vecchio. Ma non può nascondere la gravidanza a lungo e due mesi dopo don Pietro la raggiunge, alloggiando in una locanda sotto falso nome, per procurarle mercé dei medicinali un violento aborto. Dei contrattempi non previsti ostacolano la pratica e il 21 dicembre Giuditta è ricoverata per sgravarsi del feto nell’Ospizio dell’Orbatello, da dove è dimessa il 25 febbraio dell’anno dopo tornando a servizio del Doni. Il neonato è portato nel vicino Spedale degli Innocenti. All’epoca, una parte di questo edificio era destinata alle gravide vergognose e qui finivano gl’infanti abbandonati, i cosiddetti gettatelli, innocentini o nocentini. Lo Spedale esercitava la sua beneficenza nella provincia di Firenze, nel Mugello e nella Romagna toscana dove erano aperti gli spedaletti succursali a S. Piero in Bagno, Modigliana, Premilcuore e Galeata. Ed è probabilmente questo il percorso di Giuditta nel suo travagliato parto clandestino del figlio della colpa.
Il suo posto è preso da Veronica, la donna con cui è sorpreso dai gendarmi nel gennaio 1857. Nel frattempo pratica anche Rosa Billi, che gli fa da moglie e va da lui tutte le notti in quanto, essendo di bassa estrazione, di giorno il prete la evita perché, come ha ben spiegato il dottor Fabroni, gli piace distinguere fra il ceto delle signore da frequentare in pubblico e le persone più basse con cui è bene non farsi vedere. Anche lei si presta a fare la mezzana, ma siccome è di lingua lunga, don Pietro le proibisce anche di andare a servire in casa Monti dall’altra sua amante Assunta; infine la licenzia.
Intanto inizia anche una liaison con Anna Monti sposata con Giovanni Ghetti, (18) che la stessa Veronica e sua sorella Maria accompagnano a casa sua e quando i due si appartano in camera, loro aspettano in cucina.
—-
(18) Don Pietro definisce Giovanni Ghetti un coticone zotico, sguaiato e ignorante; sta di fatto, però, come ci spiega Bonfante, che successivamente divenne capitano della guardia civica, assessore e poi sindaco; partecipò alle guerre d’indipendenza e fu il fondatore della Società di Mutuo Soccorso di Tredozio a cui lasciò in eredità il suo palazzo e tre poderi. Forse don Pietro non lo teneva in gran stima essendo questi il marito di una delle sue donne e di idee anticlericali.
Una relazione molto chiacchierata perché la sua famiglia è una delle più in vista del paese. Anna è figlia di Calocero Monti, un uomo astuto e intelligente che ha iniziato la sua carriera raccattando da ragazzetto lo sterco per le vie con un cesto in mano e qualche volta a campar d’accatto fino a diventare l’amministratore del patrimonio della ricca famiglia di Filippo Bonaccorsi. (19)
—-
(19) La famiglia Bonaccorsi Dolcini Dal Prato è iscritta nel Libro d’oro del patriziato fiorentino ed è considerata la più ricca di tutte le Romagne. Dal matrimonio di Filippo Bonaccorsi con Rosa di Pier Matteo Ragazzini nascono quattro figlie: Eleonora, Ortensia, Rosa e Anna. Quest’ultima va in sposa a Bettino Ricasoli, un testimone è lo stesso Calocero, con un matrimonio d’interesse che risolleva le deplorevoli condizioni in cui versano le finanze del nobile toscano. E quando il barone, alla prematura morte della moglie liquida tutto il patrimonio immobiliare romagnolo, gli riserva un trattamento di favore cedendogli numerosi poderi a una somma decisamente contenuta a ricompensa alle straordinarie occupazioni avute come amministratore dei suoi averi. In: D. Bronzuoli, Matrimoni e patrimoni, Firenze, Ed. Polistampa, 2013, pp. 29, 68 e segg. E quando Bettino, governatore delle Provincie Toscane, dovrà valutare le istanze di grazie e riduzione della pena di don Pietro, i suoi legami affettivi ed economici con Tredozio di certo avranno influito nelle sue decisioni.
Calocero sa che all’arciprete piacciono le donne, ma finge di non vedere niente anche se la loro storia è sulla bocca di tutti. (20)
—-
(20) Don Pietro ha il dente avvelenato nei confronti di Calocero, che nel suo Sogno alle Murate, il racconto fantastico che scrive quando è detenuto nel carcere fiorentino, identifica nella figura del ladro che deruba il ricco signore (Filippo Bonaccorsi) e i suoi fratelli due preti don Giovanni Battista, suo compare e don Andrea, parroco di San Benedetto in Alpe e un secolare Giuseppe detto il Papa, noto per essere un uomo pio, che fa rinchiudere in manicomio. E lui stesso che dal matrimonio con Teresa Fantini, di diciassette anni più giovane, ha due figli, maschio e femmina, fa con lei la separazione di toro, così scrive don Pietro, per non disperdere l’ingente patrimonio accumulato.
Il marito Giovanni è una persona specchiata, ma debole e tutt’altro che acquiescente a questa tresca, ma non ha il coraggio di reagire. Il suocero Paolo Ghetti è uomo più risentito, ma pure lui non si azzarda a dir nulla e chiede all’avvocato Pietro Fantini e a suo fratello Lorenzo, gli zii, di convincerla a cessare quell’indecenza, ma la donna nega tutto. E probabilmente per causa del patema d’animo che gli procura la condotta della nuora, alla fine ha un accidente che lo blocca, sebbene sia ancora in grado di parlare. Ma le chiacchiere sono insistenti perché i due sono stati visti insieme lungo il fiume Tramazzo in una brillera, verso la mezzanotte in attitudine turpe e il prete trovandosi una volta in casa della donna malata, con la scusa di tastarle il polso, mise le mani sotto le lenzuola e invece gliele teneva fisse nelle parti pudende, senza alcun riguardo alle persone che vi erano presenti fra le quali il padre del Ghetti di lei marito, il quale non si azzardò a non dire nulla per il gran timore che ha di questo prete. I due si vedono anche conversare senza alcun riguardo sulla pubblica via e la gente mormora che quel becco del marito, si strugge dalla passione, ma tace ed é in grave apprensione pel conosciuto feroce carattere del prete ed anche per quello assai capriccioso della propria moglie. E a volte s’incontrano pure in qualche locanda compiacente a Firenze dove lui si presenta travestito e sotto falso nome.
4. L’indagine segreta prefettizia
La situazione si è spinta a tal punto che nel giugno 1857 la Dominante sollecita un’indagine su don Stiflón essendo la sua condotta a Tredozio motivo di grande scandalo. Ma il sottoprefetto ha difficoltà a trovare chi sia disposto a deporre. Alla fine riesce a convocare in segreto alcuni notabili di Tredozio: l’avvocato Pietro Fantini, possidente; Andrea Leoni, speziale di Tredozio, fratello di don Cesare Leoni vicario foraneo di Tredozio succeduto a don Valgimigli nella cura di San Valentino; Calocero Monti direttamente interessato perché è il padre di Anna; Luigi Brenti, possidente; Angiolo Vivoli, di Firenzuola, medico condotto a Tredozio; Giuseppe Fabbroni, medico chirurgo di cui abbiamo già detto.
Tutti chiedono garanzie per la loro incolumità, accettano a condizione che la deposizione sia segreta e confermano che egli tiene ora pratiche scandalose e immorali con diverse donne coniugate e no, ben spargendo il disordine e la discordia in alcune famiglie, che impudentemente ha esercitato atti gravissimi e ributtantissimi alla vista altrui, che esercita illegalmente la medicina, che professa massime antireligiose e perverse, che è dedito ai brogli, al giuoco, alla crapula, che si mostra dissoluto fino alla nausea, di niuna fede politica, regolato solo dai propri appetiti e dalle proprie passioni, conculcatore di ogni Legge Divina ed umana, prepotente, tenace nelle persecuzioni, temibile nell’ira, dispregiatore di ogni rimorso, pronto e capace di ogni delitto. In particolare, il farmacista è tra i più intimoriti, viste le grandissime relazioni di don Pietro non solo in Tredozio, ma anche con impiegati molto alti, ed anche in Firenze e si sente colpito sotto l’aspetto professionale e familiare. È notorio, dice, che il prete Valgimigli esercita la medicina e nessuno, neppure fra quelli della polizia, ha il coraggio a denunziarlo e con la sua ciarla trova anche dei creduloni che gli danno retta e si fanno medicare da lui ed anzi a Modigliana vi è il suo fratello speziale, che spedisce quante ricette detto prete gli manda. Da parte sua si è astenuto più che ha potuto, ma siccome una volta il prete lo ha minacciato, ora si limita a dare dei medicinali semplici, come olio di ricino, rabarbaro, santonina (21) e simili, che si vendono anche dai droghieri, tanto per non urtarlo di più.
—-
(21) Santonina: principio attivo contenuto in diverse specie del genere Artemisia, usato in medicina come vermifugo.
In materia di religione è un ateo, e uno che non crede a nulla, o crede a modo suo. Per lui non è peccato l’adulterio, l’incesto e lo stupro, ed egli stesso ha detto che questi fatti non sono proibiti dal Vangelo, e che sono immaginati dai preti per tenere la pace nelle famiglie, ed anzi ha rimproverato mio fratello prete perché ha denunziato le fanciulle incinte del suo popolo, dicendo che son cose che non vanno avvertite e anche il vescovo ha paura, e perciò lo tollera. Spende e spande oltre i limiti di quello, che si conosce che abbia, prosegue il farmacista e la sua casa è aperta a tutti i più viziosi del paese; costì vi si tiene gioco e vi sono crapule e gozzoviglie continuamente e con questo mezzo ha saputo procacciarsi molti aderenti, che gli fanno una polizia a parte. È anche dedito agli imbrogli e con questo mezzo si procura aderenti, non mancandogli né testa, né istruzione, né furberia. Il Fabbroni è stato scolaro con don Pietro, ma della vecchia amicizia non resta più nulla e osserva che quelli che lo evitano in pubblico, in privato lo invitano a far la partita nelle loro case. Anche lui sa che esercita illegalmente la medicina, senza però essere a conoscenza di conseguenze sinistre per i malati. Calocero Monti conferma la pessima fama dell’arciprete per avere ricettato i briganti, partecipato alle loro ruberie e condiviso i bottini e per averne lui stesso ammazzati tre. Finge di non sapere dei fatti di famiglia, ma sa delle tresche illecite con varie donne anche maritate e crede che alcune di loro vi si prestino per i quattrini che egli sparge a piene mani. Anche nella conduzione del suo ministero è irreligiosissimo ed esprime massime contrarie al Vangelo, dicendo che il trattar le donne non è peccato e sottolinea anche la sua attività di sensale di pochi scrupoli perché fa da cavalocchio, (22) e tratta gli affari dei terzi e dei quarti, fa dei compromessi, delle scritte, e dà consigli per interessi a questo e quello.
—-
(22) Cavalòcchio: Chi fa l’avvocato in cause di poca importanza o senza averne il titolo, senza porsi eccessivi scrupoli. Quegli che prezzolato riscuote i crediti altrui e fa de’ garbugli e degli abbindolamenti legali (P. Fanfani, Vocabolario dell’uso toscano, Firenze, G. Barbera, 1863).
Il Vivoli abita vicino alla casa di don Pietro e perciò vede chi la frequenta: persone del popolino, che il prete alletta per procurarsi le loro simpatie, intrattenendole nel giuoco, nella crapula senza neppur riguardo alle ore delle sue funzioni. Anche lui è a conoscenza dei suoi intrallazzi amorosi e conferma che esercita la medicina senza alcuna matricola, spedisce ricette ed ha persino vaccinato dei bambini, procurandosi da Modigliana i medicinali occorrenti per le cure che egli intraprende. Al termine delle deposizioni i testimoni si rifiutano di firmarle dicendo di essersi già troppo esposti con le sole dichiarazioni a un grave pericolo e non le ripeteranno in una pubblica udienza.
5. L’arresto e l’interrogatorio alle Murate
Ragguagliato sulle malefatte del prete romagnolo, lo stesso Canapone, il granduca Leopoldo II, ravvisa opportuno un provvedimento disciplinare atto a frenare in lui tanta licenza e il ministro degli Affari Ecclesiastici chiede di rimuoverlo con discrezione dal paese e di tradurlo sotto buona scorta alle carceri pretoriali di Firenze, per contestargli in modo bastantemente sicuro e tranquillo le sue defezioni con la circospezione necessaria per tutelare i testimoni che temono di esporsi con le loro dichiarazioni.
Il prefetto dispone un’inchiesta, questa volta non più segreta, per stabilire la gravità degli addebiti contestati e ordina la sua carcerazione chiedendo di agire con efficacia per evitare disgustose emergenze. La Ministeriale con l’ordine dell’arresto giunge con la diligenza della mattina del 14/1/1858. Per assicurare la massima segretezza dell’operazione, si decide di far agire la gendarmeria di Rocca e non quella di Modigliana dove don Pietro ha parenti e amici e può in qualche modo venire a saperlo. La trappola scatta la mattina del giorno dopo: mentre don Pietro esce di casa per recarsi in chiesa a celebrare la messa è arrestato e tradotto nel quartiere della gendarmeria locale ed ivi trattenuto fino a sera con i riguardi dovuti al suo carattere sacerdotale. Quando la situazione è più tranquilla e tutti sono rientrati in casa, viene caricato sul calesse di Luigi Poggiolini, Bulone e trasferito a Rocca per la strada ghiacciata del monte Busca che costringe gli uomini della scorta a scendere e a camminare a piedi. La notte seguente è tradotto a Firenze dove giunge il 18. Qui viene registrato al Bargello dove sono espletate le formalità di rito, poi è trasferito nel carcere delle Murate in una stanza ben sicura e totalmente separata da altro detenuto e con le cautele prescritte, si raccomanda il prefetto, in conformità del Concordato tra i Governi Toscano e Romano. Appena Anna Ghetti apprende la notizia, decide di seguirlo. Dice al marito che le sarebbe piaciuto tornare a Firenze dalla zia Marianna per trascorrere un po’ di giorni per il carnevale. L’uomo acconsente. La sera stessa va a Rocca a casa di Pompeo Valgimigli, fratello del prete, per valutare il da farsi. Poi, travestita da uomo, parte subito per la capitale. Quando sa del suo arrivo, don Pietro le scrive una lettera apparentemente formale, ma con il preciso scopo di attivare all’esterno procedure utili per farlo uscire di prigione. La censura del carcere intercetta e blocca il mes- saggio. Ma Anna entra subito in azione e la mattina del 21 gli manda una colazione: caffelatte e semel, (23) e dentro il semel ha nascosto un biglietto con un messaggio: Tentiamo ogni mezzo per metterci in comunicazione con te per giovarti, salvarti se è possibile.
—-
(23) Il Vocabolario dell’uso toscano, cit., definisce il semel una foggia di piccolo pane finissimo e di particolare lavorazione, che suole usarsi intingere nel caffè e altre bibite a colazione. C’è chi lo mangia anche a pranzo.
So tutto e siccome il disperarsi non giova, procuro renderti meno peggio la tua prigionia. Domattina verrà Ernesto a nome di tuo fratello Pompeo a sentire di dove desideri ti sia portato il pranzo e tu dirai: dalla Villa de Paris. Dopo pranzo ti verrà servito un caffè, nel manico del bricco vi sarà l’occorrente per poter rispondere, prova ogni mezzo per svitarlo, tieni il lapis e metti la risposta dove trovi la roba. Io sono stata alla Rocca da Pompeo. Qualunque cosa ti sia portata osservala attentamente, sia stufato, fritto, tabacco, insomma tutto. Addio Pietro ama chi ti adora, ti è fedele e sarà sempre tua a costo della vita. Spero che mi risponderai che sono disperata, te lo figuri. Un bacio il più tenero ti dà la tua sposa con la speranza che tu l’ami ancora». Ma il
trucco è scoperto e il corriere arrestato e don Pietro ha tanto rancore in corpo se è vero, come riferisce il fiduciario della polizia, che in una lettera scritta alla Ghetti le chiede: Se mi ami procura di uccidere tuo marito.
Durante la sua permanenza fiorentina Anna sa che è sorvegliata, ma è brava a dissimulare i suoi movimenti e riesce a sapere che il delegato di Santa Croce di lei dice che fino ad oggi non ha dato da sospettare in alcun rapporto colla propria condotta e che il suo soggiorno nella capitale, non ha altro scopo che quello di un semplice passatempo, tanto più che la Vespignani, [la zia] usufruttuaria dello stabile in cui dimora, è donna che fino ad oggi non ha dato da sospettare in alcun rapporto colla propria condotta. Ma la sua lontananza dalla famiglia si prolunga oltre i limiti del lecito, il marito e il padre fanno di tutto per ricondurla al tetto maritale e la sera dell’8 marzo, Calocero va a riprendersela e la riporta a Tredozio tenendola a casa sua per un po’ di giorni, colla veduta di riunirla in seguito al marito e di richiamarla con paterne ammonizioni a più esemplare condotta, appartenendo ad agiata ed onesta famiglia. Intanto il prete passa i giorni in isolamento finché il 7 febbraio è condotto nella stanza degli esami ordinari dove lo attende il delegato di S. Croce. Don Pietro protesta di non conoscere il motivo dell’arresto. Il funzionario gli contesta di aver tenuto una condotta non solo irregolare, ma di più eminentemente riprovevole, la fierezza del carattere e una effrenata tendenza al libertinaggio.
Don Pietro si difende dicendo di aver dato un grosso contributo al governo nel disperdere i malfattori di Romagna e questo gli ha provocato l’odio di alcuni funzionari governativi locali gelosi del suo rapporto diretto col sottoprefetto di Rocca e di alcuni tredoziesi che avevano complottato per ottenere il suo arresto. Si è sempre comportato come uomo pacifico, prudente e facile al perdono. Conserva ancora gli attestati di riconoscenza del gonfaloniere, di alcuni priori e del pievano in occasione del colera e può dire che il popolo di Tredozio è con lui. Chiede i nomi dei suoi accusatori. Per tutta risposta, il delegato replica che il processo è ultimato e non ci saranno ulteriori esami. Anzi, sostiene che le misure prese dal governo sono dirette non tanto a punirlo, quanto a tutelarlo. Lui ringrazia per l’aiuto sebbene trovi strano ottenere la sua sicurezza col rimanere detenuto in un carcere penitenziario.
Dopo quell’unico interrogatorio resta in una snervante attesa degli eventi. E ragiona: ma se il processo è finito, perché non si è ancora giunti a delle conclusioni? E perché non gli è consentito di difendersi?
Nelle sue memorie difensive dice di non conoscere il motivo del suo arresto. Di aver lasciato la parrocchia su pressione del vescovo e del governo. Nessuno si è mai lagnato sul suo conto.
È stimato da tutti i signori di Tredozio, ammesso in quasi tutte le case di persone oneste ed estimato poi direttore del lazzaretto ai tempi del colera. Di più, ha avuto anche l’assistenza di parecchi malati nelle primarie case del paese, per lo che questi signori non avrebbero di certo avvicinato una persona la quale si fosse macchiata, come viene falsamente dedotto, di così gravi misfatti. Anzi, prosegue, vorrei che mi si trovasse una sola persona colla quale in tre anni abbi avuto che dire né il minimo dissapore e che sia capace di fare di me quel carattere, che per quanto sento mi viene attribuito.
Gli viene contestato di essere un soggetto facile all’ira, come capace di qualunque vendetta; di sbrigliarsi cioè ad ogni genere di vita licenziosa e di corruttela ad ognuno disdicevole, specialmente poi a chi riveste il carattere sacerdotale; di sedurre un buon numero di donne nubili e maritate con oltraggio impudente alla morale e con detrimento anche gravissimo dell’ordine della famiglia. Non è vero, ribatte, perché con molte parole non si fa neppure un fatto ed io vorrei che mi fossero contestati fatti precisi e non rimproveri generici. Dicono che lo hanno visto in congressi con femmine in luoghi, tempi e modi da ritenerli senza velo per disonesti avvicinamenti, da cui si dice che sono nati anche dei figli che apertamente si designano come miei. Lui può solo dire che ha parlato con delle donne, ma non in modo disonesto, né in modo da dar sospetto se nonché a quelli che hanno la vista più acuta dello stesso Dio, da poter conoscere nei figli nati a quale padre appartengano. Gli sono state contestate anche altre sue inclinazioni viziose come il giuoco, la crapula, l’associazione ai più depravati, l’esercizio illegale della medicina e l’arresto è stato eseguito a seguito degli ordini del Superior Governo e per misura di alta polizia. Lui può solo rispondere di essersi qualche volta divertito con persone oneste e in modi limitatissimi, di aborrire la crapula, di non aver accostate persone per alcuno modo riprovevoli; di avere qualche volta assistito i malati, ma non come medico. Tutte queste sono solo calunnie. Ma perché nessuno mi ha mai rimproverato o si è bonariamente lagnato, se non direttamente ma anche per mezzo di terze persone con me stesso?ribatte don Pietro e riflette: Alla fine di questo processo posso dire che ora finalmente so di soffrire non per mancanze che io abbia commesso, ma unicamente per cattiveria e malignità altrui. Non mi furono contestate se non che incoerenti chiacchiere, maligne supposizioni e un ammasso di ingiuriosi, infamanti vituperi, che
alcuni signori di Tredozio forse per privati odi e vendette hanno vomitato in un modo vergognoso contro di me. Non mi si è accennato neppure un fatto particolare, neppure una persona mi si è determinata ... Ecco la ricompensa, conclude, che i tredoziesi assegnano alle immense fatiche, che io sostenni nella luttuosa circostanza del colera e ciò non mi giunge nuovo, perché io sapevo di aver fatto troppo bene a quel paese per non dovermi aspettare la mercede, che Cristo preannunzia in terra a quelli, che per amor di lui sacrificano se stessi al bene altrui.
La sua famiglia intanto si attiva per cercare di capire meglio gli sviluppi della vicenda e manda Giacomino a Firenze per avere un colloquio con lui, ufficialmente per curare i suoi interessi e riferire alla famiglia sullo stato in cui si trovava il detenuto. Il giovane, analfabeta, si fa scrivere la richiesta dell’incontro in cui il motivo è per interesse di un paro di manzi venduti al Casetto di San Carlo. Il colloquio è autorizzato alla presenza del coadiutore del delegato di S. Croce.
Poi Giacomino torna a Tredozio e don Pietro si incontra con l’avvocato Ildefolso Giusti per imbastire una linea difensiva contro quel muro di silenzio che l’autorità costituita gli frappone.
Decide quindi di inviare al prefetto una memoria con la sua versione dei fatti e si dice sicuro di essere amato e ben voluto dalla maggior parte del Paese, anzi esclusi questi pochi mestatori di male, da tutti del paese. E conclude nella speranza che gli verrà fatta ragione il più presto possibile.
6. L’istruttoria romagnola e la condanna
Intanto anche in Romagna viene avviata un’indagine amministrativa da parte della sottoprefettura di Rocca. Le audizioni iniziano il 27 marzo e si concludono l’11/5/1858 e sono sentite 126 persone. I testimoni espongono il loro pensiero, tutto basato sulla pubblica voce, che si divide in tre categorie:
i partitanti che lo assolvono da ogni peccato o comunque lo giustificano; gli equidistanti che si barcamenano nel dire e nel non dire per questioni di quieto vivere;
gli accusatori, la maggioranza, che sono soddisfatti del suo arresto, ma che non si sbilanciano più di tanto per il timore di un suo ritorno in paese. Ma l’inchiesta stenta a decollare; dalla capitale partono pressanti sollecitazioni e, per accelerare i tempi, mandano da Firenze un giovane praticante copista per svolgere il servizio alla compitazione di questa procedura. Il sottoprefetto giustifica il ritardo con la necessità di muoversi con cautela per non allarmare i soggetti interessati e la famiglia Valgimigli è a conoscenza delle indagini e non lascia intentati mezzi onde espiarne le mosse nella veduta poi di paralizzarne gli effetti. Gli addebiti contestati a don Pietro sono:
- di cooperazione alla strage della famiglia Lombardi avvenuta per opera della banda Lisagna nella notte dal 5 al 6 aprile 1851;
- di favoreggiamento e ricettazione della suddetta banda nella propria canonica di San Valentino;
- di avere ucciso nel luglio 1853 Angiolo Lama detto Lisagna, Antonio Ravaglioli detto il Calabrese e d’aver poco dopo fatto uccidere dalla Forza a San Valentino Giuseppe Zannelli detto Cesarino allo scopo d’im- possessarsi dei loro averi;
- di avere dopo la detta uccisione, continuato a tenere relazione coi malviventi superstiti, in particolar modo con Giuseppe Afflitti detto Lazzarino;
- di avere tentato di organizzare una nuova banda di malfattori;
- di avere messa incinta la giovane Giuditta Villa di Tredozio, sua serva e tentato di farla abortire a Firenze;
- di avere infine tenuto una condotta biasimevole sotto tutti i rapporti ed in specie in quelli della moralità.
Il 2/6:1858 il Consiglio di Prefettura, conclusa l’inchiesta, condanna il sacerdote don Pietro Valgimigli parroco di San Valentino in Romagna alla reclusione per anni tre nello Stabilimento Correzionale per traviata condotta. Il 9 giugno è trasferito alla cella n. 36 nel reparto ove si trovano i condannati in espiazione e si trova al piano terreno, vicino all’infermeria. Una parte del carcere demolita nella ristrutturazione dell’edificio che ha conservato solo una porzione storica a memoria dell’antica prigione.
7. Il carcere
Il segreto dell’istruttoria e la pesante condanna inflittagli convincono don Stiflón dell’assoluta inutilità di avvalersi di un qualunque appello o ricorso che gli avesse accordato la legge sia in via di giustizia, sia in via di grazia. Cerca altre vie per uscire da quella situazione e quando conosce un altro detenuto, un certo Giulio Lijbert che ha un fratello, Pietro, cantante nel Teatro Ferdinando, gli dà più volte dei denari nella speranza che possa aiutarlo tramite il collegamento con un frate cappuccino all’esterno, ma scopertolo falso e impostore cessa di finanziarlo. Anche questo tentativo fallisce e alla fine si convince che è meglio rassegnarsi alla tristissima sorte ed espiare la pena inflittagli. Il 1859 è un anno di grandi eventi per la Toscana, il 27 aprile il granduca Leopoldo II se ne va per sempre da Firenze, grandi manifestazioni popolari per le strade e alle fortezze sono esposti vessilli tricolori. L’entusiasmo è generale, alle Murate si preparano bandiere, banderuole e coccarde e i detenuti sperano in un provvedimento di clemenza. La seconda guerra d’indipendenza prosegue vittoriosa. Bettino Ricasoli è nominato presidente e ministro dell’Interno del governo provvisorio toscano e il 6 settembre concede l’amnistia. Ma il provvedimento non riguarda il Valgimigli che resta in carcere.
Nel luglio 1860 don Pietro presenta una supplica al Ricasoli che, lo ricordiamo, ha sposato Anna Bonaccorsi Dolcini di Tredozio e quindi è sensibile alle istanze di quelli che non lo vogliono più in Romagna. Chiede di commutare la pena residua in esilio dalla Toscana per il tempo e alle condizioni fissate dal governo. Ammette la colpa, ma trova il castigo eccessivo. Contesta l’irregolarità della procedura con cui è stato condannato e i cinque mesi di carcere preventivo non computati nel calcolo della pena, quasi li avesse passati in villeggiatura, ironizza. La supplica si arena sul tavolo del barone di ferro. Il 6 ottobre insiste chiedendo al governatore che, qualora non voglia condonargli tutta la pena, computi almeno il carcere preventivo, ritenendo la pretesa di farlo partire dal giorno della sua condanna, esorbitante ed assurda e chiede inoltre, come atto di grazia per la lunga prigionia sofferta, di ordinare a di lui favore la piena remissione e condonazione di ogni pena ulteriore. Il barone sollecita i funzionari governativi di valutare se la memoria suddetta sia meritevole di attenzione. Il direttore delle Murate conferma che è corretto conteggiare il periodo intercorso dall’arresto alla condanna nel computo complessivo della pena. Il delegato di Modigliana constata con sorpresa che il fascicolo relativo al suo procedimento economico è praticamente vuoto e anche nell’archivio di Rocca non esistono elementi per valutare la richiesta, in quanto gli atti della procedura economica contro Valgimigli trasmessi a Firenze non sono stati restituiti. Emerge chiaro, quindi, che tutta la documentazione relativa a quell’affare è stata avocata dal governo centrale ... la ragion di Stato ha prevalso su tutti gli altri interessi e don Pietro, che pure per un certo periodo è riuscito a volgerla a proprio favore, se la ritrova ora contro in tutta la sua potenza burocratica. L’affare non si risolve e rimane pendente nell’attesa della superiore risoluzione che non arriverà mai. Don Pietro espia tutta la condanna ed esce il 1/6/1861 dopo aver scontato quarantun mesi di prigionia, compresi i cinque di carcere preventivo.
8. “Un sogno alle Murate”
Nei lunghi giorni trascorsi in carcere don Pietro si è ormai rassegnato a scontare tutta la pena. Ma vivere nell’angustia di una cella dove non si possono fare cinque passi senza intoppare nell’uscio o nel muro lo fa sentire come un uccello a cui hanno tarpato le ali. Lui è una persona colta e di gradevole penna; scrivere gli riesce piuttosto bene, anzi, gli piace proprio. Perché non mettere a frutto questo suo talento per non morire d’inedia? Perché non scrivere un libello in cui attacca i suoi accusatori e denuncia tutte le loro nefandezze? Ricorda bene lo scalpore suscitato da quello affisso a Modigliana dopo lo scontro di Spignano e il tradimento di Sacramento. Pian piano matura dentro di lui un desiderio di vendetta. Ottenuto il permesso, inizia a fermare sulla carta le sue impressioni e predispone il canovaccio dell’opera: sono già oltre quaranta capitoli, ognuno col proprio titolo e ce ne saranno sicuramente altri da aggiungere. Quando il 1/7/1861 riassapora la libertà ed esce dal portone delle Murate ha in mano una valigia con poche cose; tra queste un grosso fascicolo di oltre duecentocinquanta pagine con tutti i suoi appunti. Non è facile reinserirsi nella vita civile dopo un lungo periodo di carcere. Conscio della sua situazione, si rivolge agli amici che lo hanno sostenuto in quegli anni difficili e che, fortunatamente, non mancano di aprirgli la porta; tra questi don C.B. che gli chiede di poter leggere il manoscritto. L’opera ha la forma del romanzo, colla sola differenza che i fatti esposti non sono invenzioni di fantasia, ma sono tutte cose vere e realmente accadute e che vuole raccontare solo la verità dei fatti. Un sacerdote arrestato in chiesa, poco men che con l’ostia consacrata in mano, incatenato e guardato come un infame assassino, scrive don Pietro e senza alcun riguardo tradotto in carcere, non già perché reo di qualche delitto, ma per semplice misura di polizia; un accusato al quale si diniega e impedisce ogni possibile difesa e si condanna col deposto apertamente falso e calunnioso di pochi scellerati suoi giurati nemici, già noti al governo per uomini che non ebbero mai né fede né religione, sono fatti che di per sé, anche nudi e semplici, commuovono a dispetto e a sdegno chiunque li conosce. Don C.B. gli propone di completare l’opera e darla alle stampe. Alla fine don Pietro accetta e il libro viene edito nel 1861 dalla Tipografia Torelli di Firenze, col chilometrico titolo: Un sogno. Descrizione tolta da un’opera inedita intitolata “Le Murate di Firenze” ossia “La casa della depravazione e della mor- te”. Memorie apologetiche.
Il volumetto contiene solo una parte del lavoro complessivo articolato in 74 capitoli, dove don Pietro parla del suo arresto, della condanna e della dura vita in carcere fino agli ultimi giorni di pri- gionia e si paragona a Silvio Pellico, il patriota che narrò la sua reclusione nel libro Le mie prigioni. Il sogno comprende i capitoli dal XXIV al XXXI che illustrano le vedute in cui esso è articolato. Il sogno narra di un incendio scoppiato nel carcere delle Murate dal quale il protagonista è salvato da un’aquila grandissima tutta bianca come neve dal cui petto spiccavasi bianco e snello un corpo umano, cui soprastava la bella faccia d’angelica donna» (Anna Monti?) che, in un viaggio fantastico, lo trasporta in Transilvania, oltre i monti Carpazi. Qui lo accoglie un venerando vecchio, il buon Genio che lo introduce nel Palazzo della Verità. Visitando il bel maniero incontra dei personaggi che portano impressi in fronte i nomi identificativi: l’empio, il ladro, il fanciullone, l’ince- stuoso, l’ipocrita, il mestatore, il cacaciano, l’avaro, il materialone, il calunniatore e lo spergiuro, in cui si possono riconoscere i «signori» di Tredozio. Ma, conclude don Pietro: se qualcuno si vedesse tratteggiato in questo sogno così bene al naturale o che avesse inteso parlare di quei tali, di quelle tali S’ingannerebbe a partito!perché tutto è frutto solo dalla sua matta immaginazione e nulla più. Giustificazione posta a paravento o ulteriore presa in giro di don Stiflón, ben consapevole di ciò che ha scritto? Nel novembre dello stesso anno, don Natale Graziani, parroco di Ottignana e maestro della scuola comunale di Tredozio, scrive al suo cugino don Giovanni Verità, in quel periodo cappellano militare a Chieti, dei recenti fatti avvenuti a Tredozio: il mese scorso, dice, qualcuno ha lanciato al di là dei muri di cinta, nei cortili di alcuni palazzi di Tredozio, un libello dal titolo Un sogno alle Murate.
Un racconto, come ben riassume Bonfante, che parla di una serie di personaggi misteriosi; misteriosi solo formalmente, giacché, con abile penna, non solo sono stati descritti, d’ognuno di essi, i difetti più abietti, ma sono anche state, di loro, indicate caratteristiche tali da consentire ai tredoziesi la possibilità d’individuare la vera identità dei personaggi descritti e cioè una serie di persone notabili di Tredozio. Questi ultimi, hanno distrutto i libretti piovuti dal cielo nei loro cortili; ma qualcuno ha ugualmente avuto modo di leggere il libello e forse lo possiede ancora; sicché, dopo qualche tempo, la notizia di quel ch’è stato scritto si è diffusa ed è sopravvenuto in paese un grave scandalo. Anche la polizia si è mossa, perché sembra non sia estraneo ai fatti qualche funzionario di Rocca e, addirittura, sia coinvolto anche uno dei signori di Tredozio, destinatari del libretto, che pare abbia tenuto mano ai due banditi uccisi a San Valentino otto anni prima. Non esiste alcun dubbio, conclude don Natale, che quel ch’è successo costituisce la vendetta dell’ex arciprete di San Valentino condannato a tre anni di carcere a seguito delle loro testimonianze. Don Giovanni Verità, canonico della Collegiata di S. Stefano in Modigliana per diritto di famiglia, va collocato in quella categoria di preti liberali e liberaleggianti considerati dai superiori non forti in teologia che seppe distinguere nella chiesa l’aspetto dogmatico da quello storico e contingente, obbedendo al primo, dissentendo attivamente dal secondo. (24)
—-
(24) Comune di Modigliana, Centenario della morte di don Giovanni Verità salvatore di Garibaldi, Faenza, Unione Tip. Artigiana Faenza, 1985, pp. 15, 16.
Ed è con questo spirito di adesione ai moti risorgimentali che nel 1849 contribuisce al salvataggio di Giuseppe Garibaldi nella trafila romagnola. Don Giovanni conosce bene don Pietro Valgimigli, suo compaesano e collega e risponde a don Natale che non è affatto sorpreso di quello che il famoso prete ha combinato: uno scellerato da par suo non può che far opere che lo assomiglino; vedendosi osservato da tutti si sforza di rendere osservanti gli altri; la consolazione dei dannati, come volgarmente si dice, però continua, non per questo devi essere persuaso che io abbia buonissima opinione di alcuni individui, da quel tristo soggetto accusati ingiustamente, o non accusati; abbastanza conosco alcuni polli: ma guardo e passo. (25)
—-
(25) V. Becattini, Don Giovanni Verità. Prete Cattolico. Patriota Garibaldino, Faenza, Tip. Faentina, 1984, pp. 52, 53.
È, questa, la parte dell’opera scritta dal Valgimigli che ci è pervenuta commenta Bonfante nella sua appassionata e puntuale ricerca storica e che ci svela gli occulti accadimenti, scandalosi e perversi, che segretamente animavano la vita, in quello che appariva un tranquillo paese dell’Appennino, di alcune famiglie, tenutarie del potere economico, politico e religioso di quella comunità.
9. La seconda vita di don Stiflón
Quando si avvicina la data della scarcerazione, il barone Ricasoli, all’epoca governatore delle Provincie Toscane, chiede al prefetto quali misure di pubblica sicurezza intenda adottare sul Valgimigli per garantirsi efficacemente da quei disturbi, che sono forse a temersi per la di lui presenza in località nelle quali è inviso e dove ben sarebbe a desiderarsi che non ritornasse. Interpellato se fosse disposto ad abbandonare lo Stato e ridursi all’Estero», don Pietro, risponde che è necessario almeno momentaneamente, per sistemare i di lui interessi fermarsi a S. Valentino. Però nel momento in cui fosse tornato in libertà, le misure per tutelare il Valgimigli e provvedere nel tempo stesso alla quiete pubblica non possono essere che quelle prescritte dal Regolamento di Polizia Amministrativa, quindi il controllo sulla sua persona sarebbe assai limitato. Per impedire il suo ritorno in Romagna si cerca di convincere un fratello a incontrarlo a Firenze per sistemare i suoi affari. Il prefetto propone questa soluzione, ma lui non intende por piede, neppure momentaneamente, nel Circondario della Rocca e specialmente a S. Valentino e a Tredozio, ma
non vuole impegnarsi in precedenza e nell’incertezza della sistemazione che si propone dare ai propri interessi, ad abbandonare il Regno e ripararsi all’Estero. In qualunque caso però gli occorrerebbe solo portarsi a Modigliana e, comunque, espiata la pena, non ci sono motivi validi per impedirgli dei movimenti. In effetti le osservazioni del prefetto sono giuste e, quando esce dal carcere, don Pietro va a trovare diversi suoi amici a cui ha promesso di fare visita. Parte alla volta di Faenza, prosegue per Ferrara e dopo qualche settimana, passando da Bologna, rientra a Firenze. Poi, con una soluzione probabilmente già concordata, si trasferisce nel piviere di Cascia, diocesi di Fiesole, a Reggello in Valdarno. Qui può mantenere tutti i suoi contatti fiorentini e romagnoli, ha il fratello farmacista nella vicina Pelago e la vicina strada regia con il servizio postale che gli consente di curare i propri interessi e vendicarsi con la pubblicazione e la distribuzione del suo libel- lo. Si inserisce bene nella vita della comunità locale e nel 1870, insieme ad altri sacerdoti, contribuisce con 5 lire per l’obolo in aiuto al Concilio Vaticano e a sostegno del dogma dell’infallibilità del Papa quando parla ex-cathedra in materia di fede e di morale. (26)
—-
(26) In Voti del clero italiano per la definizione dommatica dell’infallibilità pontificia con l’offerte de’ sacerdoti al S. Padre Pio IX in omaggio ed aiuto al Concilio Ecumenico Vaticano raccolte nel giugno del 1870, Vol. II, p. 181, Torino 1870, Pubbl. del giornale L’Unità cattolica.
Il Concilio fu poi interrotto a causa della presa di Porta Pia e dello scoppio della guerra franco-prussiana e poi ripreso, dopo quasi un secolo, nel 1962 col Concilio Vaticano II.
Nel 1872, volendo trasferirsi a Cortona, chiede al vescovo di Fiesole, da cui la parrocchia dipende, un’attestazione sulle sue qualità morali. E il vescovo certifica che il Molto Reverendo Sacerdote Pietro Valgimigli oriundo
della Diocesi di Modigliana, per il corso di circa otto anni che ha dimorato in questa nostra Diocesi Fiesolana, si è sempre diportato lodevolmente e conseguentemente non è stato mai sospeso né colpito da censure o irregolarità che si sappia, per cui avendoci esposto di volere prendere dimora nella Diocesi di Cortona, lo raccomandiamo all’Ordinario della Diocesi predetta. A Cortona costruisce un buon rapporto col vescovo Giovan Battista Laparelli-Pitti, l’unico a sapere del suo passato, che pensa a lui quando, nel 1877, deve provvedere alla cura delle anime di S. Lorenzo a Rinfrena, una parrocchia vicina alla città, dopo la rinuncia del titolare. In lui trova le qualità necessarie per bene disimpegnare l’Uffizio di vacanza e lo nomina economo spirituale della parrocchia vacante. Don Pietro svolge il suo incarico con diligenza e passione dal 27/11/1877 al 28/6/1884, quando rinuncia ufficialmente alla parrocchia. Intanto continua a corrispondere col canonico don Tommaso Pierazzoli, cancelliere della curia di Modigliana, uno dei suoi pochi riferimenti rimasti in terra natia anche nei momenti più difficili che lo tiene informato sugli avvenimenti romagnoli, e gli scrive: In tutta la mia travagliata vita non ho mai avuto un tempo di dolce soddisfazione, di placida tranquillità come quello che passo ora e se questo, come spero, sarà l’ultimo periodo della mia vita, io debbo ringraziarne, ne ringrazio di tutto cuore il Signore. Morta del tutto la passione della caccia, dei divertimenti, io posso senza lotta attendere al mio dovere e la sera quando vado al riposo m’addormento subito perché non sento alcuna inquietudine che possa agitarmi. Dio sia benedetto! Questa corrispondenza ha un brusco soprassalto quando lo Stato italiano gli sospende la pensione granducale. Il regio decreto del 5/12/1880 stabilisce che gli impegni dello Stato inerenti gli affari ecclesiastici e del culto passino all’Amministrazione del Fondo per il Culto e un’apposita commissione valuti le origini e le cause, sopprimendo tutti quegli impegni dello Stato che non avessero basi contrattuali e non riportassero derivazione legale e fossero puramente graziosi. Chi si sente leso nei suoi diritti può ricorrere in via amministrativa producendo i documenti giustificativi del suo credito. Don Pietro si rivolge a un avvocato di Arezzo, Pietro Maggi, che lo consiglia di rinunziare alle 30 lire mensili che riscuote per l’incarico di economo spirituale della parrocchia di S. Lorenzo a Rinfrena e che possono interferire negativamente nella riassegnazione della pensione. Così lascia ufficialmente l’incarico comunicandolo al vescovo che accetta le dimissioni e il 6 agosto nomina al suo posto don Giovanni Ciabattini con lo stesso stipendio mensile. In realtà è un giochetto concordato fra i due per ingannare lo Stato italiano, che così spiega a Pierazzoli: È un accordo fatto col vescovo. Io rinunziai, il vescovo accettò la rinunzia; fu nominato economo un parroco limitrofo, il quale figura in faccia al governo, riscuote dall’economo e passa a me l’assegno perché sono io che faccio come prima ogni cosa. Apre un contenzioso col nuovo Stato ed è determinato ad andare in fondo fino all’ultimo respiro, ma quando sta per dar fuoco alle munizioni, l’Amministrazione del Fondo per il Culto decide di soprassedere perché sarebbe stata una pessima pubblicità per lo Stato dovere ammettere pub- blicamente di continuare a pagare una pensione acquisita per meriti poco edificanti, con sua grande meraviglia che si siano ricreduti senza una sentenza e alle sole ragioni prodotte dall’interessato per sopra più prete». E il 17/5/1882 la ricevitoria dell’Intendenza di Finanza di Arezzo gli paga la pensione sull’unghia, arretrati compresi, assicurandolo che le future rate trimestrali saranno corrisposte puntualmente. Don Pietro è raggiante e desidera di ritornare in Romagna di cui sente una forte nostalgia. Ma dopo un commovente incontro col vescovo di Cortona che lo invita a restare, come lui spiega a don Pierazzoli: sono rimasto a S. Lorenzo ed è molto probabile che qui me ne stia fino all’ultimo momento della mia vita. Difficilmente addunque potremo rivederci in questa terra: se piacerà al Signore ci rivedremo nella vita eterna e sarà per noi una gran gioia: speriamolo e rimettiamoci alla Divina Provvidenza». Don Pietro, parroco rinunciatario della cura di San Lorenzo a Rinfrena, muore il 30/1/1885 a Cortona. Ha da poco compiuto 61 anni, pieno di acciacchi e di ripensamenti morali. È sepolto nel cimitero della Misericordia di quella città munito dei conforti religiosi, speriamo redento dalle sue malefatte.
10. Processo postumo
Il 29/4/2018 è stata realizzata una ricostruzione storica del Processo a don Pietro Valgimigli detto don Stiflón (1823-1885) prete della Romagna toscana nella bella sede di Palazzo Fantini a Tredozio grazie all’ospitalità degli attuali proprietari, con il patrocinio dell’Accademia degli Incamminati di Modigliana, del Comune di Tredozio, del Comitato della Romagna Toscana per la Promozione dei Valori Risorgimentali.
Lo scopo è stato quello di riaprire il caso di questo complesso ed enigmatico personaggio che all’epoca fu condannato sulla base di un procedimento indiziario in cui non ebbe la possibilità di difendersi perché già condannato dalla voce pubblica e poi esiliato per sempre dalla sua terra natale. Giusti o sbagliati che possano essere stati i motivi che portarono a queste conclusioni, questa revisione processuale postuma ha cercato di capire e valutare le molte accuse e le poche difese e dargli la possibilità di esporre anche il suo punto di vista per giungere alla fine di questo riesame con una sentenza emessa dal Collegio giudicante qui insediato e dal giudizio della giuria popolare presente in sala. Una ricostruzione storica, basata sui documenti raccolti nel libro Facinorosi pontifici, in cui sono stati coinvolti sindaci e volti noti di Forlì e provincia, che hanno partecipato con generosa disponibilità. (27)
—-
(27) Il collegio giudicante è formato dal presidente Luigi Cesare Bonfante giudice onorario presso il Tribunale di Ravenna e dai giudici a latere, gli avvocati Giancallisto Maz- zolini, Giancarlo Fontaine e Rosaria Tassinari, sindaca di Rocca San Casciano e da Simona Vietina, sindaca di Tredozio. Il pubblico ministero è Roberto Roccari, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena, mentre la difesa è rappresentata da Lorenzo Valgimigli, penalista; Iacopo Versari è il cancelliere. Al banco dei testimoni sfilano Pel- legrino Artusi, rappresentato da Giuseppe Mercatali, segretario dell’Accademia degli Incamminati; Giuseppe Vannucchi, sottoprefetto di Rocca, impersonato da Massimo Frassineti; Savino Savini, contadino a Senzano, è Luigi Pieraccini, già sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole e discendente di una vittima dei briganti; Andrea Leoni, speziale di Tredozio, interpretato da Claudio Samorì, già sindaco di Modigliana; monsignor Mario Melini, primo vescovo di Modigliana, recitato da Quinto Cappelli, storico e giornalista; Giuditta Villa, domestica di don Stiflón, è Maria Cristina Rossi, assessore del Comune di Modigliana; Anna Maria Monti in Ghetti, amante di don Stiflón è portata in scena da Maria Grazia Nannini; relatore è l’autore Pier Luigi Farolfi; lo spettacolo è aperto dai canti risorgimentali del Gruppo Cantastorie Modiglianese I Ciapa Cialdini.
La sentenza emessa dalla giuria togata lo ha condannato per avere messa incinta la giovane Giuditta e tentato di farla abortire a Firenze e per avere ucciso i briganti Lisagna, Calabrese e Cesarino.
Assolto per avere dopo la detta uccisione, continuato a tenere relazione coi malviventi superstiti, in particolar modo con Lazzarino; di avere tentato di organizzare una nuova banda di malfattori; di avere tenuto una con- dotta biasimevole sotto tutti i rapporti ed in specie in quelli della moralità.
Assolto, infine, per insufficienza di prove dalle accuse di cooperazione alla strage della famiglia Lombardi e di favoreggiamento e ricettazione della suddetta banda nella propria canonica di San Valentino.
Sentenza della giuria popolare:
- Colpevole: voti 64
- Innocente: voti: 46
A questo punto, anche alla luce dei nuovi contributi portati dal ritrovamento del Sogno alle Murate e dall’integrazione dei nuovi documenti prodotti da Bonfante, forse sarebbe opportuno dare a don Stiflón una ulteriore possibilità di difesa con l’indizione di un processo di appello che valuti e si esprima definitivamente su questi fatti.
Processo a don Pietro Valgimigli detto don Stiflòn
Sentenza
Inchiesta prefettizia
su don Pietro Valgimigli detto don Stiflón nato a Modigliana il 14/10/1823 da Cammillo e Domenica Baroggi, ordinato sacerdote nel 1846 e arciprete della cura di San Valentino dal 1847 al 1854, parrocchia posta nella parte di Romagna sotto il Granducato di Toscana, regnante Leopoldo II d'Asburgo Lorena detto Canapone.
Capi di accusa
Don Stiflón è accusato:
- di cooperazione alla strage della famiglia Lombardi avvenuta per opera della banda Lisagna nella notte dal 5 al 6/4/1851;
- di favoreggiamento e ricettazione della suddetta banda nella propria canonica di S. Valentino;
- di avere ucciso nel luglio 1853 Angiolo Lama detto Lisagna e Antonio Ravaglioli detto il Calabrese e d’aver poco dopo fatto uccidere dalla Forza a S. Valentino Giuseppe Zannelli detto Cesarino allo scopo d’impossessarsi dei loro averi;
- di avere dopo la detta uccisione, continuato a tenere relazione coi malviventi superstiti, in particolar modo con Giuseppe Afflitti detto Lazzarino;
- di avere tentato di organizzare una nuova banda di malfattori;
- di avere messa incinta la giovane Giuditta Villa di Tredozio, sua serva, e tentato di farla abortire a Firenze;
- di avere infine tenuto una condotta biasimevole sotto tutti i rapporti ed in specie in quelli della moralità.
Sentenza giuria togata
• assolto per insufficienza di prove;
• assolto per insufficienza di prove;
• colpevole;
• assolto;
• assolto;
• colpevole;
• assolto.
Sentenza giuria popolare
- Colpevole: voti 64
- Innocente: voti 46
Condanna
Don Pietro Valgimigli fu condannato alla reclusione per anni tre nello Stabilimento Correzionale
per traviata condotta.
Arrestato il 15/1/1858 e portato al carcere delle Murate a Firenze, ne uscì il 1/7/1861.
17 yerel halk öneriyor
Modigliana
Processo a don Pietro Valgimigli detto don Stiflòn
Sentenza
Inchiesta prefettizia
su don Pietro Valgimigli detto don Stiflón nato a Modigliana il 14/10/1823 da Cammillo e Domenica Baroggi, ordinato sacerdote nel 1846 e arciprete della cura di San Valentino dal 1847 al 1854, parrocchia posta nella parte di Romagna sotto il Granducato di Toscana, regnante Leopoldo II d'Asburgo Lorena detto Canapone.
Capi di accusa
Don Stiflón è accusato:
- di cooperazione alla strage della famiglia Lombardi avvenuta per opera della banda Lisagna nella notte dal 5 al 6/4/1851;
- di favoreggiamento e ricettazione della suddetta banda nella propria canonica di S. Valentino;
- di avere ucciso nel luglio 1853 Angiolo Lama detto Lisagna e Antonio Ravaglioli detto il Calabrese e d’aver poco dopo fatto uccidere dalla Forza a S. Valentino Giuseppe Zannelli detto Cesarino allo scopo d’impossessarsi dei loro averi;
- di avere dopo la detta uccisione, continuato a tenere relazione coi malviventi superstiti, in particolar modo con Giuseppe Afflitti detto Lazzarino;
- di avere tentato di organizzare una nuova banda di malfattori;
- di avere messa incinta la giovane Giuditta Villa di Tredozio, sua serva, e tentato di farla abortire a Firenze;
- di avere infine tenuto una condotta biasimevole sotto tutti i rapporti ed in specie in quelli della moralità.
Sentenza giuria togata
• assolto per insufficienza di prove;
• assolto per insufficienza di prove;
• colpevole;
• assolto;
• assolto;
• colpevole;
• assolto.
Sentenza giuria popolare
- Colpevole: voti 64
- Innocente: voti 46
Condanna
Don Pietro Valgimigli fu condannato alla reclusione per anni tre nello Stabilimento Correzionale
per traviata condotta.
Arrestato il 15/1/1858 e portato al carcere delle Murate a Firenze, ne uscì il 1/7/1861.
Stefano Pelloni e la sua masnada di briganti:
- Giuseppe Tasselli (Giazzolo) di Barbiano,
- Angelo Lama (Lisagna) e Giuseppe Morigi (Morischi) di Forlì,
- Felice Scheda (Anguillone), Francesco Babini (Mattiazza), Giuseppe Afflitti (Lazzarino) e Giacomo Drei (Il gobbo) di Imola,
- Antonio Ravaioli (il Calabrese) e Alfonso Panzavolta (l’innamorato) di Faenza,
- Luigi Serantini (Falcone), Giuseppe Zanelli (Cesarino) e Domenico Sabbatani (il Ghigno) di Castel Bolognese
- Michele Conti (Carrera) di Cotignola,
- Tommaso Montini (Teggione) di Masiera,
- Pietro Bertoni di Granarolo Faentino,
- Giacomo Emaldi di Fusignano,
- Giacomo Cantoni di Cesena,
- Antonio Farina (il famoso delatore detto Dumandone) di Villanova di Bagnacavallo.
513 yerel halk öneriyor
Rome
Stefano Pelloni e la sua masnada di briganti:
- Giuseppe Tasselli (Giazzolo) di Barbiano,
- Angelo Lama (Lisagna) e Giuseppe Morigi (Morischi) di Forlì,
- Felice Scheda (Anguillone), Francesco Babini (Mattiazza), Giuseppe Afflitti (Lazzarino) e Giacomo Drei (Il gobbo) di Imola,
- Antonio Ravaioli (il Calabrese) e Alfonso Panzavolta (l’innamorato) di Faenza,
- Luigi Serantini (Falcone), Giuseppe Zanelli (Cesarino) e Domenico Sabbatani (il Ghigno) di Castel Bolognese
- Michele Conti (Carrera) di Cotignola,
- Tommaso Montini (Teggione) di Masiera,
- Pietro Bertoni di Granarolo Faentino,
- Giacomo Emaldi di Fusignano,
- Giacomo Cantoni di Cesena,
- Antonio Farina (il famoso delatore detto Dumandone) di Villanova di Bagnacavallo.
In effetti la storia di Stefano Pelloni, meglio conosciuto come il Passatore, è così avvincente da averlo consacrato ad un mito che ancora oggi perdura, fonte d'ispirazione per diversi scrittori e studiosi.
Ma prima di addentrarci nelle vicende che lo riguardano, è doverosa una premessa che serva a spiegare come mai il fenomeno del brigantaggio, nel mondo contadino, ebbe il suo picco massimo proprio a metà Ottocento.
Lo storico britannico Eric J. Hobsbawn, padre degli studi sul brigantaggio sociale, definì in modo esaustivo gli elementi principali che lo compongono: è un fenomeno rurale che esiste da secoli, appare in società contadine pre-industriali, si manifesta quando l'equilibrio sociale è sconvolto da carestie, siccità, flagelli naturali e caos politico, quando la regione subisce il dominio di un potere straniero e l'amministrazione statale è troppo inefficiente per prendere misure adeguate per combattere il fenomeno.
L'analisi di Hobsbawm non sbaglia, in quanto le prime forme di banditismo su territorio romagnolo si attestano già dal Cinquecento, a seguito di carestie che colpirono quelle terre e causarono una crescente miseria, al punto che bande di ladri e di affamati si unirono agli ordini di Iacopo del Gallo e Pozzarino del Sesto, importanti banditi dell'epoca.
A metà Ottocento la situazione non era molto più evoluta: all'analfabetismo imperante si aggiungevano epidemie, condizioni di lavoro contadino precarie e con mezzi rudimentali ed un governo incapace di fare fronte alle necessità della popolazione.
Al tempo, la nostra penisola era divisa in tanti stati sotto il controllo dell'Impero Austro-Ungarico.
Le Legazioni di Bologna, Ravenna, Forlì e Ferrara in particolare tornarono a fare parte dello Stato Pontificio, uno dei più arretrati e reazionari della penisola.
In questo periodo storico crebbe Stefano Pelloni. Nato a Boncellino di Bagnacavallo il 4 agosto 1824, egli deve il suo soprannome al mestiere del padre Girolamo, che faceva il traghettatore tra una sponda e l'altra del fiume Lamone. In altri casi viene chiamato Malandri, dal cognome della donna che sposò un suo bisavolo.
I genitori aspiravano ad avviarlo alla carriera ecclesiastica, perciò Stefano entrò in seminario. Ma aveva uno spirito troppo ribelle, che mal sopportava la disciplina imposta a chi vuol diventare sacerdote. Perciò abbandonò il collegio religioso e si dedicò a mestieri poco remunerativi: giornaliero di campagna, scarriolante, muratore. Questo gli permise di acquisire contatti e conoscenze nel mondo rurale e forse anche di sviluppare una certa avversione per i possidenti, padroni delle terre coltivate con così tanta fatica da coloni e mezzadri.
A poco più di vent'anni, era personaggio ben noto alle forze dell'ordine, non solo nel Ravennate, anche se la tradizione più diffusa vuole che egli si trovò a diventare fuorilegge per una tragica fatalità: durante una festa, trovandosi a diverbio con alcuni conoscenti, forse per motivi politici, egli avrebbe lanciato un sasso contro gli avversari, colpendo però una donna incinta estranea alla rissa e uccidendo lei ed il suo bambino. Venne rinchiuso nelle carceri di Bagnacavallo, ma riuscì ad evadere e si diede alla campagna.
Quest'uomo cominciò a fare parlare di sé nel biennio 1849-1851, quando cioè riuscì ad unificare sotto il proprio comando i membri di altre bande del territorio ed a mettere a segno alcuni dei colpi più importanti:
- a Bagnara il 16 febbraio 1849,
- a Cotignola il 17 gennaio 1850,
- a Castel Guelfo il 27 gennaio 1850,
- a Brisighella il 7 febbraio 1850,
- a Longiano il 28 maggio 1850,
- a Lugo nel Ghetto Ebraico il 2 ottobre 1850,
- a Consandolo il 9 gennaio 1851,
- a Forlimpopoli il 25 gennaio 1851.
Banda del Lazzarino
Ma non si pensi che tutto questo fosse possibile senza un aiuto: il Passatore godeva infatti di una rete di informatori e protettori, gente che viveva nelle campagne, ma anche esponenti delle forze dell'ordine, che venivano ben ricompensati o che erano costretti a collaborare per paura di ritorsioni da parte dei fuorilegge.
Inizialmente, il governo del tempo si dimostrò totalmente incapace di neutralizzare o almeno arginare il fenomeno del brigantaggio: notificazioni, leggi repressive, provvedimenti di disarmo o registrazione dei mezzi di trasporto, non facevano altro che aumentare la fama dei briganti e di farli apparire come gli unici in grado di mettere fine alle ingiustizie della società.
Alla fine del 1849, però, le cose cominciano a cambiare: le autorità romane si avvalsero di un militare che si era fatto le ossa e costruito la carriera, da semplice gendarme a ufficiale, nella lotta contro i briganti delle Marche e del Lazio: Michele Zambelli. Il Comandante dei Carabinieri Pontifici aveva compreso che l'unico modo per colpire i banditi e catturarli era togliere loro gli appoggi: organizzò dunque delle squadre mobili in grado di inseguirli nei loro rifugi e comprese l'importanza dei pentiti, allora chiamati "riveli", che per aver salva la vita, denunciarono i loro compagni permettendone la cattura. Nello stesso tempo, le taglie sulla testa del Passatore e dei membri della sua banda venivano aumentate al punto tale da concorrere con le ricompense ricevute dagli stessi briganti per l'appoggio ricevuto. La vita di fuorilegge del Passatore andò dunque complicandosi notevolmente. La giustizia gli stava alle calcagna poiché gli informatori della polizia si moltiplicarono ed i rifugi diventarono sempre meno sicuri.
Il 21/3/1851, Stefano Pelloni ed alcuni dei suoi si trovavano nella casa di un collaboratore fidato, quando qualcuno li vide e li denunciò. All'arrivo della polizia scoppiò un terribile scontro a fuoco. I banditi riuscirono a scappare, dividendosi.
Il 23 marzo, Stefano e Giuseppe Tasselli (detto Giazzolo) si rifugiarono in un casotto di caccia di Villa Spadina di Russi, ma i loro fucili da briganti furono riconosciuti e vennero segnalati. I gendarmi accerchiarono il rifugio ed al termine dello scontro a fuoco che ne seguì, Giazzolo riuscì a fuggire, ma il Passatore cadde a terra morto.
Zambelli, una volta arrivato sul luogo, sottrasse il cadavere alle autorità di Russi con un obiettivo preciso: far sfilare la salma sfigurata del Passatore per i paesi della Romagna, affinché la gente potesse constatarne la morte per mano dei gendarmi.
Giuseppe Afflitti, il Lazzarino
Alla morte del Passatore, sarà Giuseppe Afflitti, detto il Lazzarino, a continuare a terrorizzare tutta la Bassa Romagna con una sua banda fino a quando, catturato, sarà fucilato a Bologna l'8/5/1857.
Dopo la battaglia di Magenta del 4/6/1859, gli Austriaci sconfitti dai Franco-Piemontesi, richiamarono le truppe presenti nello Stato Pontificio ed il 12 giugno abbandonarono Bologna. Dopo 10 anni era finita la dominazione austriaca, ma il Governo Piemontese che sostituirà quello dello Stato Pontificio non migliorerà di molto le condizioni sociali. Bisognerà attendere alcuni decenni per vedere cambiamenti significativi.
Il brigantaggio del Passatore rimarrà nei racconti dei contadini che lo tramanderanno nelle stalle d'inverno alla luce fioca delle lanterne, favorendo il diffondersi di storie e leggende sul conto dell'uomo che si schierò dalla parte dei poveri derubando i ricchi.
Nacque così, anche grazie a poeti come Giovanni Pascoli ed a dispetto della realtà che lo descrive come uno spietato criminale, la figura leggendaria del Passator Cortese. La povera gente continuò per anni ancora a ritenere il brigantaggio l'unico paladino contro le ingiustizie fino a quando, dopo la seconda metà dell'Ottocento, troverà la possibilità di rivendicare i propri diritti attraverso i grandi movimenti popolari di massa socialisti, repubblicani, anarchici.
Stefano Pelloni venne sepolto in un campo sconsacrato all'esterno del recinto della Certosa di Bologna. Forse qualcuno pensava che in questo modo sarebbe stato rapidamente dimenticato, ma il mito e le gesta del brigante scaltro ed imprendibile, che mise a segno tanti colpi con la sua banda, è arrivato fino a noi come parte integrante della coscienza collettiva ed importante tramite di comprensione del complesso sistema politico che in quel periodo dominava i nostri territori, definendone il tessuto sociale e condizionando le scelte di vita della popolazione.
Barbiano di Cotignola
In effetti la storia di Stefano Pelloni, meglio conosciuto come il Passatore, è così avvincente da averlo consacrato ad un mito che ancora oggi perdura, fonte d'ispirazione per diversi scrittori e studiosi.
Ma prima di addentrarci nelle vicende che lo riguardano, è doverosa una premessa che serva a spiegare come mai il fenomeno del brigantaggio, nel mondo contadino, ebbe il suo picco massimo proprio a metà Ottocento.
Lo storico britannico Eric J. Hobsbawn, padre degli studi sul brigantaggio sociale, definì in modo esaustivo gli elementi principali che lo compongono: è un fenomeno rurale che esiste da secoli, appare in società contadine pre-industriali, si manifesta quando l'equilibrio sociale è sconvolto da carestie, siccità, flagelli naturali e caos politico, quando la regione subisce il dominio di un potere straniero e l'amministrazione statale è troppo inefficiente per prendere misure adeguate per combattere il fenomeno.
L'analisi di Hobsbawm non sbaglia, in quanto le prime forme di banditismo su territorio romagnolo si attestano già dal Cinquecento, a seguito di carestie che colpirono quelle terre e causarono una crescente miseria, al punto che bande di ladri e di affamati si unirono agli ordini di Iacopo del Gallo e Pozzarino del Sesto, importanti banditi dell'epoca.
A metà Ottocento la situazione non era molto più evoluta: all'analfabetismo imperante si aggiungevano epidemie, condizioni di lavoro contadino precarie e con mezzi rudimentali ed un governo incapace di fare fronte alle necessità della popolazione.
Al tempo, la nostra penisola era divisa in tanti stati sotto il controllo dell'Impero Austro-Ungarico.
Le Legazioni di Bologna, Ravenna, Forlì e Ferrara in particolare tornarono a fare parte dello Stato Pontificio, uno dei più arretrati e reazionari della penisola.
In questo periodo storico crebbe Stefano Pelloni. Nato a Boncellino di Bagnacavallo il 4 agosto 1824, egli deve il suo soprannome al mestiere del padre Girolamo, che faceva il traghettatore tra una sponda e l'altra del fiume Lamone. In altri casi viene chiamato Malandri, dal cognome della donna che sposò un suo bisavolo.
I genitori aspiravano ad avviarlo alla carriera ecclesiastica, perciò Stefano entrò in seminario. Ma aveva uno spirito troppo ribelle, che mal sopportava la disciplina imposta a chi vuol diventare sacerdote. Perciò abbandonò il collegio religioso e si dedicò a mestieri poco remunerativi: giornaliero di campagna, scarriolante, muratore. Questo gli permise di acquisire contatti e conoscenze nel mondo rurale e forse anche di sviluppare una certa avversione per i possidenti, padroni delle terre coltivate con così tanta fatica da coloni e mezzadri.
A poco più di vent'anni, era personaggio ben noto alle forze dell'ordine, non solo nel Ravennate, anche se la tradizione più diffusa vuole che egli si trovò a diventare fuorilegge per una tragica fatalità: durante una festa, trovandosi a diverbio con alcuni conoscenti, forse per motivi politici, egli avrebbe lanciato un sasso contro gli avversari, colpendo però una donna incinta estranea alla rissa e uccidendo lei ed il suo bambino. Venne rinchiuso nelle carceri di Bagnacavallo, ma riuscì ad evadere e si diede alla campagna.
Quest'uomo cominciò a fare parlare di sé nel biennio 1849-1851, quando cioè riuscì ad unificare sotto il proprio comando i membri di altre bande del territorio ed a mettere a segno alcuni dei colpi più importanti:
- a Bagnara il 16 febbraio 1849,
- a Cotignola il 17 gennaio 1850,
- a Castel Guelfo il 27 gennaio 1850,
- a Brisighella il 7 febbraio 1850,
- a Longiano il 28 maggio 1850,
- a Lugo nel Ghetto Ebraico il 2 ottobre 1850,
- a Consandolo il 9 gennaio 1851,
- a Forlimpopoli il 25 gennaio 1851.
Banda del Lazzarino
Ma non si pensi che tutto questo fosse possibile senza un aiuto: il Passatore godeva infatti di una rete di informatori e protettori, gente che viveva nelle campagne, ma anche esponenti delle forze dell'ordine, che venivano ben ricompensati o che erano costretti a collaborare per paura di ritorsioni da parte dei fuorilegge.
Inizialmente, il governo del tempo si dimostrò totalmente incapace di neutralizzare o almeno arginare il fenomeno del brigantaggio: notificazioni, leggi repressive, provvedimenti di disarmo o registrazione dei mezzi di trasporto, non facevano altro che aumentare la fama dei briganti e di farli apparire come gli unici in grado di mettere fine alle ingiustizie della società.
Alla fine del 1849, però, le cose cominciano a cambiare: le autorità romane si avvalsero di un militare che si era fatto le ossa e costruito la carriera, da semplice gendarme a ufficiale, nella lotta contro i briganti delle Marche e del Lazio: Michele Zambelli. Il Comandante dei Carabinieri Pontifici aveva compreso che l'unico modo per colpire i banditi e catturarli era togliere loro gli appoggi: organizzò dunque delle squadre mobili in grado di inseguirli nei loro rifugi e comprese l'importanza dei pentiti, allora chiamati "riveli", che per aver salva la vita, denunciarono i loro compagni permettendone la cattura. Nello stesso tempo, le taglie sulla testa del Passatore e dei membri della sua banda venivano aumentate al punto tale da concorrere con le ricompense ricevute dagli stessi briganti per l'appoggio ricevuto. La vita di fuorilegge del Passatore andò dunque complicandosi notevolmente. La giustizia gli stava alle calcagna poiché gli informatori della polizia si moltiplicarono ed i rifugi diventarono sempre meno sicuri.
Il 21/3/1851, Stefano Pelloni ed alcuni dei suoi si trovavano nella casa di un collaboratore fidato, quando qualcuno li vide e li denunciò. All'arrivo della polizia scoppiò un terribile scontro a fuoco. I banditi riuscirono a scappare, dividendosi.
Il 23 marzo, Stefano e Giuseppe Tasselli (detto Giazzolo) si rifugiarono in un casotto di caccia di Villa Spadina di Russi, ma i loro fucili da briganti furono riconosciuti e vennero segnalati. I gendarmi accerchiarono il rifugio ed al termine dello scontro a fuoco che ne seguì, Giazzolo riuscì a fuggire, ma il Passatore cadde a terra morto.
Zambelli, una volta arrivato sul luogo, sottrasse il cadavere alle autorità di Russi con un obiettivo preciso: far sfilare la salma sfigurata del Passatore per i paesi della Romagna, affinché la gente potesse constatarne la morte per mano dei gendarmi.
Giuseppe Afflitti, il Lazzarino
Alla morte del Passatore, sarà Giuseppe Afflitti, detto il Lazzarino, a continuare a terrorizzare tutta la Bassa Romagna con una sua banda fino a quando, catturato, sarà fucilato a Bologna l'8/5/1857.
Dopo la battaglia di Magenta del 4/6/1859, gli Austriaci sconfitti dai Franco-Piemontesi, richiamarono le truppe presenti nello Stato Pontificio ed il 12 giugno abbandonarono Bologna. Dopo 10 anni era finita la dominazione austriaca, ma il Governo Piemontese che sostituirà quello dello Stato Pontificio non migliorerà di molto le condizioni sociali. Bisognerà attendere alcuni decenni per vedere cambiamenti significativi.
Il brigantaggio del Passatore rimarrà nei racconti dei contadini che lo tramanderanno nelle stalle d'inverno alla luce fioca delle lanterne, favorendo il diffondersi di storie e leggende sul conto dell'uomo che si schierò dalla parte dei poveri derubando i ricchi.
Nacque così, anche grazie a poeti come Giovanni Pascoli ed a dispetto della realtà che lo descrive come uno spietato criminale, la figura leggendaria del Passator Cortese. La povera gente continuò per anni ancora a ritenere il brigantaggio l'unico paladino contro le ingiustizie fino a quando, dopo la seconda metà dell'Ottocento, troverà la possibilità di rivendicare i propri diritti attraverso i grandi movimenti popolari di massa socialisti, repubblicani, anarchici.
Stefano Pelloni venne sepolto in un campo sconsacrato all'esterno del recinto della Certosa di Bologna. Forse qualcuno pensava che in questo modo sarebbe stato rapidamente dimenticato, ma il mito e le gesta del brigante scaltro ed imprendibile, che mise a segno tanti colpi con la sua banda, è arrivato fino a noi come parte integrante della coscienza collettiva ed importante tramite di comprensione del complesso sistema politico che in quel periodo dominava i nostri territori, definendone il tessuto sociale e condizionando le scelte di vita della popolazione.
Fra i componenti della banda del Passatore vi erano alcuni cittadini di Castel Bolognese:
- Giuseppe Zanelli, detto Cesarino, giovinotto di 23-24 anni, piccolo di statura, imberbe, di occhi castagni chiari, di bel colorito e buona carnagione;
- Domenico Sabbatani, detto Ghigno o Ghignone; - Giuseppe Serantini, detto Falcone;
- Giacomo Drei, detto della Rosa.
Essi presero parte alla invasione dei paesi di:
- Consandolo (25-1-1850),
- Longiano (28-5-1850),
- Brisighella (7-2-1850),
- Cotignola (18-1-1850).
Il Drei aveva partecipato all’impresa contro la canonica di S. Andrea Diolaguardia di Cesena, la sera del 5/1/1850, usando gravi sevizie contro il parroco don Antonio Fusaroli.
Giuseppe Serantini, figlio di Luigi Giacomo, di anni 24 e Giacomo Drei, figlio di Sante, di anni 31, furono condannati a morte “a iudicio statario militari austriaco”, assieme Carlo Mercatelli fu Francesco di Fognano (o Limisano?) e furono fucilati a Castel Bolognese il 1/5/1852 alle 2 del pomeriggio. Il giudizio statario era celebrato direttamente sul posto e quindi la procedura era sommaria.
Ecco la cronaca della fucilazione che Don Gamberini riporta nel suo diario (conservato nell’Archivio parrocchiale di San Petronio):
Furono in quest’anno condannati alla fucilazione dal giudizio Statuario Militare Austriaco:
- Carlo Mercatelli della Parrocchia di Limisano,
- Giacomo Drei del Giardino
- Giuseppe Serantini d’anni 24 di questa Parrocchia e fu eseguita la sentenza di morte di tutti e tre in una volta il giorno 1 maggio alle 2 ¼ pomeridiane nella fossa di questo Castello dirimpetto al vecchio Cimitero di Santa Croce dai Tedeschi. Essi vennero qui tradotti dalle Carceri d’Imola accompagnati da tre PP. Cappuccini, dopo averli colà sacramentati, e confortati e li assistettero fin all’ultimo. Qui si fecero prima le Agonie nel Suffragio, nelle Monache, in San Francesco e qui in Parrocchia ed appena eseguita la fucilazione andò il clero e fatte le esequie accompagnò i tre cadaveri al Cimitero, ove furono sepolti.
Non andò meglio a Giuseppe Zanelli, il Cesarino, che fu ucciso da una scarica dei gendarmi nel luglio 1853. Rimasto ferito in un primo scontro, fu caricato dai compagni su un cavallo e trasportato verso Marradi. Durante l’inseguimento fu nuovamente colpito, questa volta a morte.
La banda del Passatore a Castel Bolognese trovava alloggio presso la famiglia di Giuseppe Silvestrini del fondo Nardina, il quale ricettava gli ori e la refurtiva della banda; nella casa di Francesco e Mariano Montevecchi, detti Innocentone, mercanti di bestiame; presso la famiglia dei fratelli Fichi; in casa di Giuseppe Bacchilega, detto Delogazzo di Borello.
Un’altra curiosità che lega il Passatore a Castel Bolognese è stata recentemente raccontata a Sette Sere da Giovanna Carroli, custode del Mulino di Scodellino dal 1938 al 1998. Racconta Giovanna che a metà ‘800 a fare il mugnaio era il capo della Guardia Civica di Castello. Di notte perlustrava la strade per difendere la popolazione dai briganti. La guardia andava dicendo che se avesse incontrato il Passatore lo avrebbe ucciso. La voce arrivò alle orecchie del famoso brigante. Un giorno l’uomo si sposò nella chiesa di San Petronio e lasciò un suo amico fidato a guardia del Mulino. Questi vide più volte il Passatore aggirarsi nelle campagne circostanti e lo riferì al mugnaio. Saputo il fatto, questi si trasferì a Firenze e non fece più ritorno a Castel Bolognese.
Il Passatore, nato a Boncellino il 24 agosto 1824, fu ucciso in uno scontro a fuoco con i papalini il 23 marzo 1851. Il suo cadavere fu messo su un birroccio e portato in giro in tutta la Romagna, perchè tutti lo vedessero. A Castel Bolognese il carro sostò sulla via Emilia di fronte all’attuale sede della Banca di Romagna. Alla scena assistette Oliva Diversi, la nonna dello scrittore castellano Francesco Serantini, che del Passatore fu il più famoso storico (si veda a tal proposito il volume “Fatti memorabili della banda del Passatore in terra di Romagna”, pubblicato a Faenza nel 1929). Serantini evocò con documentata verità ma anche con paterna indulgenza, vita, imprese e morte di Stefano Pelloni, a lui legato per sempre e che quasi sicuramente aveva imparato a conoscere fin da bambino, grazie ai racconti di nonna Oliva.
Morto il Passatore, il resto della banda agiva diretta da Giuseppe Afflitti, detto Lazzarino. Il 10/10/1854 la banda del Lazzarino tentò un colpo a Castel Bolognese entrando nell’abitazione del possidente Francesco Gottarelli e appropriandosi di 423 scudi. Il garzone del Gottarelli, Giovanni Mingazzini, riuscì, inosservato, ad avvertire i gendarmi castellani i quali costrinsero la banda a fuggire. Nello scontro rimasero però feriti i gendarmi Giuseppe Stornini e Francesco Casadio, mentre il Gottarelli, rimasto pure gravemente ferito, morì pochi giorni dopo.
Castelbolognese-Riolo Terme railway station
Fra i componenti della banda del Passatore vi erano alcuni cittadini di Castel Bolognese:
- Giuseppe Zanelli, detto Cesarino, giovinotto di 23-24 anni, piccolo di statura, imberbe, di occhi castagni chiari, di bel colorito e buona carnagione;
- Domenico Sabbatani, detto Ghigno o Ghignone; - Giuseppe Serantini, detto Falcone;
- Giacomo Drei, detto della Rosa.
Essi presero parte alla invasione dei paesi di:
- Consandolo (25-1-1850),
- Longiano (28-5-1850),
- Brisighella (7-2-1850),
- Cotignola (18-1-1850).
Il Drei aveva partecipato all’impresa contro la canonica di S. Andrea Diolaguardia di Cesena, la sera del 5/1/1850, usando gravi sevizie contro il parroco don Antonio Fusaroli.
Giuseppe Serantini, figlio di Luigi Giacomo, di anni 24 e Giacomo Drei, figlio di Sante, di anni 31, furono condannati a morte “a iudicio statario militari austriaco”, assieme Carlo Mercatelli fu Francesco di Fognano (o Limisano?) e furono fucilati a Castel Bolognese il 1/5/1852 alle 2 del pomeriggio. Il giudizio statario era celebrato direttamente sul posto e quindi la procedura era sommaria.
Ecco la cronaca della fucilazione che Don Gamberini riporta nel suo diario (conservato nell’Archivio parrocchiale di San Petronio):
Furono in quest’anno condannati alla fucilazione dal giudizio Statuario Militare Austriaco:
- Carlo Mercatelli della Parrocchia di Limisano,
- Giacomo Drei del Giardino
- Giuseppe Serantini d’anni 24 di questa Parrocchia e fu eseguita la sentenza di morte di tutti e tre in una volta il giorno 1 maggio alle 2 ¼ pomeridiane nella fossa di questo Castello dirimpetto al vecchio Cimitero di Santa Croce dai Tedeschi. Essi vennero qui tradotti dalle Carceri d’Imola accompagnati da tre PP. Cappuccini, dopo averli colà sacramentati, e confortati e li assistettero fin all’ultimo. Qui si fecero prima le Agonie nel Suffragio, nelle Monache, in San Francesco e qui in Parrocchia ed appena eseguita la fucilazione andò il clero e fatte le esequie accompagnò i tre cadaveri al Cimitero, ove furono sepolti.
Non andò meglio a Giuseppe Zanelli, il Cesarino, che fu ucciso da una scarica dei gendarmi nel luglio 1853. Rimasto ferito in un primo scontro, fu caricato dai compagni su un cavallo e trasportato verso Marradi. Durante l’inseguimento fu nuovamente colpito, questa volta a morte.
La banda del Passatore a Castel Bolognese trovava alloggio presso la famiglia di Giuseppe Silvestrini del fondo Nardina, il quale ricettava gli ori e la refurtiva della banda; nella casa di Francesco e Mariano Montevecchi, detti Innocentone, mercanti di bestiame; presso la famiglia dei fratelli Fichi; in casa di Giuseppe Bacchilega, detto Delogazzo di Borello.
Un’altra curiosità che lega il Passatore a Castel Bolognese è stata recentemente raccontata a Sette Sere da Giovanna Carroli, custode del Mulino di Scodellino dal 1938 al 1998. Racconta Giovanna che a metà ‘800 a fare il mugnaio era il capo della Guardia Civica di Castello. Di notte perlustrava la strade per difendere la popolazione dai briganti. La guardia andava dicendo che se avesse incontrato il Passatore lo avrebbe ucciso. La voce arrivò alle orecchie del famoso brigante. Un giorno l’uomo si sposò nella chiesa di San Petronio e lasciò un suo amico fidato a guardia del Mulino. Questi vide più volte il Passatore aggirarsi nelle campagne circostanti e lo riferì al mugnaio. Saputo il fatto, questi si trasferì a Firenze e non fece più ritorno a Castel Bolognese.
Il Passatore, nato a Boncellino il 24 agosto 1824, fu ucciso in uno scontro a fuoco con i papalini il 23 marzo 1851. Il suo cadavere fu messo su un birroccio e portato in giro in tutta la Romagna, perchè tutti lo vedessero. A Castel Bolognese il carro sostò sulla via Emilia di fronte all’attuale sede della Banca di Romagna. Alla scena assistette Oliva Diversi, la nonna dello scrittore castellano Francesco Serantini, che del Passatore fu il più famoso storico (si veda a tal proposito il volume “Fatti memorabili della banda del Passatore in terra di Romagna”, pubblicato a Faenza nel 1929). Serantini evocò con documentata verità ma anche con paterna indulgenza, vita, imprese e morte di Stefano Pelloni, a lui legato per sempre e che quasi sicuramente aveva imparato a conoscere fin da bambino, grazie ai racconti di nonna Oliva.
Morto il Passatore, il resto della banda agiva diretta da Giuseppe Afflitti, detto Lazzarino. Il 10/10/1854 la banda del Lazzarino tentò un colpo a Castel Bolognese entrando nell’abitazione del possidente Francesco Gottarelli e appropriandosi di 423 scudi. Il garzone del Gottarelli, Giovanni Mingazzini, riuscì, inosservato, ad avvertire i gendarmi castellani i quali costrinsero la banda a fuggire. Nello scontro rimasero però feriti i gendarmi Giuseppe Stornini e Francesco Casadio, mentre il Gottarelli, rimasto pure gravemente ferito, morì pochi giorni dopo.
LA NOTTE IN CUI COTIGNOLA FU INVASA DALLA BANDA DEL PASSATORE
Non era nemmeno trascorso un anno dalla clamorosa invasione di Bagnara, che la conventicola di malviventi prese a progettare una seconda invasione, quella di Cotignola.
A tal fine, il Passatore andò raccogliendo informazioni da dritti e grattoni interessati all'affare, che presero sornioni a tener d'occhio il movimento della Forza e a raccogliere notizie tra caffè e nelle osterir, sollecitando il chiacchiericcio sulla costintenza patrimoniale dei maggiorenti del paese.
Si può forse pensare che nella scelta di quell'obiettivo agisse nel Passatore una sorta di ruggine antica, legata alle sofferenze patite negli inutili anni di scuola, fatti di costrizioni e di rinuncie, di beffe e di umiliazioni: nella sua muta paranoia egli poteva desiderare di veder giungere l'ora del pareggio dei conti, di mostrare chi era diventato Stuvane de Pasador.
Ma più ancora doveva agire una bruciante sete di vendetta verso Simone Benini, in forza alla gendarmeria di Cotignola, e verso Filippo Tamburini e Giuseppe Randi, due ex appartenenti alla Guardia Civica, che avevano partecipato all'uccisione di Pietro Tasselli, detto Pierone, suo amico d'infanzia e fratello dell'insepparabille Giazzolo. Pierone era caduto il 20/12/1847 in un agguato tesogli dalla Civica e da allora Giazzolo non aveva lasciato nulla di intentato per rinnovare nell'animo di Stuvane la torva necessità della vendetta.
Il Passatore e i suoi accoliti, raggiunta la certezza della buona riuscita del colpo, rassicurati dalla scarsa consistenza della Forza, passarono voce affinché il fior fiore della delinquenza locale si riunisse il 27/1/1850 nelle immediate vicinanze della cittadina stesa nella pianura, tra Lugo e Russi. Verso le sette di sera, quando le tenebre diacce già stringevano la campagna, fuguri intabarrati dai visi nascosti nell'ala di larghi cappellacci, avvolti nelle capparelle, andarono via via intruppandosi, giungendo da direzioni diverse al ponte che portava in paese. Il Passatore, con la sua voce fessa e stizzosa, tenne a mettere in chiaro che lui, oltre al bottino, era lì per regolare un vecchio conto: nessuno si azzardasse a mettergli i bastoni fra le ruote.
Divisi i compiti, la masnada puntò sul paese, che nelle tenebre fitte si indovinava appena al pallido baluginare di scarse luci. Faceva freddo e nel deserto delle strade il silenzio era rotto solo dall'abbaiare dei cani.
L'irsuta masnada penetro nel piccolo paese, sorvegliato da pochi gendarmi papalini, mal pagati e male armati, che spesso si ingaglioffavano nei locali pubblici aperti sulla piazza, in lunghe partite a tresette con i paesani. La tattica della banda nelle invasioni dei paesi seguiva uno schema che si sarebbe ripetuto con ben poche variazioni. Il primo obiettivo ero quello di rendere inoffensiva la Forza. Il commando inviato a tal fine ad occupare la caserma ebbe la ventura di imbattersi in due armigeri che bighellonavano del tutto ignari in un giro d'ispezione. I due arditi, alla vista di quei ceffi armati di schioppe micidiali e che all'aspetto non promettevano nulla di buono, si lasciarono disarmare senza opporre resistenza, mansueti come agnelli. Ammanettati con le loro stesse ferraglie e sbefeggiati, vennero trascinati sino alla caserma, al cui interno due gendarmi e un brigadiere male in arnese ammazzavano il tempo chiacchierando al lume della lanterna.
Lo scalpiccio all'ingresso desto la loro attenzione, ma i due gendarmi prigionieri, pungolati dai coltellacci alla schiena, dettero loro il segnale di riconoscimento, sollecitandoli ad aprire. La masnada armata poté così in tal modo irrompere all'interno, togliendo ai tre ogni velleità di resistenza.
Oramai al sicuro i militi nelle loro mani, si accese per un'attimo la gazzara del dileggio, nella quale i cinque sventurati sentivano esprimersi l'odio dei malandrini nei confronti della legge.
Le uniformi passarono dai cinque sulle spalle di altrettanti briganti, comprese le grandi lucerne di tela incerata sulla testa, tra motteggi e risate per la nudità dei gendarmi e la mascherata del travestimento. Altri si impadronirono delle armi, sfasciarono mobili e insegne papali, dispersero e bruciarono le carte odiose dell'archivio, sotto lo sguardo allucinato dei gendarmi, morti di freddo e di paura, che in quello stato furono costretti a seguire la masnada fino ai tre caffè della piazza.
La banda, divisa in tre gruppi, irruppe nei locali pubblici, raggelando gli avventori. Per controllare meglio la situazione, ingiunsero ad Agostino Spada di chiudere il suo locale e trasferirono tutti i presenti negli altri due esercizi, condotti da Pier Sante Spada e da Agostino Drei, dove stabilirono il loro centro operativo.
Vennero chiamati i possidenti, i bottegai, gli artigiani, nella spola dai caffè alle case, tirandosi dietro sia i rapinati che gli infreddoliti gendarmi a far da esca, affinché alla loro voce quelli di casa aprissero alla svelta, senza nulla sospettare.
La rapina, grazie alle divise che i banditi indossavano e alla perfetta conoscenza dei luoghi e delle persone, segno del buon lavoro svolto dagli informatori, procedette nel migliore dei modi: gli scudi, gli orologi, i preziosi si ammucchiavano sul tavolo di raccolta, crescendo ad ogni ritorno.
Il Passatore, nella memoria di quegli affronti patiti quando entrava in Cotignola sull'asina della madre, in quell'operoso trambusto menava gran spocchia del suo nome, affinché sapessero la grandezza del figlio del barcaiolo, spavaldo in mezzo ai tavoli con quella sua doppietta pronta a sgrillare, che per gli avventori era ininterrotta ragione d'angoscia: la quale raggiunse il suo punto rovente quando il Passatore sparò un colpo in aria che ammutoli i presenti. Nell'acre nuvola di zolfo la lama fredda della sua voce lanciò una domanda che non avrebbe sopportato il silenzio: Chi di voi ha ammazzato Pierone Giazzolo?
E poiché nessuno ebbe fiato di dare risposta, il malandrino mosse in cerchio lo sguardo indagatore, gli occhi brucianti nei bagliori di una fosca follia. Nessuno parla, eh! Avete paura ... ma io so chi sono gli assassini ... non è vero Giazzolo? Giazzolo annui con un ghigno feroce. Ecco là uno dei boia! ... Guardate come trema, il porco! Dico a te Simone Benini! Simone Benini, una delle guardie trascinate fin lì dalla caserma, semisvestito, si sentì venir meno, subito stretto da alcuni malandrini che gli si avvicinarono armati di coltelli, pronti a fendergli le carni. Simone Benini urlò di essere innocente; ma tutto sarebbe stato inutile, se improvvisamente il milite Guido Faccibene non si fosse frapposto, offrendosi coraggiosamente in cambio dell'amico, anziano e padre di famiglia. Quel gesto imprevisto disorientó il Passatore, che suo malgrado ammiró il coraggio dell'uomo. Va bene, disse il brigante, voglio essere generoso col civicotto, ma quei due bastardi ... là, non sfuggiranno al castigo che si meritano! e con gli occhi iniettati di sangue, indicò il Randi e il Tabanelli, anche loro nel gruppo, irrigiditi nel terrore.
Lasciando il paese sacheggiato, la banda trascino i due sventurati fino al ponte, dove il gruppo si fermò. Giazzolo si avventò sui due, menando micidiali coltellate, subito coadiuvato dal Passatore, in un alacre lavoro da macellai, che aprì rose di sangue. Non ancora soddisfatti, Stuvane e Giazol sollevarono i due che agonizzavano ai loro piedi in una pozza di sangue e li lasciarono precipitare nelle gelide acque del fiume Senio.
Placati infine nella loro sete di sangue, convinti oramai della morte dei due ex civici, in ordine sparso, si dileguarono nelle tenebre da cui erano giunti, per ritrovarsi per vie diverse, come convenuto, alla casa di Antonio Benedetti, detto Brighella, a Pieve Cesato, dove come al solito banchettarono e si divisero i frutti della rapina, che risultò di circa 4500 scudi.
Ne dimenticarono la congrua somma da assegnare per il disturbo alla famiglia del Brighella, che per quella sua ospitalità rischiava la vita e in effetti il favoreggiamento fu scoperto, portando il Brighella davanti al tremendo Giudizio Statario con buone probabilità di finire davanti a un plotone d'esecuzione; ma tra i lamenti e implorazioni l'uomo riuscì a convincere i giudici che aveva dovuto accogliere i banditi sotto minaccia di morte.
Quanto ai due accoltellati gettati nel fiume, essi dopo essere stati per quasi tutta la notte a lamentarsi nell'alveo, furono finalmente soccorsi da mani pietose che provvidero a curarli.
Il Randi, che era stato colpito da 18 coltellate, morì il giorno seguente, mentre il Tamburini, segnato per quattro volte dalla lama, pur dopo una lunga degenza finì col cavarsela.
Dopo la sanguinosa invasione di Cotignola, che impressionò fortemente tutto il territorio, moltiplicando le richieste di aiuto da parte delle popolazioni indifese e dei possidenti, sempre più spaventati, il capitano Michele Zambelli, trasferitosi a Lugo per essere più vicino alle zone esposte a rischi maggiori, dette un energico impulso alle indagini, tanto che interrogando i derubati, inseguendo indizi, sfruttando dicerie e confessioni, nel giro di pochi mesi fu in grado di inviare di fronte al Giudizio Statario molti di quelli stessi che avevano partecipato all'impresa.
GLI INVASORI DI COTIGNOLA:
- Stefano Pelloni (Stuvane de Pasador),
- Giuseppe Tasselli (il Giazzolo),
- Giuseppe Poli (il Pastore),
- Giacomo Bedeschi (il Maraffone),
- Costante Cristofani (il Filipetto),
- Francesco Cristofani (il Filipetto),
- Stefano Tampieri (l'Olivetto),
- Francesco Saporetti (il Rizzone),
- Antonio Benedetti (il Brighella),
- Giuseppe Golfieri (lo Scalzo),
- Andrea Pancini (il Coccone),
- Antonio Basili (il Basei),
- Tommaso Montini (il Teggione),
- Agostino Liverani (il Bartolino),
- Modesto Mingozzi (il Vallino),
- Michele Conti (il Carrera),
- Luigi Conti (il Carrera),
- Gaetano Morgagni (il Fagotto),
- Domenico Lolli (il Caraffa),
- Michele Melotti (lo Sventura),
- Giovanni Battista Mignani (il Pilastrino).
Il racconto è tratto da “Il Passatore. Le imprese brigantesche di Stefano Pelloni" (Editrice Il Ponte Vecchio, Cesena) di Remo Ragazzini, Roberto Casalini, Marzio Casalini e narra dell'invasione di Cotignola perpetrata dalla banda del Passatore la notte del 20/12/1847. Era un lunedì sera.
Cotignola
LA NOTTE IN CUI COTIGNOLA FU INVASA DALLA BANDA DEL PASSATORE
Non era nemmeno trascorso un anno dalla clamorosa invasione di Bagnara, che la conventicola di malviventi prese a progettare una seconda invasione, quella di Cotignola.
A tal fine, il Passatore andò raccogliendo informazioni da dritti e grattoni interessati all'affare, che presero sornioni a tener d'occhio il movimento della Forza e a raccogliere notizie tra caffè e nelle osterir, sollecitando il chiacchiericcio sulla costintenza patrimoniale dei maggiorenti del paese.
Si può forse pensare che nella scelta di quell'obiettivo agisse nel Passatore una sorta di ruggine antica, legata alle sofferenze patite negli inutili anni di scuola, fatti di costrizioni e di rinuncie, di beffe e di umiliazioni: nella sua muta paranoia egli poteva desiderare di veder giungere l'ora del pareggio dei conti, di mostrare chi era diventato Stuvane de Pasador.
Ma più ancora doveva agire una bruciante sete di vendetta verso Simone Benini, in forza alla gendarmeria di Cotignola, e verso Filippo Tamburini e Giuseppe Randi, due ex appartenenti alla Guardia Civica, che avevano partecipato all'uccisione di Pietro Tasselli, detto Pierone, suo amico d'infanzia e fratello dell'insepparabille Giazzolo. Pierone era caduto il 20/12/1847 in un agguato tesogli dalla Civica e da allora Giazzolo non aveva lasciato nulla di intentato per rinnovare nell'animo di Stuvane la torva necessità della vendetta.
Il Passatore e i suoi accoliti, raggiunta la certezza della buona riuscita del colpo, rassicurati dalla scarsa consistenza della Forza, passarono voce affinché il fior fiore della delinquenza locale si riunisse il 27/1/1850 nelle immediate vicinanze della cittadina stesa nella pianura, tra Lugo e Russi. Verso le sette di sera, quando le tenebre diacce già stringevano la campagna, fuguri intabarrati dai visi nascosti nell'ala di larghi cappellacci, avvolti nelle capparelle, andarono via via intruppandosi, giungendo da direzioni diverse al ponte che portava in paese. Il Passatore, con la sua voce fessa e stizzosa, tenne a mettere in chiaro che lui, oltre al bottino, era lì per regolare un vecchio conto: nessuno si azzardasse a mettergli i bastoni fra le ruote.
Divisi i compiti, la masnada puntò sul paese, che nelle tenebre fitte si indovinava appena al pallido baluginare di scarse luci. Faceva freddo e nel deserto delle strade il silenzio era rotto solo dall'abbaiare dei cani.
L'irsuta masnada penetro nel piccolo paese, sorvegliato da pochi gendarmi papalini, mal pagati e male armati, che spesso si ingaglioffavano nei locali pubblici aperti sulla piazza, in lunghe partite a tresette con i paesani. La tattica della banda nelle invasioni dei paesi seguiva uno schema che si sarebbe ripetuto con ben poche variazioni. Il primo obiettivo ero quello di rendere inoffensiva la Forza. Il commando inviato a tal fine ad occupare la caserma ebbe la ventura di imbattersi in due armigeri che bighellonavano del tutto ignari in un giro d'ispezione. I due arditi, alla vista di quei ceffi armati di schioppe micidiali e che all'aspetto non promettevano nulla di buono, si lasciarono disarmare senza opporre resistenza, mansueti come agnelli. Ammanettati con le loro stesse ferraglie e sbefeggiati, vennero trascinati sino alla caserma, al cui interno due gendarmi e un brigadiere male in arnese ammazzavano il tempo chiacchierando al lume della lanterna.
Lo scalpiccio all'ingresso desto la loro attenzione, ma i due gendarmi prigionieri, pungolati dai coltellacci alla schiena, dettero loro il segnale di riconoscimento, sollecitandoli ad aprire. La masnada armata poté così in tal modo irrompere all'interno, togliendo ai tre ogni velleità di resistenza.
Oramai al sicuro i militi nelle loro mani, si accese per un'attimo la gazzara del dileggio, nella quale i cinque sventurati sentivano esprimersi l'odio dei malandrini nei confronti della legge.
Le uniformi passarono dai cinque sulle spalle di altrettanti briganti, comprese le grandi lucerne di tela incerata sulla testa, tra motteggi e risate per la nudità dei gendarmi e la mascherata del travestimento. Altri si impadronirono delle armi, sfasciarono mobili e insegne papali, dispersero e bruciarono le carte odiose dell'archivio, sotto lo sguardo allucinato dei gendarmi, morti di freddo e di paura, che in quello stato furono costretti a seguire la masnada fino ai tre caffè della piazza.
La banda, divisa in tre gruppi, irruppe nei locali pubblici, raggelando gli avventori. Per controllare meglio la situazione, ingiunsero ad Agostino Spada di chiudere il suo locale e trasferirono tutti i presenti negli altri due esercizi, condotti da Pier Sante Spada e da Agostino Drei, dove stabilirono il loro centro operativo.
Vennero chiamati i possidenti, i bottegai, gli artigiani, nella spola dai caffè alle case, tirandosi dietro sia i rapinati che gli infreddoliti gendarmi a far da esca, affinché alla loro voce quelli di casa aprissero alla svelta, senza nulla sospettare.
La rapina, grazie alle divise che i banditi indossavano e alla perfetta conoscenza dei luoghi e delle persone, segno del buon lavoro svolto dagli informatori, procedette nel migliore dei modi: gli scudi, gli orologi, i preziosi si ammucchiavano sul tavolo di raccolta, crescendo ad ogni ritorno.
Il Passatore, nella memoria di quegli affronti patiti quando entrava in Cotignola sull'asina della madre, in quell'operoso trambusto menava gran spocchia del suo nome, affinché sapessero la grandezza del figlio del barcaiolo, spavaldo in mezzo ai tavoli con quella sua doppietta pronta a sgrillare, che per gli avventori era ininterrotta ragione d'angoscia: la quale raggiunse il suo punto rovente quando il Passatore sparò un colpo in aria che ammutoli i presenti. Nell'acre nuvola di zolfo la lama fredda della sua voce lanciò una domanda che non avrebbe sopportato il silenzio: Chi di voi ha ammazzato Pierone Giazzolo?
E poiché nessuno ebbe fiato di dare risposta, il malandrino mosse in cerchio lo sguardo indagatore, gli occhi brucianti nei bagliori di una fosca follia. Nessuno parla, eh! Avete paura ... ma io so chi sono gli assassini ... non è vero Giazzolo? Giazzolo annui con un ghigno feroce. Ecco là uno dei boia! ... Guardate come trema, il porco! Dico a te Simone Benini! Simone Benini, una delle guardie trascinate fin lì dalla caserma, semisvestito, si sentì venir meno, subito stretto da alcuni malandrini che gli si avvicinarono armati di coltelli, pronti a fendergli le carni. Simone Benini urlò di essere innocente; ma tutto sarebbe stato inutile, se improvvisamente il milite Guido Faccibene non si fosse frapposto, offrendosi coraggiosamente in cambio dell'amico, anziano e padre di famiglia. Quel gesto imprevisto disorientó il Passatore, che suo malgrado ammiró il coraggio dell'uomo. Va bene, disse il brigante, voglio essere generoso col civicotto, ma quei due bastardi ... là, non sfuggiranno al castigo che si meritano! e con gli occhi iniettati di sangue, indicò il Randi e il Tabanelli, anche loro nel gruppo, irrigiditi nel terrore.
Lasciando il paese sacheggiato, la banda trascino i due sventurati fino al ponte, dove il gruppo si fermò. Giazzolo si avventò sui due, menando micidiali coltellate, subito coadiuvato dal Passatore, in un alacre lavoro da macellai, che aprì rose di sangue. Non ancora soddisfatti, Stuvane e Giazol sollevarono i due che agonizzavano ai loro piedi in una pozza di sangue e li lasciarono precipitare nelle gelide acque del fiume Senio.
Placati infine nella loro sete di sangue, convinti oramai della morte dei due ex civici, in ordine sparso, si dileguarono nelle tenebre da cui erano giunti, per ritrovarsi per vie diverse, come convenuto, alla casa di Antonio Benedetti, detto Brighella, a Pieve Cesato, dove come al solito banchettarono e si divisero i frutti della rapina, che risultò di circa 4500 scudi.
Ne dimenticarono la congrua somma da assegnare per il disturbo alla famiglia del Brighella, che per quella sua ospitalità rischiava la vita e in effetti il favoreggiamento fu scoperto, portando il Brighella davanti al tremendo Giudizio Statario con buone probabilità di finire davanti a un plotone d'esecuzione; ma tra i lamenti e implorazioni l'uomo riuscì a convincere i giudici che aveva dovuto accogliere i banditi sotto minaccia di morte.
Quanto ai due accoltellati gettati nel fiume, essi dopo essere stati per quasi tutta la notte a lamentarsi nell'alveo, furono finalmente soccorsi da mani pietose che provvidero a curarli.
Il Randi, che era stato colpito da 18 coltellate, morì il giorno seguente, mentre il Tamburini, segnato per quattro volte dalla lama, pur dopo una lunga degenza finì col cavarsela.
Dopo la sanguinosa invasione di Cotignola, che impressionò fortemente tutto il territorio, moltiplicando le richieste di aiuto da parte delle popolazioni indifese e dei possidenti, sempre più spaventati, il capitano Michele Zambelli, trasferitosi a Lugo per essere più vicino alle zone esposte a rischi maggiori, dette un energico impulso alle indagini, tanto che interrogando i derubati, inseguendo indizi, sfruttando dicerie e confessioni, nel giro di pochi mesi fu in grado di inviare di fronte al Giudizio Statario molti di quelli stessi che avevano partecipato all'impresa.
GLI INVASORI DI COTIGNOLA:
- Stefano Pelloni (Stuvane de Pasador),
- Giuseppe Tasselli (il Giazzolo),
- Giuseppe Poli (il Pastore),
- Giacomo Bedeschi (il Maraffone),
- Costante Cristofani (il Filipetto),
- Francesco Cristofani (il Filipetto),
- Stefano Tampieri (l'Olivetto),
- Francesco Saporetti (il Rizzone),
- Antonio Benedetti (il Brighella),
- Giuseppe Golfieri (lo Scalzo),
- Andrea Pancini (il Coccone),
- Antonio Basili (il Basei),
- Tommaso Montini (il Teggione),
- Agostino Liverani (il Bartolino),
- Modesto Mingozzi (il Vallino),
- Michele Conti (il Carrera),
- Luigi Conti (il Carrera),
- Gaetano Morgagni (il Fagotto),
- Domenico Lolli (il Caraffa),
- Michele Melotti (lo Sventura),
- Giovanni Battista Mignani (il Pilastrino).
Il racconto è tratto da “Il Passatore. Le imprese brigantesche di Stefano Pelloni" (Editrice Il Ponte Vecchio, Cesena) di Remo Ragazzini, Roberto Casalini, Marzio Casalini e narra dell'invasione di Cotignola perpetrata dalla banda del Passatore la notte del 20/12/1847. Era un lunedì sera.
22 aprile 1851.
In un grotta al Belvedere, oggi Villa Bianchi, sopra Ponte Abbadesse, la gendarmeria pontificia catturava, grazie a una soffiata, un brigante cesenate della banda del Passatore: Giacomo Cantoni, detto Corneli (o anche Miseria). Sulla sua testa una ghiotta taglia: 100 scudi.
Sulla base della scheda segnaletica e del mandato di cattura di quel tempo, abbiamo chiesto all’illustratore concittadino Vittorio Belli una sorta di identikit al modo del tempo.
Questa la scheda del nostro brigante, poi fucilato a Bologna. Giacomo Cantoni, del fu Vincenzo, 30 anni, abitante in parrocchia San Pietro di Cesena, ammogliato con prole, di professione salcino (selciatore di strade). Già condannato per ferimento a tre anni di lavori forzati. Porta cappello a larga tesa, fucile a un colpo, due pistole.
Più dettagliato il bando di cattura, con premio, emanato dal legato pontificio monsignor Bedini l’11/3/1851 che descrive i connotati di 18 briganti (il fior fiore della ribalderia e dell’audacia, Passatore in testa) ancora uccel di bosco. Giacomo Cantoni, statura ordinaria, capelli, occhi e barba castagni (castani), fronte spaziosa, naso profilato, mento ovale, viso lungo, segni particolari (cicatrici, ecc.): nessuno.
A inchiodare Cantoni furono le confessioni di tre briganti catturati, che in cambio della vita e sconti di pena, avevano cantato come canarini permettendo alla gendarmeria del capitano Zambelli di smantellare l’ampia rete di covi, complici, manutengoli che proteggeva i banditi. Proprio nella casa cesenate, fuori dalle mura, di Cantoni, i briganti s’erano spartiti in parti uguali il ricco bottino (2000 scudi) dopo lo spettacolare assalto alla diligenza sulla via Emilia sotto Longiano il 22/9/1850.
In quella circostanza i briganti, giunti alla spicciolata per non dare nell’occhio, avevano trovato ospitalità lautamente ricompensata presso i coloni Barducci, detti Mezzabotta. Da loro i malviventi comprarono strapagandolo un coltro, cioè la lama dell’aratro, per scassinare la cassetta dei valori. A tirar le fila fu un birbante delle colline cesenati: Giovanni Drudi, detto Bastianello, 28 anni, contadino in Saiano, tra i più attivi anche nell’invasione brigantesca di Longiano del 28/5/1850 (Bastianello fu arrestato il 27/1/1851: ma non parlò).
Bastianello e Giacomo Cantoni, processati e condannati, furono fucilati a Bologna, Prati di Caprara, il 14/5/1851.
Stessa sorte, ma il 14 ottobre di quell’anno, per Giovanni e Giacomo Barducci, padre e figlio, di Montilgallo: prima della fatale ospitalità ai briganti erano incensurati.
Furono tutti seppelliti, insieme a numerosi compari, fuori dalla Certosa di Bologna nel campo dei Traditori.
Adesso che quasi tutti i briganti erano sottoterra poteva cominciare a fiorire la leggenda del Passator cortese.
42 yerel halk öneriyor
Cesena
22 aprile 1851.
In un grotta al Belvedere, oggi Villa Bianchi, sopra Ponte Abbadesse, la gendarmeria pontificia catturava, grazie a una soffiata, un brigante cesenate della banda del Passatore: Giacomo Cantoni, detto Corneli (o anche Miseria). Sulla sua testa una ghiotta taglia: 100 scudi.
Sulla base della scheda segnaletica e del mandato di cattura di quel tempo, abbiamo chiesto all’illustratore concittadino Vittorio Belli una sorta di identikit al modo del tempo.
Questa la scheda del nostro brigante, poi fucilato a Bologna. Giacomo Cantoni, del fu Vincenzo, 30 anni, abitante in parrocchia San Pietro di Cesena, ammogliato con prole, di professione salcino (selciatore di strade). Già condannato per ferimento a tre anni di lavori forzati. Porta cappello a larga tesa, fucile a un colpo, due pistole.
Più dettagliato il bando di cattura, con premio, emanato dal legato pontificio monsignor Bedini l’11/3/1851 che descrive i connotati di 18 briganti (il fior fiore della ribalderia e dell’audacia, Passatore in testa) ancora uccel di bosco. Giacomo Cantoni, statura ordinaria, capelli, occhi e barba castagni (castani), fronte spaziosa, naso profilato, mento ovale, viso lungo, segni particolari (cicatrici, ecc.): nessuno.
A inchiodare Cantoni furono le confessioni di tre briganti catturati, che in cambio della vita e sconti di pena, avevano cantato come canarini permettendo alla gendarmeria del capitano Zambelli di smantellare l’ampia rete di covi, complici, manutengoli che proteggeva i banditi. Proprio nella casa cesenate, fuori dalle mura, di Cantoni, i briganti s’erano spartiti in parti uguali il ricco bottino (2000 scudi) dopo lo spettacolare assalto alla diligenza sulla via Emilia sotto Longiano il 22/9/1850.
In quella circostanza i briganti, giunti alla spicciolata per non dare nell’occhio, avevano trovato ospitalità lautamente ricompensata presso i coloni Barducci, detti Mezzabotta. Da loro i malviventi comprarono strapagandolo un coltro, cioè la lama dell’aratro, per scassinare la cassetta dei valori. A tirar le fila fu un birbante delle colline cesenati: Giovanni Drudi, detto Bastianello, 28 anni, contadino in Saiano, tra i più attivi anche nell’invasione brigantesca di Longiano del 28/5/1850 (Bastianello fu arrestato il 27/1/1851: ma non parlò).
Bastianello e Giacomo Cantoni, processati e condannati, furono fucilati a Bologna, Prati di Caprara, il 14/5/1851.
Stessa sorte, ma il 14 ottobre di quell’anno, per Giovanni e Giacomo Barducci, padre e figlio, di Montilgallo: prima della fatale ospitalità ai briganti erano incensurati.
Furono tutti seppelliti, insieme a numerosi compari, fuori dalla Certosa di Bologna nel campo dei Traditori.
Adesso che quasi tutti i briganti erano sottoterra poteva cominciare a fiorire la leggenda del Passator cortese.
In secoli più recenti, molte rocche e fortezze medioevali, avendo ormai perduto le funzioni difensive, vennero adibite totalmente o parzialmente in carceri. Non fa eccezione la Rocca di Lugo che nei secoli fu sede e centro dell'autorità politica territoriale che governava la Romandiola (commissari e governatori inviati prima dagli Estensi, poi dai legati Pontifici di Ferrara) e ospitò funzioni giudiziarie e militari oltreché amministrative … e anche alcuni componenti della banda del Passatore, tra cui Antonio Farina detto Dumandone, che per aver salva la vita fece il nome dei complici.
Quasi tutti i castelli e rocche medioevali nati con funzioni militari e amministrative avevano qualche vano, più o meno comodo e più o meno umido e freddo, destinato a prigione. In secoli più recenti, avendo ormai perduto le funzioni difensive, vennero adibite totalmente o parzialmente in carceri. Non fa eccezione la Rocca di Lugo che nei secoli fu sede e centro dell'autorità politica territoriale che governava la Romandiola (commissari e governatori inviati prima dagli Estensi, poi dai legati Pontifici di Ferrara) e ospitò funzioni giudiziarie e militari oltreché amministrative.
Possiamo affermare che ancora nella seconda metà dell’800, circa 1/4 dei suoi vani erano destinati a prigioni e alle relative attività (oltre alle celle vi erano due parlatoi e il cortile per i prigionieri, la cucina carceraria, 2 sale per i due corpi di guardia carceraria e relativo dormitorio, l’ufficio del direttore delle carceri, i magazzini per il servizio carceri, compreso quello dei corpi di reato ecc).
Dai disegni del 21/11/1845, conservati a Roma in Archivio di Stato, Pianta delle Carceri di Lugo, risulta una capienza complessiva nella Rocca di Lugo di ben 113 prigionieri; a quella data, ne erano custoditi 30.
L'ubicazione delle prigioni è variata nel tempo, considerate anche le complesse vicissitudini e incessanti trasformazioni edilizie e architettoniche subite dalla Rocca (guerre, assedi, incendi, variare degli usi e scopi degli spazi interni a seconda delle necessità sopravvenute ecc), ma in generale possiamo affermare che i due torrioni principali, quello circolare di nord/ovest e quello quadrato di sud/est ospitarono per secoli le carceri, probabilmente fin dal ‘600 (come si evince da un disegno ottocentesco copia di originale perduto).
A questi 2 corpi si aggiunsero poi le celle poste a lato del giardino pensile visibili ancor oggi e che rappresentano uno tra gli scorci più suggestivi della Rocca, nonostante la loro sinistra destinazione.
Nel torrione circolare di nord ovest, detto erroneamente di Uguccione, si partiva dalla prigione posta al livello del giardino (in gergo “la Galeotta”, che nel 1845 risultava “inservibile per ordine dell’Em.mo Sig. Cardinal Legato”), per salire fino all’ultimo piano sotto il tetto (presente fino ai primi anni del ‘900), che nel 1871 conteneva la prigione militare e anche quella femminile, in precedenza ubicata sopra la volta di ingresso alla Rocca.
Spostandoci a visitare i vani all'ultimo piano della Torre di sud/est, di fianco all'ingresso principale, per diversi anni adibiti ad archivio, risulta ancor oggi evidente ai nostri occhi – al di là della documentazione storica - come in passato essi fossero utilizzati come prigioni, considerando le strutture interne e in particolare porte e finestre particolarmente rinforzati con robuste grate e catenacci; ma anche i vani sottostanti, compreso il salone che ospitò dal 1926 agli anni Ottanta il Museo Baracca in precedenza erano adibiti a carceri.
Rocca Estense
Piazza Francesco BaraccaIn secoli più recenti, molte rocche e fortezze medioevali, avendo ormai perduto le funzioni difensive, vennero adibite totalmente o parzialmente in carceri. Non fa eccezione la Rocca di Lugo che nei secoli fu sede e centro dell'autorità politica territoriale che governava la Romandiola (commissari e governatori inviati prima dagli Estensi, poi dai legati Pontifici di Ferrara) e ospitò funzioni giudiziarie e militari oltreché amministrative … e anche alcuni componenti della banda del Passatore, tra cui Antonio Farina detto Dumandone, che per aver salva la vita fece il nome dei complici.
Quasi tutti i castelli e rocche medioevali nati con funzioni militari e amministrative avevano qualche vano, più o meno comodo e più o meno umido e freddo, destinato a prigione. In secoli più recenti, avendo ormai perduto le funzioni difensive, vennero adibite totalmente o parzialmente in carceri. Non fa eccezione la Rocca di Lugo che nei secoli fu sede e centro dell'autorità politica territoriale che governava la Romandiola (commissari e governatori inviati prima dagli Estensi, poi dai legati Pontifici di Ferrara) e ospitò funzioni giudiziarie e militari oltreché amministrative.
Possiamo affermare che ancora nella seconda metà dell’800, circa 1/4 dei suoi vani erano destinati a prigioni e alle relative attività (oltre alle celle vi erano due parlatoi e il cortile per i prigionieri, la cucina carceraria, 2 sale per i due corpi di guardia carceraria e relativo dormitorio, l’ufficio del direttore delle carceri, i magazzini per il servizio carceri, compreso quello dei corpi di reato ecc).
Dai disegni del 21/11/1845, conservati a Roma in Archivio di Stato, Pianta delle Carceri di Lugo, risulta una capienza complessiva nella Rocca di Lugo di ben 113 prigionieri; a quella data, ne erano custoditi 30.
L'ubicazione delle prigioni è variata nel tempo, considerate anche le complesse vicissitudini e incessanti trasformazioni edilizie e architettoniche subite dalla Rocca (guerre, assedi, incendi, variare degli usi e scopi degli spazi interni a seconda delle necessità sopravvenute ecc), ma in generale possiamo affermare che i due torrioni principali, quello circolare di nord/ovest e quello quadrato di sud/est ospitarono per secoli le carceri, probabilmente fin dal ‘600 (come si evince da un disegno ottocentesco copia di originale perduto).
A questi 2 corpi si aggiunsero poi le celle poste a lato del giardino pensile visibili ancor oggi e che rappresentano uno tra gli scorci più suggestivi della Rocca, nonostante la loro sinistra destinazione.
Nel torrione circolare di nord ovest, detto erroneamente di Uguccione, si partiva dalla prigione posta al livello del giardino (in gergo “la Galeotta”, che nel 1845 risultava “inservibile per ordine dell’Em.mo Sig. Cardinal Legato”), per salire fino all’ultimo piano sotto il tetto (presente fino ai primi anni del ‘900), che nel 1871 conteneva la prigione militare e anche quella femminile, in precedenza ubicata sopra la volta di ingresso alla Rocca.
Spostandoci a visitare i vani all'ultimo piano della Torre di sud/est, di fianco all'ingresso principale, per diversi anni adibiti ad archivio, risulta ancor oggi evidente ai nostri occhi – al di là della documentazione storica - come in passato essi fossero utilizzati come prigioni, considerando le strutture interne e in particolare porte e finestre particolarmente rinforzati con robuste grate e catenacci; ma anche i vani sottostanti, compreso il salone che ospitò dal 1926 agli anni Ottanta il Museo Baracca in precedenza erano adibiti a carceri.
Il Passatore
di Andrea Trentini
Romagna – Giovanni Pascoli
Romagna solatia, dolce paese
cui regnarono Guidi e Malatesta;
cui tenne pure il Passator cortese,
re della strada e re della foresta.
Era una notte buia e tempestosa. Anzi, quella volta lì doveva esserci il sole quando, mentre Stefano aiutava controvoglia il padre nel mestiere del passatore, all’imbarco del traghetto si presentò un bandito. Che era un bandito lo si capiva subito: era alto e massiccio, portava degli orecchini d’oro e il suo volto era adornato da degli splendidi mustacchi. Stuvané lo aveva visto bene, lo divorava con gli occhi e aveva addirittura scambiato con lui alcune battute di scherno sui papalini. Ecco uno che non piega la schiena, uno che va all’avventura invece che starsene nei campi! Avrà probabilmente pensato.
E in effetti, Stefano Pelloni detto Melandri, amorevolmente chiamato da famigliari e amici col diminutivo Stuvané, un bandito lo era diventato. E che razza di bandito, furbo, spietato, sanguinario. Fra i tanti che in quel periodo storico, siamo fra il 1840 e il 1850, infestavano la Romagna, solo i suoi delitti sono diventati gesta, la sua storia una leggenda. E c’erano state le notti buie quando si accingeva a perpetrare i suoi delitti e anche tempestose, quantomeno in senso metaforico, quando era braccato da tre eserciti contemporaneamente.
Fin da bambino si era capito che il potere costituito non avrebbe fatto parte del suo essere. La famiglia, nel vano tentativo di dargli un’istruzione, lo aveva iscritto a una scuola privata, ma a nulla era giovata la sferza che il maestro era uso calargli sulle dita con fine pedagogico. Le mani doloranti sfogliavano il libro, ma la fantasia correva lontana cercando i campi e le strade oltre la cornice della finestra. Dopo tre anni di scuola ne era uscito con il titolo di analfabeta. Già a quindici anni fece il suo debutto ufficiale in un’aula di tribunale per una sassata alla figlia di un vicino di casa finita senza conseguenze. Poi era stato accusato di concorso in rapina con assassinio e di essere il mandante dell’omicidio di un testimone. Per affinare il suo apprendistato aveva fatto parte della banda del Taglione, che mandava i suoi accoliti di notte a taglieggiare i contadini e i proprietari terrieri con la minaccia di un lutto in famiglia oltre all’incendio dei loro fienili. Di lì, la prigione, le evasioni, le catture e la definitiva latitanza.
Le cause – o le scusanti per i suoi ammiratori – che avevano indotto Stefano Pelloni a intraprendere la carriera del fuorilegge si possono ricercare nella situazione politica ed economica di quel periodo. Quelli furono certamente anni neri per la Romagna e per i suoi abitanti. Il Congresso di Vienna aveva annesso l’intero territorio romagnolo allo Stato Pontificio. Nel giro di quindici anni, ai contadini era stato tolto tutto, fuorché il lavoro. Persino i trebbi, le feste rurali legate al ciclo del raccolto, erano stati proibiti, in quanto sinonimo di scarsa rettitudine. Restava una popolazione povera e infelice, orfana di pane e di svaghi, costretta da una parte a seguire alla lettera le imposizioni dei possidenti e dall’altra le prescrizioni del clero intransigente e bigotto.
Il Boncellino, paese natale di Stefano Pelloni, si trovava in una condizione giuridica particolarmente sfavorevole. Quella piccola frazione di Bagnacavallo, un borgo rustico popolato da un migliaio di braccianti, la maggior parte dei quali alloggiata in capanne di giunchi lungo l’argine del fiume Lamone, era infatti il punto di intersezione di un numero spropositato di giurisdizioni. Il potere era spartito fra le legazioni di Ferrara e Ravenna, i governatorati di Lugo, Bagnacavallo, Russi e Faenza, cui si aggiungevano i comuni di Cotignola e Russi. Inoltre sul territorio erano presenti un discreto numero di presidi militari austriaci che reggevano e controllavano il vicino Granducato di Toscana. A conti fatti gli abitanti del Boncellino si trovavano in una spiacevole condizione di inferiorità numerica rispetto alla quantità di persone che a vario titolo potevano comandarli. E allora si può comprendere come in alcuni di loro, specie tra i giovani, non ancora educati alla rassegnazione, la scorciatoia della malavita apparisse l’unica via per dichiarare il diritto alla vita.
La famiglia Pelloni, della quale Stuvané era il più giovane di dieci figli, non era tra quelle che se la passavano peggio. La sopravvivenza era garantita dal loro piccolo podere sulla riva sinistra del Lamone che possedevano da generazioni. A rimpinguare le entrate ci pensava papà Girolamo affiancando all’attività di coltivatore quella di falegname e soprattutto quella di custode degli argini del Lamone. Faceva anche il traghettatore o, come si diceva a quel tempo, il passatore. Quel titolo sarebbe poi passato a designare suo figlio, che in realtà non diede che occasionalmente il suo contributo come barcaiolo. Ma a Stuvané tutto questo non bastava, oltre all’avventura fine a se stessa le sue passioni erano il vino, il gioco e le donne. Tutto questo in una parola significava soldi.
Il suo passatempo preferito era il gioco della bassetta, un passatempo infido e costoso. Molti contadini avevano dilapidato le loro esigue fortune puntando sulle carte traditrici, tanto che persino il governo si era occupato di quella rovinosa abitudine promulgando pene molto severe. Per quanto riguarda le compagnie femminili, il nostro eroe non andava molto per il sottile, fra le tante si ricorda la sua relazione con la procace Marianna Marangoni, donna sposata di parecchi anni più vecchia di lui, per tutti la Rivalona, in onore alla sua abitudine di concedersi al fortunato di turno sulla riva del Lamone. Purtroppo, o per fortuna, queste frequentazioni gli procurarono una fastidiosissima sifilide che tra evasioni e rapine non ebbe mai modo di curare a dovere e che lo tormentò tutta la vita obbligandolo anche a frequenti periodi di inattività.
Il 28 giugno 1845 il Tribunale di Ferrara condanna il Pelloni a quattro anni di lavori forzati e, mentre viene tradotto ad Ancona per scontare la pena, riesce a sfuggire dalla sorveglianza dei gendarmi dandosi definitivamente alla macchia. Purtroppo per il padre Girolamo, che morì nel 1845 proprio mentre Stefano si guadagnava i gradi di brigante professionista, tutte la sue speranze di riportarlo sulla via della legalità si rivelarono vane.
Fu comunque nel 1874 che molti in Romagna appresero dell’esistenza di un nuovo capo bandito, soprannominato E’ Pasador. Una nota informativa di un parroco della zona di Brisighella segna l’atto di nascita della banda del Passatore: Appresi oggi 4 gennaio 1847 dai Coloni Sussidiari che nei boschi di Zattaglia si è attruppata nuova banda di assassini condotti da un capo che va dicendo a coloro che incontra e rapina di essere evaso dalle carceri pontificie e che si fa chiamare Stuvanì de Passador. A differenza degli altri, Stefano Pelloni aveva l’ardire di firmare le sue malefatte, anche perché sarebbe comunque stato facilmente identificabile a causa di una fucilata ricevuta in faccia in età giovanile che gli aveva lasciato sullo zigomo destro una grossa macchia azzurrognola dovuta ad alcuni grani di polvere da sparo conficcatisi sotto pelle.
Le attività del Passatore andavano dalla semplice rapina ai viandanti alle più complesse e redditizie rapine alle case di ricchi possidenti, vendette su commissione, fino ad arrivare a occupare interi paesi.
L’invasione di Forlimpopoli, per com’è stata orchestrata, rappresenta la sua impresa più celebre. Quella sera, al teatro cittadino, quando si aprì il sipario per dare inizio al secondo atto dello spettacolo, il folto pubblico, che comprendeva una nutrita schiera di ricchi possidenti, al posto degli attori si trovò la banda del Passatore con i fucili spianati. Per tutta la notte i signori presenti furono scortati alle loro abitazioni e depredati dei loro averi. Chi non era andato a teatro venne svegliato e gli fu riservato lo stesso trattamento. Mentre la banda depredava, il Passatore si sollazzava fra osterie e postriboli. Finita la razzia i banditi conclusero la serata con abbondanti libagioni e lunghi giri di danze con le dame più belle. Prima di andarsene elargirono una mancia al capocomico scusandosi per avergli rubato la scena.
La banda del Passatore, come le tante altre che infestavano la Romagna, potette godere di una certa libertà d’azione nel periodo che coincise con i primi moti rivoluzionari. Nel 1848, la sollevazione di varie di varie città fra cui Milano, Venezia e Bologna, la Repubblica Romana e la Prima guerra d’Indipendenza videro gli austriaci costretti ad impegnare le loro forze per riconquistare i territori perduti. Questa situazione favorevole, accompagnata da una fitta rete di fiancheggiatori e di rifugi organizzati, consentiva ai banditi di razziare il territorio praticamente indisturbati. La mancanza di informazioni e lo sbandamento generale consentiva ai briganti anche la possibilità di confondersi con i rivoluzionari. Da non sottovalutare l’armamento in gran parte costituito da moderne doppiette di costruzione francese, che venivano reperite nel vicino Granducato di Toscana, con cui i vecchi catenacci delle guardie pontificie non potevano competere. Tristemente famoso era un fucile quadricanne in dotazione alla banda, arma rivelatasi pesante e poco maneggevole ma che doveva incutere spavento e rassegnazione da parte di chi era sotto tiro. I calessi, che allora erano i mezzi più veloci e versatili, li requisivano direttamente alle loro vittime.
Ripristinata la situazione politica, la lotta alla piaga del banditismo si fece spietata. Fu ingaggiato il colonnello pontificio Michele Zambelli con l’incarico di uccidere il Passatore. Gli furono affidati i migliori soldati disponibili e completa libertà di movimento. Fu istituito il Giudizio Statuario, un vero e proprio tribunale militare creato per piegare definitavene le velleità di sediziosi e briganti.
Il rischio della fucilazione immediata per i briganti e i loro complici, a qualunque titolo, salvo un immediato pentimento e la disponibilità a collaborare, fecero terra bruciata intorno al Passatore. La mattina del 23 marzo 1851 fu denunciata la sua presenza in un capanno sulle rive del Lamone nei dintorni del Boncellino. Vi si era rifugiato insieme con un compagno di avventura per passarvi la notte. Cinque militari della Linea Pontificia e quattro volontari accorsero sul posto e, dopo una breve sparatoria, Stefano Pelloni, il Passatore, cadeva morto con la faccia nell’erba.
Ci furono polemiche per aggiudicarsi il merito dell’uccisione per intascare la cospicua taglia. Intanto il corpo del Passatore, caricato su un carretto, fu trasportato ed esposto nelle città e paesi teatro delle sue gesta. Due giorni dopo raggiunse Bologna già in avanzato stato di decomposizione dove, dopo un sommario quanto dubbioso riconoscimento da parte di un suo fratello, venne sepolto nel cimitero della Certosa di Bologna, in un recinto, all’esterno della zona consacrata, detto il campo dei traditori.
La leggenda del Passatore aveva già cominciato a prendere corpo quando lui era ancora in piena attività. Durante le soste del corteo funebre, accanto ai possidenti plaudenti per l’uccisione del mostro, la stragrande maggioranza del pubblico era composta da braccianti e donne in lacrime. La sua temerarietà, e la capacità di tenere testa alle autorità gli avevano fatto assumere il ruolo di simbolo di riscossa e di speranza per tutto un popolo. Giovanni Pascoli nella sua poesia, Romagna, lo definisce il Passator cortese. La leggenda vuole che rubasse ai ricchi per donare ai poveri. Di certo il danaro ricavato dalle rapine veniva generosamente regalato a tutti coloro dai quali poteva trarre giovamento; quindi case aperte ad asilo, vettovaglie, aiuti e favori pronti e sicuri, avvisi fedeli e così via. Lo stesso Garibaldi ha aiutato ingenuamente a creare il mito proponendosi, in una lettera dall’America, di baciare il piede di quel bravo italiano.
Di cortese, nelle fucilate e nella violenza con cui si accaniva sulle sue vittime, ci dovette essere ben poco. Il professor Leonida Costa, nel suo libro Il rovescio della medaglia, utilizzando i verbali ufficiali relativi alla vicenda di Stefano Pelloni, ha cercato di rimettere un po’ di ordine nella vicenda dimostrando, documenti alla mano, che il Passatore amato e stimato dal popolo non è mai esistito. La storia indica un solo inequivocabile Passatore: quello che si distinse nelle rapine, nelle atroci vendette, nelle torture, negli stupri, nei brutali assassinî, nel vilipendio dei cadaveri.
Ma il tempo sana tutte le ferite. Oggi le iniziative intitolate al Passatore si contano a decine, vanno dalla podistica all’enologia, dalla gastronomia al turismo, dai tornei di scacchi ai francobolli, alle canzoni e via dicendo.
E poi diciamocelo sinceramente, quando troviamo qualcuno capace di farsi rispettare, inconsciamente ci viene in mente qualche nostro conoscente cui una ripassatina farebbe proprio bene. Per fortuna, in genere, l’educazione, la morale o anche solo la diplomazia o il rischio di buscarle ci fa desistere, ed evocare chi potrebbe averlo fatto può essere fonte di pur fuggevole consolazione.
Boncellino
Il Passatore
di Andrea Trentini
Romagna – Giovanni Pascoli
Romagna solatia, dolce paese
cui regnarono Guidi e Malatesta;
cui tenne pure il Passator cortese,
re della strada e re della foresta.
Era una notte buia e tempestosa. Anzi, quella volta lì doveva esserci il sole quando, mentre Stefano aiutava controvoglia il padre nel mestiere del passatore, all’imbarco del traghetto si presentò un bandito. Che era un bandito lo si capiva subito: era alto e massiccio, portava degli orecchini d’oro e il suo volto era adornato da degli splendidi mustacchi. Stuvané lo aveva visto bene, lo divorava con gli occhi e aveva addirittura scambiato con lui alcune battute di scherno sui papalini. Ecco uno che non piega la schiena, uno che va all’avventura invece che starsene nei campi! Avrà probabilmente pensato.
E in effetti, Stefano Pelloni detto Melandri, amorevolmente chiamato da famigliari e amici col diminutivo Stuvané, un bandito lo era diventato. E che razza di bandito, furbo, spietato, sanguinario. Fra i tanti che in quel periodo storico, siamo fra il 1840 e il 1850, infestavano la Romagna, solo i suoi delitti sono diventati gesta, la sua storia una leggenda. E c’erano state le notti buie quando si accingeva a perpetrare i suoi delitti e anche tempestose, quantomeno in senso metaforico, quando era braccato da tre eserciti contemporaneamente.
Fin da bambino si era capito che il potere costituito non avrebbe fatto parte del suo essere. La famiglia, nel vano tentativo di dargli un’istruzione, lo aveva iscritto a una scuola privata, ma a nulla era giovata la sferza che il maestro era uso calargli sulle dita con fine pedagogico. Le mani doloranti sfogliavano il libro, ma la fantasia correva lontana cercando i campi e le strade oltre la cornice della finestra. Dopo tre anni di scuola ne era uscito con il titolo di analfabeta. Già a quindici anni fece il suo debutto ufficiale in un’aula di tribunale per una sassata alla figlia di un vicino di casa finita senza conseguenze. Poi era stato accusato di concorso in rapina con assassinio e di essere il mandante dell’omicidio di un testimone. Per affinare il suo apprendistato aveva fatto parte della banda del Taglione, che mandava i suoi accoliti di notte a taglieggiare i contadini e i proprietari terrieri con la minaccia di un lutto in famiglia oltre all’incendio dei loro fienili. Di lì, la prigione, le evasioni, le catture e la definitiva latitanza.
Le cause – o le scusanti per i suoi ammiratori – che avevano indotto Stefano Pelloni a intraprendere la carriera del fuorilegge si possono ricercare nella situazione politica ed economica di quel periodo. Quelli furono certamente anni neri per la Romagna e per i suoi abitanti. Il Congresso di Vienna aveva annesso l’intero territorio romagnolo allo Stato Pontificio. Nel giro di quindici anni, ai contadini era stato tolto tutto, fuorché il lavoro. Persino i trebbi, le feste rurali legate al ciclo del raccolto, erano stati proibiti, in quanto sinonimo di scarsa rettitudine. Restava una popolazione povera e infelice, orfana di pane e di svaghi, costretta da una parte a seguire alla lettera le imposizioni dei possidenti e dall’altra le prescrizioni del clero intransigente e bigotto.
Il Boncellino, paese natale di Stefano Pelloni, si trovava in una condizione giuridica particolarmente sfavorevole. Quella piccola frazione di Bagnacavallo, un borgo rustico popolato da un migliaio di braccianti, la maggior parte dei quali alloggiata in capanne di giunchi lungo l’argine del fiume Lamone, era infatti il punto di intersezione di un numero spropositato di giurisdizioni. Il potere era spartito fra le legazioni di Ferrara e Ravenna, i governatorati di Lugo, Bagnacavallo, Russi e Faenza, cui si aggiungevano i comuni di Cotignola e Russi. Inoltre sul territorio erano presenti un discreto numero di presidi militari austriaci che reggevano e controllavano il vicino Granducato di Toscana. A conti fatti gli abitanti del Boncellino si trovavano in una spiacevole condizione di inferiorità numerica rispetto alla quantità di persone che a vario titolo potevano comandarli. E allora si può comprendere come in alcuni di loro, specie tra i giovani, non ancora educati alla rassegnazione, la scorciatoia della malavita apparisse l’unica via per dichiarare il diritto alla vita.
La famiglia Pelloni, della quale Stuvané era il più giovane di dieci figli, non era tra quelle che se la passavano peggio. La sopravvivenza era garantita dal loro piccolo podere sulla riva sinistra del Lamone che possedevano da generazioni. A rimpinguare le entrate ci pensava papà Girolamo affiancando all’attività di coltivatore quella di falegname e soprattutto quella di custode degli argini del Lamone. Faceva anche il traghettatore o, come si diceva a quel tempo, il passatore. Quel titolo sarebbe poi passato a designare suo figlio, che in realtà non diede che occasionalmente il suo contributo come barcaiolo. Ma a Stuvané tutto questo non bastava, oltre all’avventura fine a se stessa le sue passioni erano il vino, il gioco e le donne. Tutto questo in una parola significava soldi.
Il suo passatempo preferito era il gioco della bassetta, un passatempo infido e costoso. Molti contadini avevano dilapidato le loro esigue fortune puntando sulle carte traditrici, tanto che persino il governo si era occupato di quella rovinosa abitudine promulgando pene molto severe. Per quanto riguarda le compagnie femminili, il nostro eroe non andava molto per il sottile, fra le tante si ricorda la sua relazione con la procace Marianna Marangoni, donna sposata di parecchi anni più vecchia di lui, per tutti la Rivalona, in onore alla sua abitudine di concedersi al fortunato di turno sulla riva del Lamone. Purtroppo, o per fortuna, queste frequentazioni gli procurarono una fastidiosissima sifilide che tra evasioni e rapine non ebbe mai modo di curare a dovere e che lo tormentò tutta la vita obbligandolo anche a frequenti periodi di inattività.
Il 28 giugno 1845 il Tribunale di Ferrara condanna il Pelloni a quattro anni di lavori forzati e, mentre viene tradotto ad Ancona per scontare la pena, riesce a sfuggire dalla sorveglianza dei gendarmi dandosi definitivamente alla macchia. Purtroppo per il padre Girolamo, che morì nel 1845 proprio mentre Stefano si guadagnava i gradi di brigante professionista, tutte la sue speranze di riportarlo sulla via della legalità si rivelarono vane.
Fu comunque nel 1874 che molti in Romagna appresero dell’esistenza di un nuovo capo bandito, soprannominato E’ Pasador. Una nota informativa di un parroco della zona di Brisighella segna l’atto di nascita della banda del Passatore: Appresi oggi 4 gennaio 1847 dai Coloni Sussidiari che nei boschi di Zattaglia si è attruppata nuova banda di assassini condotti da un capo che va dicendo a coloro che incontra e rapina di essere evaso dalle carceri pontificie e che si fa chiamare Stuvanì de Passador. A differenza degli altri, Stefano Pelloni aveva l’ardire di firmare le sue malefatte, anche perché sarebbe comunque stato facilmente identificabile a causa di una fucilata ricevuta in faccia in età giovanile che gli aveva lasciato sullo zigomo destro una grossa macchia azzurrognola dovuta ad alcuni grani di polvere da sparo conficcatisi sotto pelle.
Le attività del Passatore andavano dalla semplice rapina ai viandanti alle più complesse e redditizie rapine alle case di ricchi possidenti, vendette su commissione, fino ad arrivare a occupare interi paesi.
L’invasione di Forlimpopoli, per com’è stata orchestrata, rappresenta la sua impresa più celebre. Quella sera, al teatro cittadino, quando si aprì il sipario per dare inizio al secondo atto dello spettacolo, il folto pubblico, che comprendeva una nutrita schiera di ricchi possidenti, al posto degli attori si trovò la banda del Passatore con i fucili spianati. Per tutta la notte i signori presenti furono scortati alle loro abitazioni e depredati dei loro averi. Chi non era andato a teatro venne svegliato e gli fu riservato lo stesso trattamento. Mentre la banda depredava, il Passatore si sollazzava fra osterie e postriboli. Finita la razzia i banditi conclusero la serata con abbondanti libagioni e lunghi giri di danze con le dame più belle. Prima di andarsene elargirono una mancia al capocomico scusandosi per avergli rubato la scena.
La banda del Passatore, come le tante altre che infestavano la Romagna, potette godere di una certa libertà d’azione nel periodo che coincise con i primi moti rivoluzionari. Nel 1848, la sollevazione di varie di varie città fra cui Milano, Venezia e Bologna, la Repubblica Romana e la Prima guerra d’Indipendenza videro gli austriaci costretti ad impegnare le loro forze per riconquistare i territori perduti. Questa situazione favorevole, accompagnata da una fitta rete di fiancheggiatori e di rifugi organizzati, consentiva ai banditi di razziare il territorio praticamente indisturbati. La mancanza di informazioni e lo sbandamento generale consentiva ai briganti anche la possibilità di confondersi con i rivoluzionari. Da non sottovalutare l’armamento in gran parte costituito da moderne doppiette di costruzione francese, che venivano reperite nel vicino Granducato di Toscana, con cui i vecchi catenacci delle guardie pontificie non potevano competere. Tristemente famoso era un fucile quadricanne in dotazione alla banda, arma rivelatasi pesante e poco maneggevole ma che doveva incutere spavento e rassegnazione da parte di chi era sotto tiro. I calessi, che allora erano i mezzi più veloci e versatili, li requisivano direttamente alle loro vittime.
Ripristinata la situazione politica, la lotta alla piaga del banditismo si fece spietata. Fu ingaggiato il colonnello pontificio Michele Zambelli con l’incarico di uccidere il Passatore. Gli furono affidati i migliori soldati disponibili e completa libertà di movimento. Fu istituito il Giudizio Statuario, un vero e proprio tribunale militare creato per piegare definitavene le velleità di sediziosi e briganti.
Il rischio della fucilazione immediata per i briganti e i loro complici, a qualunque titolo, salvo un immediato pentimento e la disponibilità a collaborare, fecero terra bruciata intorno al Passatore. La mattina del 23 marzo 1851 fu denunciata la sua presenza in un capanno sulle rive del Lamone nei dintorni del Boncellino. Vi si era rifugiato insieme con un compagno di avventura per passarvi la notte. Cinque militari della Linea Pontificia e quattro volontari accorsero sul posto e, dopo una breve sparatoria, Stefano Pelloni, il Passatore, cadeva morto con la faccia nell’erba.
Ci furono polemiche per aggiudicarsi il merito dell’uccisione per intascare la cospicua taglia. Intanto il corpo del Passatore, caricato su un carretto, fu trasportato ed esposto nelle città e paesi teatro delle sue gesta. Due giorni dopo raggiunse Bologna già in avanzato stato di decomposizione dove, dopo un sommario quanto dubbioso riconoscimento da parte di un suo fratello, venne sepolto nel cimitero della Certosa di Bologna, in un recinto, all’esterno della zona consacrata, detto il campo dei traditori.
La leggenda del Passatore aveva già cominciato a prendere corpo quando lui era ancora in piena attività. Durante le soste del corteo funebre, accanto ai possidenti plaudenti per l’uccisione del mostro, la stragrande maggioranza del pubblico era composta da braccianti e donne in lacrime. La sua temerarietà, e la capacità di tenere testa alle autorità gli avevano fatto assumere il ruolo di simbolo di riscossa e di speranza per tutto un popolo. Giovanni Pascoli nella sua poesia, Romagna, lo definisce il Passator cortese. La leggenda vuole che rubasse ai ricchi per donare ai poveri. Di certo il danaro ricavato dalle rapine veniva generosamente regalato a tutti coloro dai quali poteva trarre giovamento; quindi case aperte ad asilo, vettovaglie, aiuti e favori pronti e sicuri, avvisi fedeli e così via. Lo stesso Garibaldi ha aiutato ingenuamente a creare il mito proponendosi, in una lettera dall’America, di baciare il piede di quel bravo italiano.
Di cortese, nelle fucilate e nella violenza con cui si accaniva sulle sue vittime, ci dovette essere ben poco. Il professor Leonida Costa, nel suo libro Il rovescio della medaglia, utilizzando i verbali ufficiali relativi alla vicenda di Stefano Pelloni, ha cercato di rimettere un po’ di ordine nella vicenda dimostrando, documenti alla mano, che il Passatore amato e stimato dal popolo non è mai esistito. La storia indica un solo inequivocabile Passatore: quello che si distinse nelle rapine, nelle atroci vendette, nelle torture, negli stupri, nei brutali assassinî, nel vilipendio dei cadaveri.
Ma il tempo sana tutte le ferite. Oggi le iniziative intitolate al Passatore si contano a decine, vanno dalla podistica all’enologia, dalla gastronomia al turismo, dai tornei di scacchi ai francobolli, alle canzoni e via dicendo.
E poi diciamocelo sinceramente, quando troviamo qualcuno capace di farsi rispettare, inconsciamente ci viene in mente qualche nostro conoscente cui una ripassatina farebbe proprio bene. Per fortuna, in genere, l’educazione, la morale o anche solo la diplomazia o il rischio di buscarle ci fa desistere, ed evocare chi potrebbe averlo fatto può essere fonte di pur fuggevole consolazione.
Il Passatore e il brigantaggio romagnolo di metà Ottocento
"Non v'ha mai periodico, specialmente italiano, che non faccia parola della banda di assassini guidata dal Passatore, e dello stato in cui, per fatto di essa, trovansi le Romagne...".
Così esordiva il Giornale di Roma il 22 marzo 1851, in apertura dell'articolo dedicato alle Notizie delle Province.
Stefano Pelloni il Passatore
Ed in effetti la storia di Stefano Pelloni, meglio conosciuto come il Passatore, è così avvincente da averlo consacrato ad un mito che ancora oggi perdura, fonte d'ispirazione per diversi scrittori e studiosi.
Ma prima di addentrarci nelle vicende che lo riguardano, è doverosa una premessa che serva a spiegare come mai il fenomeno del brigantaggio, nel mondo contadino, ebbe il suo picco massimo proprio a metà Ottocento.
Lo storico britannico Eric J. Hobsbawn, padre degli studi sul brigantaggio sociale, definì in modo esaustivo gli elementi principali che lo compongono: è un fenomeno rurale che esiste da secoli, appare in società contadine pre-industriali, si manifesta quando l'equilibrio sociale è sconvolto da carestie, siccità, flagelli naturali e caos politico, quando la regione subisce il dominio di un potere straniero e l'amministrazione statale è troppo inefficiente per prendere misure adeguate per combattere il fenomeno.
L'analisi di Hobsbawm non sbaglia, in quanto le prime forme di banditismo su territorio romagnolo si attestano già dal Cinquecento, a seguito di carestie che colpirono quelle terre e causarono una crescente miseria, al punto che bande di ladri e di affamati si unirono agli ordini di Iacopo del Gallo e Pozzarino del Sesto, importanti banditi dell'epoca.
A metà Ottocento la situazione non era molto più evoluta: all'analfabetismo imperante si aggiungevano epidemie, condizioni di lavoro contadino precarie e con mezzi rudimentali ed un governo incapace di fare fronte alle necessità della popolazione.
Al tempo, la nostra penisola era divisa in tanti stati sotto il controllo dell'Impero Austro-Ungarico. Le Legazioni di Bologna, Ravenna, Forlì e Ferrara in particolare tornarono a fare parte dello Stato Pontificio, uno dei più arretrati e reazionari della penisola.
In questo periodo storico crebbe Stefano Pelloni. Nato a Boncellino di Bagnacavallo il 4/8/1824, egli deve il suo soprannome al mestiere del padre Girolamo, che faceva il traghettatore tra una sponda e l'altra del fiume Lamone. In altri casi viene chiamato Malandri, dal cognome della donna che sposò un suo bisavolo. I genitori aspiravano ad avviarlo alla carriera ecclesiastica, perciò Stefano entrò in seminario. Ma aveva uno spirito troppo ribelle, che mal sopportava la disciplina imposta a chi vuol diventare sacerdote. Perciò abbandonò il collegio religioso e si dedicò a mestieri poco remunerativi: giornaliero di campagna, scarriolante, muratore. Questo gli permise di acquisire contatti e conoscenze nel mondo rurale e forse anche di sviluppare una certa avversione per i possidenti, padroni delle terre coltivate con così tanta fatica da coloni e mezzadri.
Considerando le premesse sopra esposte, quanto, secondo voi, avrà resistito Pelloni prima di dedicarsi ad una vita da brigante?
A poco più di vent'anni, era personaggio ben noto alle forze dell'ordine, non solo nel Ravennate, anche se la tradizione più diffusa vuole che egli si trovò a diventare fuorilegge per una tragica fatalità: durante una festa, trovandosi a diverbio con alcuni conoscenti, forse per motivi politici, egli avrebbe lanciato un sasso contro gli avversari, colpendo però una donna incinta estranea alla rissa e uccidendo lei ed il suo bambino. Venne rinchiuso nelle carceri di Bagnacavallo, ma riuscì ad evadere e si diede alla campagna.
Quest'uomo cominciò a fare parlare di sé nel biennio 1849-1851, quando cioè riuscì ad unificare sotto il proprio comando i membri di altre bande del territorio ed a mettere a segno alcuni dei colpi più importanti:
- a Bagnara il 16 febbraio 1849,
- a Cotignola il 17 gennaio 1850,
- a Castel Guelfo il 27 gennaio 1850,
- a Brisighella il 7 febbraio 1850,
- a Longiano il 28 maggio 1850,
- a Lugo nel Ghetto Ebraico il 2 ottobre 1850,
- a Consandolo il 9 gennaio 1851,
- a Forlimpopoli il 25 gennaio 1851.
Ma non si pensi che tutto questo fosse possibile senza un aiuto: il Passatore godeva infatti di una rete di informatori e protettori, gente che viveva nelle campagne ma anche esponenti delle forze dell'ordine, che venivano ben ricompensati o che erano costretti a collaborare per paura di ritorsioni da parte dei fuorilegge.
Inizialmente, il governo del tempo si dimostrò totalmente incapace di neutralizzare o almeno arginare il fenomeno del brigantaggio: notificazioni, leggi repressive, provvedimenti di disarmo o registrazione dei mezzi di trasporto, non facevano altro che aumentare la fama dei briganti e di farli apparire come gli unici in grado di mettere fine alle ingiustizie della società.
Alla fine del 1849, però, le cose cominciano a cambiare: le autorità romane si avvalsero di un militare che si era fatto le ossa e costruito la carriera, da semplice gendarme a ufficiale, nella lotta contro i briganti delle Marche e del Lazio: Michele Zambelli. Il Comandante dei Carabinieri Pontifici aveva compreso che l'unico modo per colpire i banditi e catturarli era togliere loro gli appoggi: organizzò dunque delle squadre mobili in grado di inseguirli nei loro rifugi e comprese l'importanza dei pentiti, allora chiamati "riveli", che per aver salva la vita, denunciarono i loro compagni permettendone la cattura. Contestualmente, le taglie sulla testa del Passatore e dei membri della sua banda venivano aumentate al punto tale da concorrere con le ricompense ricevute dagli stessi briganti per l'appoggio ricevuto.
La vita di fuorilegge del Passatore andò dunque complicandosi notevolmente. La giustizia gli stava alle calcagna poiché gli informatori della polizia si moltiplicarono ed i rifugi diventarono sempre meno sicuri. Il 21/3/1851, Stefano Pelloni ed alcuni dei suoi si trovavano nella casa di un collaboratore fidato, quando qualcuno li vide e li denunciò. All'arrivo della polizia scoppiò un terribile scontro a fuoco. I banditi riuscirono a scappare, dividendosi. Il 23 marzo, Stefano e Giuseppe Tasselli (detto Giazzolo) si rifugiarono in un casotto di caccia di Villa Spadina di Russi, ma i loro fucili da briganti furono riconosciuti ed essi vennero segnalati. I gendarmi accerchiarono il rifugio ed al termine dello scontro a fuoco che ne seguì, Giazzolo riuscì a fuggire, ma il Passatore cadde a terra morto. Zambelli, una volta arrivato sul luogo, sottrasse il cadavere alle autorità di Russi con un obiettivo preciso: far sfilare la salma sfigurata del Passatore per i paesi della Romagna, affinché la gente potesse constatarne la morte per mano dei gendarmi.
Alla morte del Passatore, sarà Giuseppe Afflitti, detto il Lazzarino, a continuare a terrorizzare tutta la Bassa Romagna con una sua banda fino a quando, catturato, sarà fucilato a Bologna l'8/5/1857.
Dopo la battaglia di Magenta del 4/6/1859, gli Austriaci sconfitti dai Franco-Piemontesi, richiamarono le truppe presenti nello Stato Pontificio ed il 12 giugno abbandonarono Bologna. Dopo 10 anni era finita la dominazione austriaca, ma il Governo Piemontese che sostituirà quello dello Stato Pontificio non migliorerà di molto le condizioni sociali. Bisognerà attendere alcuni decenni per vedere cambiamenti significativi.
Il brigantaggio del Passatore rimarrà nei racconti dei contadini che lo tramanderanno nelle stalle d'inverno alla luce fioca delle lanterne, favorendo il diffondersi di storie e leggende sul conto dell'uomo che si schierò dalla parte dei poveri derubando i ricchi. Nacque così, anche grazie a poeti come Giovanni Pascoli ed a dispetto della realtà che lo descrive come uno spietato criminale, la figura leggendaria del "Passator Cortese".
La povera gente continuò per anni ancora a ritenere il brigantaggio l'unico paladino contro le ingiustizie fino a quando, dopo la seconda metà dell'Ottocento, troverà la possibilità di rivendicare i propri diritti attraverso i grandi movimenti popolari di massa socialisti, repubblicani, anarchici.
Stefano Pelloni venne sepolto in un campo sconsacrato all'esterno del recinto della Certosa di Bologna. Forse qualcuno pensava che in questo modo sarebbe stato rapidamente dimenticato, ma il mito e le gesta del brigante scaltro ed imprendibile, che mise a segno tanti colpi con la sua banda, è arrivato fino a noi come parte integrante della coscienza collettiva ed importante tramite di comprensione del complesso sistema politico che in quel periodo dominava i nostri territori, definendone il tessuto sociale e condizionando le scelte di vita della popolazione.
Villanova di Bagnacavallo
Il Passatore e il brigantaggio romagnolo di metà Ottocento
"Non v'ha mai periodico, specialmente italiano, che non faccia parola della banda di assassini guidata dal Passatore, e dello stato in cui, per fatto di essa, trovansi le Romagne...".
Così esordiva il Giornale di Roma il 22 marzo 1851, in apertura dell'articolo dedicato alle Notizie delle Province.
Stefano Pelloni il Passatore
Ed in effetti la storia di Stefano Pelloni, meglio conosciuto come il Passatore, è così avvincente da averlo consacrato ad un mito che ancora oggi perdura, fonte d'ispirazione per diversi scrittori e studiosi.
Ma prima di addentrarci nelle vicende che lo riguardano, è doverosa una premessa che serva a spiegare come mai il fenomeno del brigantaggio, nel mondo contadino, ebbe il suo picco massimo proprio a metà Ottocento.
Lo storico britannico Eric J. Hobsbawn, padre degli studi sul brigantaggio sociale, definì in modo esaustivo gli elementi principali che lo compongono: è un fenomeno rurale che esiste da secoli, appare in società contadine pre-industriali, si manifesta quando l'equilibrio sociale è sconvolto da carestie, siccità, flagelli naturali e caos politico, quando la regione subisce il dominio di un potere straniero e l'amministrazione statale è troppo inefficiente per prendere misure adeguate per combattere il fenomeno.
L'analisi di Hobsbawm non sbaglia, in quanto le prime forme di banditismo su territorio romagnolo si attestano già dal Cinquecento, a seguito di carestie che colpirono quelle terre e causarono una crescente miseria, al punto che bande di ladri e di affamati si unirono agli ordini di Iacopo del Gallo e Pozzarino del Sesto, importanti banditi dell'epoca.
A metà Ottocento la situazione non era molto più evoluta: all'analfabetismo imperante si aggiungevano epidemie, condizioni di lavoro contadino precarie e con mezzi rudimentali ed un governo incapace di fare fronte alle necessità della popolazione.
Al tempo, la nostra penisola era divisa in tanti stati sotto il controllo dell'Impero Austro-Ungarico. Le Legazioni di Bologna, Ravenna, Forlì e Ferrara in particolare tornarono a fare parte dello Stato Pontificio, uno dei più arretrati e reazionari della penisola.
In questo periodo storico crebbe Stefano Pelloni. Nato a Boncellino di Bagnacavallo il 4/8/1824, egli deve il suo soprannome al mestiere del padre Girolamo, che faceva il traghettatore tra una sponda e l'altra del fiume Lamone. In altri casi viene chiamato Malandri, dal cognome della donna che sposò un suo bisavolo. I genitori aspiravano ad avviarlo alla carriera ecclesiastica, perciò Stefano entrò in seminario. Ma aveva uno spirito troppo ribelle, che mal sopportava la disciplina imposta a chi vuol diventare sacerdote. Perciò abbandonò il collegio religioso e si dedicò a mestieri poco remunerativi: giornaliero di campagna, scarriolante, muratore. Questo gli permise di acquisire contatti e conoscenze nel mondo rurale e forse anche di sviluppare una certa avversione per i possidenti, padroni delle terre coltivate con così tanta fatica da coloni e mezzadri.
Considerando le premesse sopra esposte, quanto, secondo voi, avrà resistito Pelloni prima di dedicarsi ad una vita da brigante?
A poco più di vent'anni, era personaggio ben noto alle forze dell'ordine, non solo nel Ravennate, anche se la tradizione più diffusa vuole che egli si trovò a diventare fuorilegge per una tragica fatalità: durante una festa, trovandosi a diverbio con alcuni conoscenti, forse per motivi politici, egli avrebbe lanciato un sasso contro gli avversari, colpendo però una donna incinta estranea alla rissa e uccidendo lei ed il suo bambino. Venne rinchiuso nelle carceri di Bagnacavallo, ma riuscì ad evadere e si diede alla campagna.
Quest'uomo cominciò a fare parlare di sé nel biennio 1849-1851, quando cioè riuscì ad unificare sotto il proprio comando i membri di altre bande del territorio ed a mettere a segno alcuni dei colpi più importanti:
- a Bagnara il 16 febbraio 1849,
- a Cotignola il 17 gennaio 1850,
- a Castel Guelfo il 27 gennaio 1850,
- a Brisighella il 7 febbraio 1850,
- a Longiano il 28 maggio 1850,
- a Lugo nel Ghetto Ebraico il 2 ottobre 1850,
- a Consandolo il 9 gennaio 1851,
- a Forlimpopoli il 25 gennaio 1851.
Ma non si pensi che tutto questo fosse possibile senza un aiuto: il Passatore godeva infatti di una rete di informatori e protettori, gente che viveva nelle campagne ma anche esponenti delle forze dell'ordine, che venivano ben ricompensati o che erano costretti a collaborare per paura di ritorsioni da parte dei fuorilegge.
Inizialmente, il governo del tempo si dimostrò totalmente incapace di neutralizzare o almeno arginare il fenomeno del brigantaggio: notificazioni, leggi repressive, provvedimenti di disarmo o registrazione dei mezzi di trasporto, non facevano altro che aumentare la fama dei briganti e di farli apparire come gli unici in grado di mettere fine alle ingiustizie della società.
Alla fine del 1849, però, le cose cominciano a cambiare: le autorità romane si avvalsero di un militare che si era fatto le ossa e costruito la carriera, da semplice gendarme a ufficiale, nella lotta contro i briganti delle Marche e del Lazio: Michele Zambelli. Il Comandante dei Carabinieri Pontifici aveva compreso che l'unico modo per colpire i banditi e catturarli era togliere loro gli appoggi: organizzò dunque delle squadre mobili in grado di inseguirli nei loro rifugi e comprese l'importanza dei pentiti, allora chiamati "riveli", che per aver salva la vita, denunciarono i loro compagni permettendone la cattura. Contestualmente, le taglie sulla testa del Passatore e dei membri della sua banda venivano aumentate al punto tale da concorrere con le ricompense ricevute dagli stessi briganti per l'appoggio ricevuto.
La vita di fuorilegge del Passatore andò dunque complicandosi notevolmente. La giustizia gli stava alle calcagna poiché gli informatori della polizia si moltiplicarono ed i rifugi diventarono sempre meno sicuri. Il 21/3/1851, Stefano Pelloni ed alcuni dei suoi si trovavano nella casa di un collaboratore fidato, quando qualcuno li vide e li denunciò. All'arrivo della polizia scoppiò un terribile scontro a fuoco. I banditi riuscirono a scappare, dividendosi. Il 23 marzo, Stefano e Giuseppe Tasselli (detto Giazzolo) si rifugiarono in un casotto di caccia di Villa Spadina di Russi, ma i loro fucili da briganti furono riconosciuti ed essi vennero segnalati. I gendarmi accerchiarono il rifugio ed al termine dello scontro a fuoco che ne seguì, Giazzolo riuscì a fuggire, ma il Passatore cadde a terra morto. Zambelli, una volta arrivato sul luogo, sottrasse il cadavere alle autorità di Russi con un obiettivo preciso: far sfilare la salma sfigurata del Passatore per i paesi della Romagna, affinché la gente potesse constatarne la morte per mano dei gendarmi.
Alla morte del Passatore, sarà Giuseppe Afflitti, detto il Lazzarino, a continuare a terrorizzare tutta la Bassa Romagna con una sua banda fino a quando, catturato, sarà fucilato a Bologna l'8/5/1857.
Dopo la battaglia di Magenta del 4/6/1859, gli Austriaci sconfitti dai Franco-Piemontesi, richiamarono le truppe presenti nello Stato Pontificio ed il 12 giugno abbandonarono Bologna. Dopo 10 anni era finita la dominazione austriaca, ma il Governo Piemontese che sostituirà quello dello Stato Pontificio non migliorerà di molto le condizioni sociali. Bisognerà attendere alcuni decenni per vedere cambiamenti significativi.
Il brigantaggio del Passatore rimarrà nei racconti dei contadini che lo tramanderanno nelle stalle d'inverno alla luce fioca delle lanterne, favorendo il diffondersi di storie e leggende sul conto dell'uomo che si schierò dalla parte dei poveri derubando i ricchi. Nacque così, anche grazie a poeti come Giovanni Pascoli ed a dispetto della realtà che lo descrive come uno spietato criminale, la figura leggendaria del "Passator Cortese".
La povera gente continuò per anni ancora a ritenere il brigantaggio l'unico paladino contro le ingiustizie fino a quando, dopo la seconda metà dell'Ottocento, troverà la possibilità di rivendicare i propri diritti attraverso i grandi movimenti popolari di massa socialisti, repubblicani, anarchici.
Stefano Pelloni venne sepolto in un campo sconsacrato all'esterno del recinto della Certosa di Bologna. Forse qualcuno pensava che in questo modo sarebbe stato rapidamente dimenticato, ma il mito e le gesta del brigante scaltro ed imprendibile, che mise a segno tanti colpi con la sua banda, è arrivato fino a noi come parte integrante della coscienza collettiva ed importante tramite di comprensione del complesso sistema politico che in quel periodo dominava i nostri territori, definendone il tessuto sociale e condizionando le scelte di vita della popolazione.
L'area romagnola a metà del secolo XIX risultava afflitta da bande di briganti che secondo il Giornale di Roma "invadevano le case, rapinavano i viandanti e grassavano ognora diligenze e corrieri, estorcendo migliaia e migliaia di scudi", in risposta a queste azioni le autorità reagirono con una colonna mobile di gendarmeria effettuando arresti e processi con giudizio statario; in due soli processi svoltisi a Faenza e Imola furono condannate e fucilate 82 persone, 10 ebbero la pena capitale commutata a carcere e altri 13 pene detentive fino al carcere a vita e, nel marzo 1851 un centinaio di persone erano arrestate in attesa di simili processi a Bologna.[74]
Il più noto fra i briganti romagnoli fu Stefano Pelloni, detto il Passatore, soprattutto attivo in Romagna nella prima metà del secolo XIX, in particolare nei tre anni successivi ai moti rivoluzionari del 1848. Delle sue gesta, quelle più famose furono le occupazioni a banda armata di interi paesi Bagnara di Romagna (16 febbraio 1849), Cotignola (17 gennaio 1850), Castel Guelfo (27 gennaio 1850), Brisighella (7 febbraio 1850), Longiano (28 maggio 1850), Consandolo (9 gennaio 1851) e Forlimpopoli (sabato, 25 gennaio 1851), durante le quali metteva a sacco le abitazioni dei più ricchi, che venivano torturati e seviziati per farsi rivelare i nascondigli degli scudi e delle gioie, mentre le donne venivano stuprate. Finì ucciso in uno scontro con le truppe papaline a Russi nel 1851. Nonostante la sua ferocia, seppe dare di sé un'immagine di combattente contro i soprusi dei ricchi e potenti; tale immagine fu poi divulgata da una certa cultura popolare romagnola, che esagerò nel descrivere Pelloni come un giustiziere difensore di oppressi e miserabili; arrivando a definirlo "Passator cortese" e utilizzandone persino il ritratto come marchio di vini autoctoni.[75]
8 yerel halk öneriyor
Predappio
L'area romagnola a metà del secolo XIX risultava afflitta da bande di briganti che secondo il Giornale di Roma "invadevano le case, rapinavano i viandanti e grassavano ognora diligenze e corrieri, estorcendo migliaia e migliaia di scudi", in risposta a queste azioni le autorità reagirono con una colonna mobile di gendarmeria effettuando arresti e processi con giudizio statario; in due soli processi svoltisi a Faenza e Imola furono condannate e fucilate 82 persone, 10 ebbero la pena capitale commutata a carcere e altri 13 pene detentive fino al carcere a vita e, nel marzo 1851 un centinaio di persone erano arrestate in attesa di simili processi a Bologna.[74]
Il più noto fra i briganti romagnoli fu Stefano Pelloni, detto il Passatore, soprattutto attivo in Romagna nella prima metà del secolo XIX, in particolare nei tre anni successivi ai moti rivoluzionari del 1848. Delle sue gesta, quelle più famose furono le occupazioni a banda armata di interi paesi Bagnara di Romagna (16 febbraio 1849), Cotignola (17 gennaio 1850), Castel Guelfo (27 gennaio 1850), Brisighella (7 febbraio 1850), Longiano (28 maggio 1850), Consandolo (9 gennaio 1851) e Forlimpopoli (sabato, 25 gennaio 1851), durante le quali metteva a sacco le abitazioni dei più ricchi, che venivano torturati e seviziati per farsi rivelare i nascondigli degli scudi e delle gioie, mentre le donne venivano stuprate. Finì ucciso in uno scontro con le truppe papaline a Russi nel 1851. Nonostante la sua ferocia, seppe dare di sé un'immagine di combattente contro i soprusi dei ricchi e potenti; tale immagine fu poi divulgata da una certa cultura popolare romagnola, che esagerò nel descrivere Pelloni come un giustiziere difensore di oppressi e miserabili; arrivando a definirlo "Passator cortese" e utilizzandone persino il ritratto come marchio di vini autoctoni.[75]